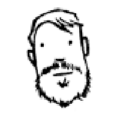Continuo il tentativo di far conoscere i ricercatori del nostro territorio sottraendoli al cono d’ombra in cui paiono relegati. Questa settimana Luca Fabbri.
 Nato nel 1978, Luca Fabbri vive a Cotignola fino a 24 anni.
Nato nel 1978, Luca Fabbri vive a Cotignola fino a 24 anni.
Diploma scientifico a Lugo al liceo Ricci Curbastro, poi laurea e dottorato in Fisica Teorica a Bologna col professor Bergia.
Durante il dottorato passa molto tempo all’università di Montréal, in Canada, dove conosce Marie-Hélène, anche lei ricercatrice, che diventerà sua moglie.
Dopo il dottorato passa da un post-doc all’altro, ma sempre portando avanti la sua ricerca in grande autonomia.
Dopo al Canada, con Marie-Hélène vanno Germania per 4 anni e ora in Francia, a Grenoble, dove lei ha un posto permanente per lavorare al CERN.
Dove stanno ora non ci sono grandi prospettive per lui, e ciò lo pone di fronte alla scelta di passare lunghi periodo lontano oppure lasciare la ricerca.
Ama passeggiare in montagna, la fantascienza, la musica classica e la metal, e ha imparato per necessità a fare i cappelletti fatti a mano col ragù alla bolognese (posso testimoniare).
Gravità e torsione.
Quella che, secondo me, è la più brillante idea di Einstein non è che il tempo sia un’altra dimensione, come lo spazio, in un unico spazio-tempo, ma il fatto lo spazio-tempo sia curvo, e che la sua curvatura sia il campo gravitazionale.
Spiegare come questo sia possibile non è difficile, fatta una premessa: uno dei postulati più discussi in geometria è il quinto postulato di Euclide, quello che dice che due rette parallele non si incontrano mai; in realtà il fatto che rette parallele non si incontrino mai non è una caratteristica assoluta dello spazio in cui viviamo, ma semplicemente la definizione di spazio piatto, mentre invece in generale sono possibili anche altri tipi di spazi. E in certi spazi curvi le rette parallele si incontrano: prendete una superficie sferica, come la superficie terrestre, sulla quale le rette parallele sono gli archi di cerchio massimo, come per esempio tutti i meridiani, ed è chiaro che questi si intersecano, per esempio ai poli. Quindi, in spazi curvi rette parallele si possono incontrare.
Ora, immaginiamo due masse e lanciamole nello spazio interstellare in modo tale che abbiano traiettorie inizialmente parallele: quello che succede è che, però, dopo un po’ le traiettorie inizieranno ad avvicinarsi e le particelle si incontreranno. La cosa può essere spiegata in due modi: uno, quello tradizionale, è che ciascuna delle due masse crea un piccolo campo gravitazionale in cui l’altra è immersa, ne risente l’influenza ed inizia a rispondere a tale campo avvicinandosi all’altra; l’altro, di Einstein, è che ciascuna delle due masse incurvi lo spazio-tempo in cui l’altra si trova, e come abbiamo appena visto anche se le traiettorie delle particelle sono parallele all’inizio, queste parallele sono in uno spazio curvo e finiranno per incontrarsi. Matematicamente e sperimentalmente si può dimostrare che questa analogia nelle descrizioni si applica non solo a questo esempio specifico, ma in generale; dunque non è in alcun modo possibile distinguere fra gravità e curvatura dello spazio-tempo. Questa, secondo me, è la più brillante idea di Einstein.
Quello che però Einstein aveva lasciato indietro è il fatto che, nella matematica più generale che uno possa usare per descrivere la relatività, lo spazio-tempo non solo ha curvatura, ma anche torsione.
Per capire grosso modo cos’è la torsione, riprendiamo l’esempio di prima, con una sola particella ma non più puntiforme, bensì dotata di una certa estensione, tipo una palla, e che quindi possa ruotare su se stessa: se lanciamo questa palla in uno spazio curvo, come abbiamo già visto, la sua traiettoria curverà; ma se lo spazio ha anche torsione, quello che succede è che la particella inizia a ruotare su sé stessa. Einstein sia perdonato per aver tralasciato questo concetto, ma aveva ragioni forti, e cioè che allora, nel 1916, si pensava davvero che tutte le particelle fossero puntiformi; ma ora sappiamo che non è così, e la torsione, cioè la possibilità di ruotare su sé stesse, in qualche modo, è importante. La cosa che succede, è che in spazi-tempi curvi con torsione queste particelle hanno dei moti molto più difficili da studiare di quelli in cui la torsione non c’è, e quindi capire cosa le particelle elementari facciano in questo caso generale è un problema aperto in fisica al giorno d’oggi.
E questo è quello che la mia ricerca mi porta a (provare di) risolvere.
di Luca Fabbri