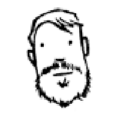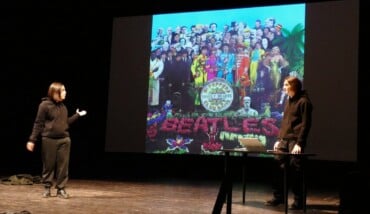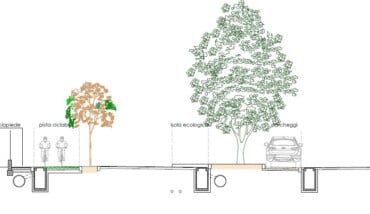Il 25 Aprile l’Italia festeggia la Liberazione: la fine della guerra e la cacciata dell’invasore, la fine di una dittatura lunga venti anni, la fine della vergogna delle leggi razziali.
Il 25 Aprile l’Italia festeggia la Liberazione: la fine della guerra e la cacciata dell’invasore, la fine di una dittatura lunga venti anni, la fine della vergogna delle leggi razziali.
Leggi razziali che in tutta Europa hanno portato alla persecuzione di milioni di ebrei e di altre minoranze.
Che hanno prodotto milioni di morti, con la morte che si è insinuata prepotentemente anche tra i sopravvissuti.
Di fronte a questa disumana tragedia, tutto sembra svanire.
Ma assieme a questi, in quegli anni sono morte anche la democrazia, il rispetto e la Cultura.
In particolare, le leggi razziali tra le altre cose hanno ucciso anche la Scienza in Europa e soprattutto in Italia.
Introdotte in Italia nel 1938 con una serie di documenti e decreti a partire dal “Manifesto sulla Razza” del 15 luglio, cui fa seguito il regio decreto “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista” del 5 settembre, hanno costretto all’esilio, alla fuga o all’isolamento alcune tra le menti più luminose del nostro Paese.
Molti degli scienziati ed intellettuali ebrei colpiti dal provvedimento del 5 settembre emigrano negli Stati Uniti. Tra loro ricordiamo Emilio Segrè (Nobel per la Fisica nel 1959), Bruno Pontecorvo (per le sue idee comuniste scappa poi in URSS nel 1950), Bruno Rossi (premio Wolf fisica 1987), Ugo Lombroso, Giorgio Levi Della Vida, Mario Castelnuovo-Tedesco, Camillo Artom, Ugo Fano, Roberto Fano, Salvatore Luria, (poi Nobel per la Medicina nel 1969), Piero Foà, Luigi Jacchia, Guido Fubini, Franco Modigliani (Nobel Economia 1985).
Altri troveranno rifugio in Gran Bretagna: Arnaldo Momigliano, Uberto Limentani, Guido Pontecorvo (fratello di Bruno e del regista Gillo); in Palestina: Umberto Cassuto, Giulio Racah; o in Sud America: Carlo Foà, Amedeo Herlitzka, Beppo Levi.
Con loro lasceranno l’Italia anche Enrico Fermi e Luigi Bogliolo, le cui mogli erano ebree.
I suoceri di Fermi furono deportati in campo di concentramento.
Fermi, dopo essersi recato a Stoccolma nel dicembre del 1938 per ricevere il Premio Nobel per la Fisica “per la sua identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti” fa rotta con la famiglia verso gli Stati Uniti, dove la Columbia University di New York lo ha invitato per una serie di lezioni, e non rintrerà più in Italia. Aveva solo 37 anni.
Con la fuga di Fermi si dissolve la punta di diamante della ricerca scientifica italiana di quegli anni: i famosi Ragazzi di via Panisperna a Roma, grazie ai quali negli anni ’30 Roma fu al centro del mondo per le straordinarie scoperte che portarono poi al Nobel attribuito a Fermi.
Il gruppo, voluto dal fisico e senatore Orso Mario Corbino a partire dal ’29, e guidato dallo straordinario scienziato che fu Enrico Fermi, era composto da giovanissimi. Per il settore sperimentale, Fermi poté contare su Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo e il chimico Oscar D’Agostino; in campo teorico, si distingueva la figura di Ettore Majorana.
A parte Majorana, scomparso nel 1938 in circostanze misteriose, rimasero in Italia solo Amaldi (che contriburà in seguito alla costituzione del CERN) e D’Agostino.
Chi decide di rimanere in Italia è comunque costretto ad abbandonare la cattedra.
Tra questi: Tullio Ascarelli, Walter Bigiavi, Mario Camis, Federico Cammeo, Alessandro Della Seta, Donato Donati, Mario Donati, Marco Fanno, Gino Fano, Federigo Enriques, Giuseppe Levi, Benvenuto Terracini, Tullio Levi-Civita, Rodolfo Mondolfo, Adolfo Ravà, Attilio Momigliano, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, Tullio Terni e Mario Fubini. E molti molti altri.
Molte le dimissioni illustri da istituzioni scientifiche italiane.
Uno per tutti: Albert Einstein, allora membro dell’Accademia dei Lincei, che si trova negli USA dal ’33, anno in cui Hitler prende il potere in Germania.
Durante gli anni trenta fu condotta una campagna che etichettò i lavori di Einstein come “fisica ebraica”, in contrasto con la “fisica tedesca” o “ariana”. Nel ’44 a Rignano sull’Arno la moglie e le figlie di suo cugino furono uccise da un reparto delle SS, verosimilmente come rappresaglia contro di lui; la strage, cui seguì il suicidio del cugino, colpì Einstein duramente. Egli già nel ’40 aveva rinunciato alla cittadinanza tedesca e svizzera diventando cittadino statunitense e non rientrerà più in Europa fino alla morte avvenuta nel ’55.
Insieme ad Einstein, migliaia di scienziati europei prendono la rotta per gli Stati Uniti, i quali si vedono “regalare” le migliori menti europee e sulle quali fonderanno un impero di Sapere e Conoscenza, portatore di sviluppo e benessere, che è stato dominatore mondiale incontrastato fino ai nostri giorni.
Mentre nel resto d’Europa molti sforzi si sono fatti nei decenni per ridurre questa distanza con gli Stati Uniti, e con ottimi risultati, in Italia stiamo ancora oggi pagando le conseguenze di quella devastazione, complice certo anche un diffuso e prolungato disinteresse rispetto alla Scienza e alla Ricerca da parte della politica e dei governi che si sono succeduti nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi.
Anche oggi pur senza leggi razziali migliaia di giovani laureati e ricercatori se ne vanno ogni anno dall’Italia alla ricerca di un luogo dove sentirsi una risorsa e non un peso, un luogo che riconosca e valorizzi il valore del Sapere e della Scienza.
“Ognuno ha le sue guerre da combattere”, mi ripeteva sempre Ida Camanzi, staffetta partigiana col nome Ilonka, scomparsa lo scorso luglio.
Ecco, questo per me è il senso che deve avere il 25 Aprile oggi come ogni anno: la memoria per ciò che è avvenuto, da cui attingere la consapevolezza e la responsabilità per le guerre che noi siamo tenuti a combattere oggi.
Per imparare da loro a non tirarci indietro.