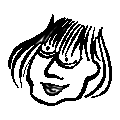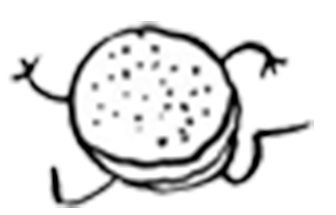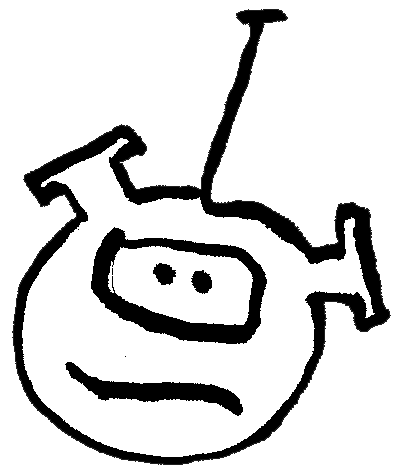«Uno dei totalitarismi più raffinati del nostro tempo (…) è l’obbligo della chiarezza, il disprezzo per lo stato del non-capisco, la generale condivisa svalutazione dell’esperienza dell’incomprensione e dei suoi effetti segreti che spingono a scelte decisive nella nostra vita. Il culto della chiarezza, che servì a illuminare le menti, oggi contribuisce a ottenebrarle. (…) La finzione della comprensibilità rassicura», scriveva Eugenio Barba nel 2011.
«Uno dei totalitarismi più raffinati del nostro tempo (…) è l’obbligo della chiarezza, il disprezzo per lo stato del non-capisco, la generale condivisa svalutazione dell’esperienza dell’incomprensione e dei suoi effetti segreti che spingono a scelte decisive nella nostra vita. Il culto della chiarezza, che servì a illuminare le menti, oggi contribuisce a ottenebrarle. (…) La finzione della comprensibilità rassicura», scriveva Eugenio Barba nel 2011.
Ogni volta che vedo spettacoli come Morte di Zarathustra di Teatro Akropolis, ripeto a me stesso le parole di Barba. Da bravo spettatore occidentale post-illuminista, anche a me fa paura l’incomprensibile, mi infastidisce. Cerco “rassicurazioni” tentando di agganciare ciò che vedo a un concetto, ad uno schema esplicativo. Ma Barba insegna che è necessario abbandonare questo totalitarismo: dunque, cerchiamo di accettare l’incomprensibile e proviamo a viverlo sulla scena.
Da critico, la questione è più complessa. Quello che Barba definisce “totalitarismo” quando applicato alla società intera, per il critico è una necessità, un pungolo deontologico. Rassegnarsi e ammettere che ciò che si è visto sulla scena non significa nulla o non è comprensibile, non è una strada percorribile. Il critico non può fare spallucce. La riflessione impone linearità; l’argomentazione necessita dialettica; la chiarezza non è totalitarismo, ma utopia, con buona pace di Barba.
Finito Morte di Zarathustra ho avuto la netta impressione di non aver capito nulla. Quaranta minuti di performance fisica, a metà strada fra teatro e danza, movimenti e figure piene di pathos da parte dei bravi Luca Donatiello, Francesca Melis, Alessandro Romi e Felice Siciliano. Nessuna storia, nessuna narrazione a rassicurare lo spettatore. Solo musica, grida e rappresentazioni fugaci, ora giocose, ora erotiche, ora violente. Ma ecco che alla fine la Melis regala una manciata di versi dal sapore nicciano, come a giustificare in extremis la scelta del titolo.
Questo il materiale di partenza, «l’esito sulla scena», come viene detto nel programma di sala, «di un percorso di ricerca sulla nascita della tragedia, ispirato a Nietzsche e alle sue scoperte sul coro ditirambico», che ha portato anche alla pubblicazione di un libro omonimo di questo spettacolo, scritto dai registi Clemente Tafuri e David Beronio.
Lo spettacolo è dunque l’espressione pratica delle idee contenute nel libro. Primo errore, fatale, per la fruizione di Morte di Zarathustra: un’opera che ha bisogno di spiegazione e di teoria per essere compresa è già un mezzo fallimento. Ogni opera estetica deve mirare all’autosufficienza per non diventare didascalia o commento.
Il secondo errore, squisitamente teorico, lo rintraccio nelle pagine del libro, un affondo denso, ben scritto ma spesso un po’ troppo oscuro, sul coro ditirambico e sulla sua “funzione” artistica, che cita Kant, Bachtin, Kerényi e Colli.
Cerco di riassumere senza semplificare. Secondo Tafuri e Beronio, il coro ditirambico è stata l’ultima forma d’arte capace di far sentire l’uomo parte non mediata del mondo; con la nascita della tragedia classica, niccianamente, l’apollineo ha preso il sopravvento sul dionisiaco, la filosofia sulla sapienza, il personaggio sul coro. Nel coro ditirambico non abbiamo personaggi, ma attori in azione, che accettano ed esprimono l’assurdità dell’esistenza senza rimanerne schiacciati: «un’esperienza limite di natura estetica» che ha anche un portato conoscitivo. Il partecipante del coro esperisce una verità – anche se, come per i misteri eleusini, questa verità è incomunicabile ed inesprimibile.
Ma dunque, questo Morte di Zarathustra, che cos’è? Un saggio di storia del teatro? Un tentativo fuori tempo massimo di riportare in vita il coro ditirambico – sulla base di una ricostruzione, quella nicciana, che, sia detto solo per inciso, vale quanto quella di ogni altro? No. Si tratta di «intuire la natura del sentimento tragico», scrivono gli autori, per arrivare «a una nuova consapevolezza dell’opera d’arte».
Un discorso che può sicuramente valere per l’attore, nel privato della sua esperienza, ma non per il pubblico. E infatti per il coro ditirambico, esattamente come per le feste carnevalesche medievali: «la partecipazione alla festa riguarda sia chi agisce sia chi assiste e, non delineandosi quindi un ruolo passivo, la stessa consapevolezza e la stessa intenzione sono condivise da tutti».
I confini fra pubblico e attore si perdono nell’azione del coro ditirambico, si perde l’individuo che, estaticamente, si sente di nuovo parte del mondo, sussunto in un’unità superiore. Grazie a questa esperienza conoscitiva: «chi lotta e danza in questo coro è chiamato a destrutturare ogni suo ruolo, anche quello di artista».
Se queste sono le premesse, c’è qualcosa che non va nello svolgimento. È evidente che ingabbiare il coro ditirambico in una scena tradizionale, per un pubblico passivo, arricchendolo di regìa e logos firmate da artisti tradizionali, facendo pagare un biglietto tradizionale è, nelle migliore delle ipotesi, cattiva fede, nella peggiore, suprema leggerezza. O al gioco partecipiamo tutti, o assistiamo a un esercizio di stile privato di contenuto.
Un percorso come quello ideato da Tafuri e Beronio può funzionare a porte chiuse, in laboratori privati, come per i misteri eleusini, nell’intimo di ogni partecipante; ma portato “in scena”, questo esercizio ultra-intellettuale si rovescia nella sua scimmiottatura, a tutto scapito di un pubblico che, legittimamente disorientato dalla totale mancanza di punti di riferimento, non si porta a casa nulla. Altroché esperienza conoscitiva.
Morte di Zarathustra
drammaturgia e regìa di Clemente Tafuri e David Beronio
con Luca Donatiello, Francesca Melis, Alessandro Romi e Felice Siciliano
produzione Teatro Akropolis
Visto al Teatro Rasi il 16 gennaio 2017