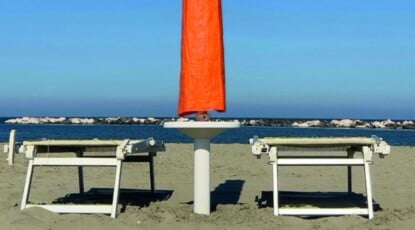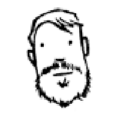«Ma in teatro fanno sempre Traviata e Bohème! Basta, è ora di cambiare? Ce ne saranno pur altre di opere?» Queste sono affermazioni da melomani (da strapazzo?) che forse lasciano un po’ il tempo che trovano, ma che, per certi versi, sono un indicatore di un’esigenza di una certa parte di pubblico.
È, in effetti, abbastanza vero che nei vari cartelloni (che essi siano operistici, sacri o concertistico-sinfonici) ci siano composizioni ricorrenti. Per gli appassionati di musica è facile, infatti, aver la possibilità di ascoltare, oltre alle due opere sopra menzionate, le Quattro Stagioni, la sinfonia n. 40, la Quinta, l’Imperatore, l’Italiana, Elisir d’amore, Tosca. Bastano questi titoli “popolari” per capire subito di che cosa si sta parlando, senza bisogno di citare i compositori né dare qualche riferimento catalogico. Ciò è dovuto, appunto, a una incredibile celebrità di questi brani, dovuta non solo alla loro bellezza ed iconicità, ma anche a una maggior frequenza di rappresentazione nelle sale da concerto ed è su quest’ultimo aspetto che ci si può interrogare.
Il primo motivo è semplice e non ha nessun coinvolgimento con la qualità musicale, bensì con l’aspetto più commerciale; è, infatti, abbastanza chiaro che un Rigoletto attirerà maggior pubblico rispetto alla Furba e lo sciocco o che il Rach3 sia più appetibile del Concerto in do maggiore di Muzio Clementi e, come è logico, più pubblico porta a uno sbigliettamento maggiore e quindi a un incasso più goloso.
Il secondo motivo, invece, è squisitamente musicale, infatti, molto spesso queste composizioni di grande fama sono dotate di un’eccellente qualità musicale, sia dal punto di vista strutturale-armonico, sia dal punto di vista tematico.
È, quindi, giusto insistere nel proporre cose già note al grande pubblico perché ciò permette di offrire pagine di spessore assoluto, tuttavia, è importante non fossilizzarsi solo su questi titoli, ma di aprire le porte anche a primizie, magari dimenticate, che permettono di avere un contesto musicale più ampio. È bello, e importante, che si conoscano anche gli autori minori affinché sia più grande il godimento nell’ascoltare la musica dei maggiori.
C’è, però, un azzarto. “Riesumare” musica dimenticata non sempre ha esiti felici e ciò dipende sia dagli esecutori sia dalla qualità della musica stessa. Ed è dietro l’angolo il rischio di trovarsi di fianco a qualcuno che sussurra a denti stretti «se non l’hanno suonata per 300 anni un motivo ci sarà».