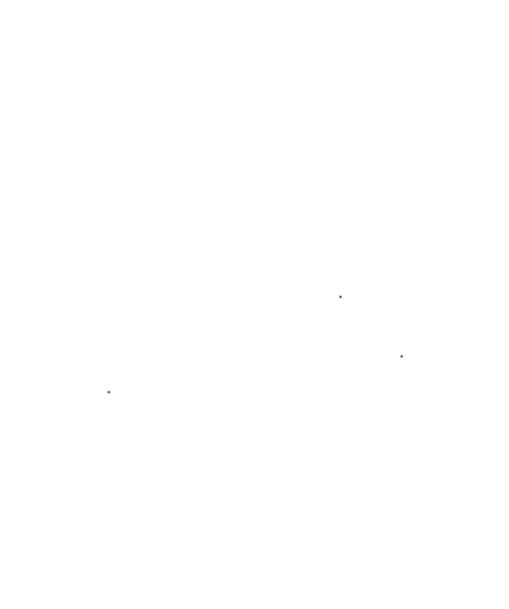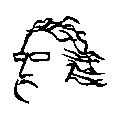Il richiamo era inconfondibile ed è ancora impresso nella memoria di tanti. Il grido «coccobello», con l’ultima “o” strascicata e la cadenza che arrivava da lontano, rappresentava un piccolo sollievo dalla calura estiva. Stesi sotto l’ombrellone in riva al mare, i turisti aspettavano il passaggio dei venditori che proponevano un rinfrescante morso del frutto tropicale per pochi spiccioli. Cesto di vimini in una mano, innaffiatoio nell’altra per irrigare i triangoli di polpa bianca durante le soste, gli ambulanti percorrevano la spiaggia avanti e indietro per tutta la stagione, facendo parte a pieno titolo dell’immaginario vacanziero romagnolo.
Oggi quel richiamo non si sente quasi più. L’uomo che si racconta essere stato il suo inventore, il napoletano Salvatore Manfredonia, se n’è andato a 80 anni alla fine dell’estate 2023. Aveva iniziato a vendere il cocco in spiaggia negli anni ’60 tra Rimini e Riccione. Ma quella pratica, per quanto potesse sembrare innocua, aveva poco di regolare. Indagini partite nel 2010 da Cesenatico hanno appurato l’esistenza di un racket del cocco, che nel 2021 hanno portato a condanne dai tre ai cinque anni e mezzo alla famiglia campana che controllava le vendite in tutta la riviera romagnola. Le noci di cocco venivano stoccate, tagliate e smistate in due basi operative a Cervia e Riccione, senza rispettare le norme igienico-sanitarie.
Il fatto era stato raccontato anche dalla trasmissione “Le Iene”, con l’inviato Filippo Roma minacciato di morte dopo essersi finto un venditore di cocco tra gli ombrelloni di Rimini. Il servizio si trova ancora online, con l’intervista a un giovane Andrea Gnassi al suo primo anno da sindaco di Rimini. Vendere il cocco in spiaggia di propria iniziativa significava essere aggrediti dagli ambulanti e dai loro capi che assegnavano le zone di pertinenza ai propri uomini. Ora che l’organizzazione è stata smantellata e i controlli anti-abusivismo delle forze dell’ordine sono frequenti, il «coccobello» sulla spiaggia è una rarità, ma i pochi venditori che sfidano la legge continuano a imitare lo stesso richiamo.
Al di là degli illeciti, resta però la nostalgia per quella modalità di consumo di un frutto molto amato dagli italiani. Il cocco è stato una delle prime specie tropicali ad arrivare nel nostro paese: essendo in grado di mantenersi per cinque mesi senza ammaccarsi né perdere la sua freschezza, poteva resistere nei lunghi viaggi via mare. I primi europei a conoscerlo furono i marinai dell’esploratore portoghese Vasco Da Gama (1469-1524), che lo battezzarono «coco» perché ricordava una testa. La pianta è originaria dell’Indonesia ma si è diffusa sin dall’antichità nelle isole del Pacifico, perché le palme – che possono raggiungere i 30 metri di altezza – crescono facilmente negli ambienti aridi e salmastri come la spiaggia, regalando grandi noci da cui si può ricavare olio, farina, latte e polpa, oltre a utilizzare i gusci, le foglie e la legna.
Una pianta di cocco può vivere per un secolo e generare 150 frutti all’anno. Oggi le palme sono coltivate in più di 90 paesi tra Asia, Africa, Caraibi e Sudamerica, per una produzione annua di oltre 60 milioni di ton- nellate, che equivalgono a quasi 60 miliardi di noci. Si tratta della sesta coltivazione mondiale.
Negli anni più recenti il mercato ha importato altri frutti esotici in Europa, dalle ormai classiche banane fino a papaya, mango, ananas e avocado, i cui consumi in Italia sono aumentati del 30% nell’ultimo decennio secondo Ismea. Ma il cocco resta il simbolo dell’estate: difficile da aprire a causa del suo duro rivestimento esterno, si è diffuso proprio grazie a quei venditori che risparmiavano il lavoro. Oltre a essere mangiato come frutto fresco o essiccato, il cocco ha una vasta possibilità di utilizzi nell’industria alimentare, cosmetica e dell’arredamento.
Tuttavia, anche il cocco risente della crisi climatica: la siccità ha fatto ridurre la produzione globale e di conseguenza i prezzi delle noci sono aumentati del 40% in un anno, secondo Ipsos. Nella nostra penisola, le regioni del sud stanno cercando di sfruttare la situazione: oggi tra Sicilia, Puglia e Calabria ci sono oltre mille ettari coltivati a mango, papaya e avocado, che disegnano un paesaggio agricolo impensabile fino a un decennio fa. La produzione ammonta a circa duemila tonnellate e rende più sostenibile l’acquisto a chilometro zero di questi frutti, che altrimenti arrivano da lontano e perciò generano un grande impatto ambientale. Se il cli- ma italiano dovesse continuare a tropicalizzarsi, non è da escludere che nel prossimo mezzo secolo potremmo trovare coltivazioni di mango anche in Romagna, al posto delle nettarine.
Ma questo non vale per il cocco, che ha bisogno di precise caratteristiche climatiche per poter essere coltivato, ovvero una temperatura media intorno a 28 gradi e un’umidità del 90% per tutto l’anno, insieme ad almeno 1500 mm di pioggia in dodici mesi. Condizioni che in Italia non esistono e si spera non esisteranno mai. Finché sarà così, chi ama questo frutto dovrà acquistarlo d’importazione e a caro prezzo. E ora che non ci sono più i venditori in spiaggia, bisogna anche aprirselo da sé.