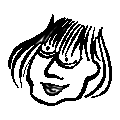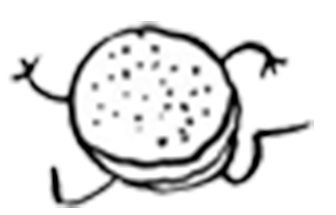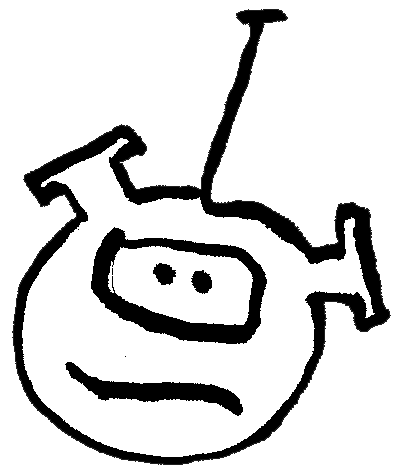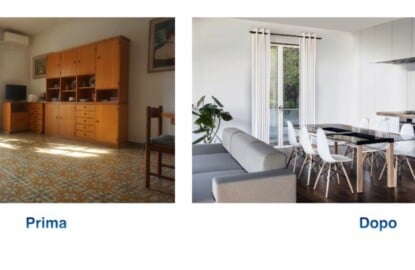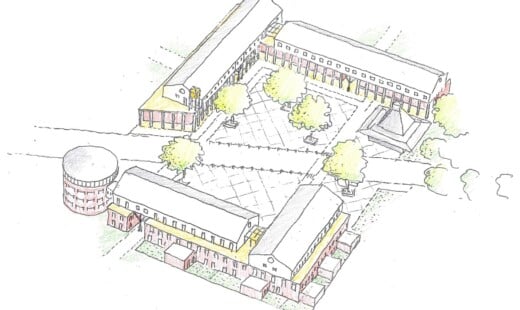Dall’1 all’8 giugno, nell’ambito del Ravenna Festival, il Grande teatro di Lido Adriano torna con Bhagavadgītā – Il canto del divino, progetto diretto da Luigi Dadina e Lanfranco Vicari con drammaturgia di Tahar Lamri (info a questo link).
Dadina, cos’è il Grande teatro di Lido Adriano?
«È una realtà che esiste da tre anni, ma che è nata da un’esperienza di due decenni, tra i laboratori della non-scuola del Teatro delle Albe e il Cisim. Nel 2022 abbiamo avuto l’idea di costruire un teatro comunitario, senza sapere bene dove ci avrebbe portato. La nostra fonte di ispirazione è arrivata da Buenos Aires, dove il gruppo Catalinas Sur ha messo in piedi un teatro di quartiere con attori, danzatori e musicisti di ogni età. I desideri erano due: mantenere una dimensione aperta e orizzontale, che permettesse a chiunque di partecipare, e rivolgere lo sguardo a Oriente».
Perché?
«L’orizzontalità ci ha permesso di avere un gruppo nutrito ed eterogeneo: la persona più giovane ha 4 anni, la più anziana 83. Guardare a Oriente era un impulso alla ricerca di nuovi spunti poetici, che non fossero le solite fiabe occidentali. Ma restando lontani dalle volgarizzazioni più modaiole e new age dell’Oriente, quelle fatte di yoga, incensi e campane tibetane».
Da dove proviene questo desiderio profondo di Oriente?
«Soprattutto dal suo stretto rapporto con Ravenna, di cui si è scritto tantissimo. Questa vicinanza passa dall’Adriatico: in Breviario mediterraneo, Predrag Matvejević lo definisce “mare dell’intimità” e molti lo considerano una pozzanghera, ma è la nostra porta di collegamento con Gerusalemme e Istanbul. Una porta aperta sull’approccio mistico di cui l’Oriente è ancora pregno, mentre noi occidentali l’abbiamo perso con l’illuminismo, che ha imposto la civiltà della ragione e della tecnica. Quel tipo di spiritualità – non intesa in senso religioso – è l’unica che consente una certa profondità di sguardo e di visione sul mondo, oggi più che mai necessarie. Per questo abbiamo voluto portare al pubblico un testo scomodo, che non appartiene alla nostra cultura ma che ci porta in viaggio verso un altrove».
Quest’anno mettete in scena la Bhagavadgītā, uno dei testi sacri più antichi e prestigiosi dell’induismo.
«C’è stato un processo di avvicinamento. Il primo anno ci siamo confrontati con Il verbo degli uccelli, un poema del poeta persiano Farid Ad Din Attar, vissuto nel 1200. Il secondo anno abbiamo attraversato il Panchatantra, una raccolta di favole in sanscrito risalente al 3° secolo; e quest’anno ci siamo sentiti pronti per una sfida più ardua. Il Bhagavadgītā è un dialogo tra due persone, Krishna (Dio) e Arjuna (un combattente), ma noi lo mettiamo in scena con 150 cittadini. Tutti arrivati grazie al passaparola, senza nessuna chiamata pubblica».
Di cosa parla il testo?
«È un’opera meravigliosa, ma anche complessa e urticante sin dall’inizio. Arjuna si rifiuta di fare la guerra e Dio lo costringe, invitandolo a seguire il suo dharma (destino, dovere). Questo incipit è stato subito problematico: ci sono state perplessità, rivolte e pianti; non tutti accettavano di trattare un’opera in cui Dio impone il conflitto. È un aspetto su cui si sono interrogati molti intellettuali e filosofi: alcuni hanno interpretato il Bhagavadgītā come un testo per guerrafondai, mentre altri – tra cui Gandhi – ci hanno letto l’essenza della non-violenza».
Avete trovato un equilibrio?
«Ci siamo arrivati grazie alla discussione. Ci siamo confrontati sulle difficoltà che si affrontano nella vita, sulle scelte che talvolta siamo costretti a prendere anche se non ci piacciono. Una chiave di lettura fondamentale è stata la storia della resistenza italiana: oggi celebriamo il 25 aprile, ma la liberazione è stata l’esito di una guerriglia civile, di una lotta fratricida. Quella guerra ha generato una Costituzione che afferma di ripudiare la guerra. Un paradosso simile all’incipit della Bhagavadgītā».
Quindi volete portare un messaggio contro la guerra?
«Ovviamente siamo tutti contro la guerra, ma dirlo non è sufficiente. È troppo semplice affermare di odiare la guerra e poi fregarsene dei conflitti in corso. La storia dell’umanità è costellata di guerre. La violenza e lo scontro sono un impulso umano, fanno parte di noi. È una questione irrisolvibile. Se qualcuno ci picchia, ci difendiamo nello stesso modo. Se oggi qualcuno tentasse di imporre una dittatura in Italia, cosa faremmo?».
La lotta armata?
«Probabilmente sì, ci siamo già passati. Nella Bhagavadgītā, i soldati non vogliono fare la guerra ma sono costretti. Per questo è un testo importante: affronta un problema tremendo che si perde nella notte dei tempi e ci interroga sul fatto che la guerra è dentro di noi, anche se sappiamo che è sbagliata. Perciò ogni individuo ha la responsabilità spirituale di uscire da questa condizione. È una domanda molto politica e radicale».
Come la affrontate?
«Attraverso immagini e racconti. Iniziamo con Max Penombra che dirige le onde del mare, un uomo che cerca di condurre un fenomeno naturale ingovernabile. Poi rappresentiamo noi stessi che non abbiamo mai conosciuto la guerra da vicino, ma ne ascoltiamo parlare la sera davanti alla tv, mentre ceniamo nella tranquillità delle nostre case. Ci sono racconti da tanti paesi: una ragazza ucraina che porta una visione intima del conflitto, due tunisine arrivate in barcone, alcuni africani che parlano lingue diverse e non si capiscono tra loro, un ragazzo del Ghana portato pochi giorni fa a Ravenna dalla nave ong Solidaire, che non so nemmeno come sia finito nel gruppo. Dio sarà interpretato da una masnada di bambini e Arjuna da 80 figuranti, di tutte le provenienze e le età. Siamo una “tribù profetica dalle pupille ardenti”, per dirla con Baudelaire, che si mette in viaggio e porta il pubblico nello spaesamento. Che è l’unica zona in cui possiamo ritrovarci».