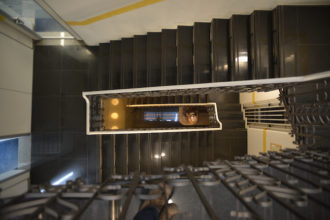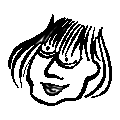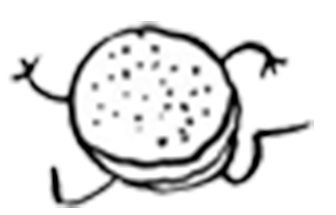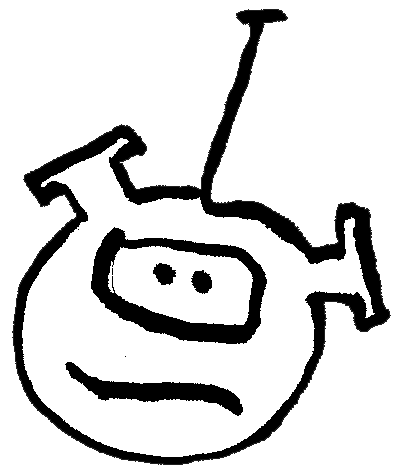In ricordo del compianto architetto ravennate Danilo Naglia recuperiamo dal nostro archivio (rivista “Casa Premium” del novembre 2014) una densa conversazione fra la nostra collaboratrice Marina Mannucci e il noto progettista che “si racconta” sul piano personale, professionale e, per così dire, etico e politico.
Circa vent’anni fa [scrive Marina Mannucci alla fine del 2014, ndr] mi capitò di contattare l’architetto Danilo Naglia per una consulenza professionale riguardo ad una casa da ristrutturare, un’occasione che ci ha permesso di conoscerci e di far crescere un rapporto di stima e amicizia reciproca che ci accompagna nel tempo.
Incontro Danilo in un bar del centro e, mentre sorseggiamo un caffè, inizia a raccontarmi momenti di storia della sua vita. Lo ascolto e prendo appunti…
«Ho deciso di frequentare la Facoltà di Architettura perché, avendo fatto il Liceo Artistico, era lo sbocco più adatto, ed anche perché, come forma artistica, mi dava la possibilità di esprimere il mio temperamento. È stata una scelta giusta, ma avrei potuto impegnarmi anche in altri campi. Sono nato e cresciuto in un ambiente in cui era naturale respirare “una certa aria”; mio padre era pittore ed ha insegnato all’Accademia, mia madre, oltre a dipingere miniature sull’avorio, suonava il pianoforte.
Tra gli anni ’50 e ’60 mi sono quindi iscritto alla Facoltà di Architettura di Venezia, ritenuta tra le migliori del mondo. In quel periodo, oltre ad essere un’università “libera”, vi erano confluiti i migliori professori: nel bienno ho avuto come docente di Architettura Bruno Zevi che svecchiò il clima portando il respiro dell’Architettura Organica, al terzo anno ebbi Ignazio Gardella per l’approccio alla progettazione, mentre Franco Albini, docente di Architettura degli Interni, mi ha trasmesso una grande dimensione della concezione di libertà. Franco Albini non imponeva mai nulla a noi studenti; ricordo che una volta gli chiedemmo di disegnare una casa popolare perché per noi era un tema importante ed un’altra volta di studiare un auditorium e lui ha sempre accettato ed appoggiato le nostre proposte.
Questo clima di libertà ci ha permesso di maturare. Alla Facoltà di Architettura, a quei tempi, si accedeva solo dai licei ed in più c’era la presenza costante del doppio binomio umanistico e scientifico. Giuseppe Samonà, direttore della Facoltà, era un uomo che aveva intuizioni formidabili, con un controllo permanente della cultura che poi si traduceva in problematicità. Di conseguenza, ci ha abituato ad affrontare gli studi in modo serio, diffondendo nello stesso tempo, tra noi studenti, un clima di entusiasmo.
Chi usciva non poteva che essere un Architetto e non un cialtrone e quindi la selezione era seria e rigorosa e quelli che arrivavano in fondo al percorso di studi erano pochi.
Giunto alla fine di questo corso di studi, ero un uomo formato sia culturalmente che politicamente e mi vennero offerte tutte le possibilità per realizzarmi. L’urbanistica a quei tempi si affrontava al quarto e quinto anno ed era un esercizio di composizione su scala territoriale. Io e il mio amico Gino Gamberini chiedemmo di farlo studiando il fenomeno dell’abbandono dell’Appennino imolese-faentino per vedere quello che si poteva fare a livello urbanistico.Con Gino iniziammo a girare tutta la zona di Casola Valsenio in Lambretta, venendo a conoscenza della situazione di povertà, indigenza e di mancanza di servizi in cui viveva la popolazione. Studiammo il territorio per capire cosa si potesse fare per dare un modo migliore di vita a quelle persone ed elaborammo un progetto.
Un’esperienza che ci ha insegnato che la funzione dell’architetto non è solo fare cose belle, ma soprattutto essere utile nella società e sapere ogni volta che posizione prendere. Una volta laureati, il sindaco Amleto Rossini di Casola Valsenio ci chiamò e ci affidò l’incarico di progettare una scuola elementare. Con Gino andammo a vedere i difficili percorsi che i bambini dovevano fare per andare a scuola, ed anche come vivevano dentro la scuola, che era allora un luogo squallido, umido, senza luce e senza riscaldamento. Quel progetto fu per noi l’occasione di realizzare nella vallata un luogo che potesse soddisfare tutte le esigenze di vita di quelle persone. Pensammo la scuola come un “centro sociale”.
Dopo questa misura morale e culturale che ho ricevuto dall’Università, parallelamente all’esercizio della mia professione ho sempre avuto a cura la difesa dell’ambiente e un amore sterminato per la mia terra. Negli anni ’70, girando per le valli ravennati, mi accorsi che, sia all’alba che al tramonto, il colore viola che contraddistingueva quel paesaggio stava scomparendo. Stavano sfalciando tutti i limonium, l’erba valliva chiamata anche statice, i cui fiori riuniti in infiorescenze erano di colore rosa, purpureo o violetto, un intervento che aveva tolto qualcosa di fondamentale alla connotazione estetica di quei luoghi. Inviai una lettera al professor Francesco Corbetta naturalista e botanico, che a quei tempi era direttore della rivista “Natura e montagna” e, grazie ad un suo intervento l’area venne sottoposta a vincoli paesaggistici arrestando sottrazione e massacro del paesaggio. Ritengo questo un successo della mia vita.
Un altro risultato positivo che reputo tale per la mia presenza nella società è stato recuperare la memoria di Roberto Bacchi, mio ex compagno di classe di quarta elementare, grazie anche all’intervento dell’allora direttore delle scuole elementari Mordani Giorgio Gaudenzi. Nel 1943 Roberto Bachi, ebreo, fu obbligato a salire su un treno che lo deportò nel campo di sterminio di Auschwitz senza più fare ritorno. Ora, tutti gli anni, il suo ricordo rivive nel “Giorno della Memoria”.
Tirando le somme della mia vita come architetto, penso di aver lasciato segni decorosi nella città. Ogni giorno è fondamentale per vedere in che modo la propria coscienza è stata rispettata. Scriveva Immanuel Kant nella conclusione della Critica della ragion pratica: “Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell’oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza”.
Ecco, io credo sia fondamentale mantenere questo doppio rapporto con la bellezza dell’universo e con la propria coscienza che è il nostro limite. Per quanto concerne il problema metafisico, esso non mi riguarda: Deus sive natura, come rifletteva Baruch Spinoza: “Dio ossia la natura”. Questi pensieri di Kant e di Spinoza sono la coscienza della mia vita. Morire essendosi portati rispetto è fondamentale, non sento il bisogno di avere la speranza di premi “futuri”; quando non ci sarò più, saranno i segni che ho lasciato a dimostrare che sono esistito».
Tra questi segni a quali sei particolarmente legato?
«Tra gli edifici che ho progettato mi piace ricordare: l’Istituto Tecnico Industriale di Ravenna, opera progettata anche con Antonino Manzone e Gino Gamberini; il condominio residenziale Marsala situato tra piazza Marsala e Via Salara; si tratta del primo tentativo che ho fatto di inserire un edificio moderno nel centro storico, per il quale Ignazio Gardella mi fece i complimenti quando venne a Ravenna in occasione della presentazione dei suoi mobili; l’edificio Yacthman House di Marina di Ravenna; l’intervento interno di Casa Melandri; l’intervento in piazza dell’Arcivescovado all’ex Istituto Bancario San Paolo di Torino ora Banca Popolare; la casa del dottor Lucinelli di Lugo; le case che ho progettato per Raffaello Biagetti; il condominio Verde di via Mario Montanari…».
Ed il presente?
«Mi capita spesso di sognare cose che non ho fatto, credo sia la necessità che è ancora viva in me di produrre in immagini le cose che ho in mente. Il mio cervello è ancora capace di emozioni; le emozioni appartengono a un campo privato, anche se alcune emozioni con gli anni si attenuano fino a scomparire. Ma natura, pittura, e musica mi sconvolgono ancora adesso.
Un’ultima riflessione riguardo al graffitismo che, nato alla fine degli anni sessanta a New York per rispondere ad un’esigenza espressiva ed anche come forma di rivendicazione, spesso illegale, di diritto alla parola, negli ultimi anni sembra essersi riappacificato col sistema oltre ad essere entrato a far parte anche di un circuito artistico. Una forma d’arte, dunque, divenuta un coloratissimo fenomeno di costume, allontanandosi da qualsiasi rivoluzione intellettuale e per la quale lo Stato si pone spesso come agenzia culturale, con la conseguenza che inesorabilmente il gesto anarchico del writer viene condizionato nella sua libertà».
Non credi sarebbe importante in questo passaggio, riflettere su come salvaguardare una più spontanea e libera produzione da parte di questi artisti?
«Sono d’accordo. È sempre necessario porsi di fronte alle cose con un atteggiamento problematico ed in questo caso le riflessioni da fare sono su piani diversi. Personalmente non sono contrario ai graffiti urbani, penso però che a volte i writer in qualche modo vengano strumentalizzati da un meccanismo; manca inoltre una coscienza culturale del “dove” sia giusto e dove non sia giusto intervenire con un graffito. I graffiti del muro di Berlino sono stati un modo di protestare contro un’ingiustizia commessa in una città. Un conto poi è se le pitture interessano un muro amorfo o le pareti di un edificio di architettura moderna. La riflessione quindi da fare a priori è: quando si può intervenire con un graffito e quando no. A Ravenna di posti dove si possono fare questi tipi di interventi ce ne sono. Io scrissi anni fa che un modo di ovviare allo scempio paesaggistico provocato dalle fabbriche di via Baiona sarebbe stato dipingerne i muri di cinta. I graffiti di Milo e SeaCreative sulle pareti esterne, affacciate su via Cassino e piazzale Sighinolfi dell’Istituto tecnico industriale da me progettato andavano lette come un volume, non come una lavagna. Se poi vogliamo parlare di graffiti come arte, posso aggiungere che il graffito dalla parte del mercato è rispettoso della geometria della parete e ne ha compreso il senso, il graffito dall’altra parete non ha nessun valore. Per concludere, credo ci debba essere un rapporto corretto tra decorazione e cultura, la collaborazione tra arti deve avvenire in modo organico e questo è un problema appunto di cultura».