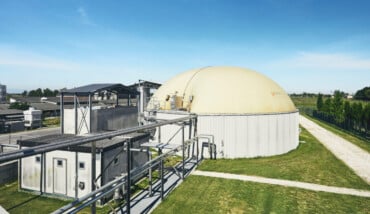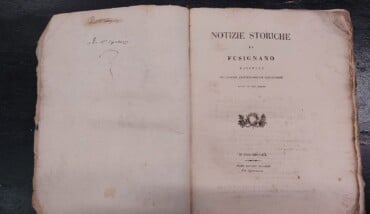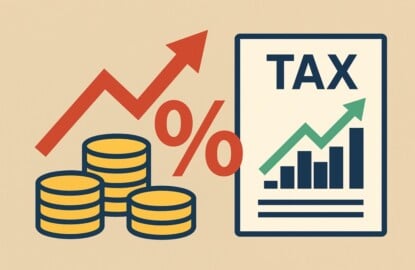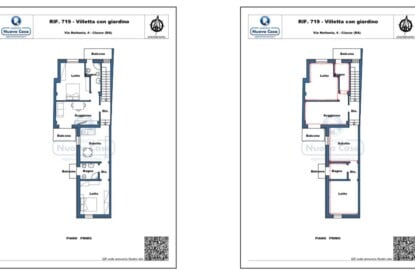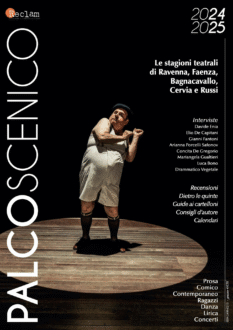«Al suono delle sirene antimissilistiche hai circa un minuto e mezzo di tempo per rifugiati negli shelter (i rifugi , ndr). Se non ne trovi uno, cerchi riparo sotto la tromba delle scale e aspetti. Dieci minuti, poi la vita ricomincia. All’inizio spaventa, poi ci si fa il callo, forse come forma di autodifesa».
Alex Alvisi ha 30 anni, è originario di Lugo ma da 3 anni vive a Haifa, nel nord di Israele. Sta conseguendo un dottorato in ingegneria aerospaziale, specializzandosi in fluidodinamica sperimentale: «Un settore con risvolti importanti in ambito biomedico e ambientale – spiega -. quando ho avuto la possibilità di studiare in un contesto scientifico come quello israeliano ho colto subito l’occasione».
Per un anno la sua esperienza in Israele è stata simile a quella di un qualunque studente all’estero, ma dal 7 ottobre 2023 le cose sono iniziate a cambiare: «Non in maniera così radicale come può sembrare dall’esterno – racconta -. In Israele la vita va avanti, sempre. La preparazione alle emergenze viene portata avanti fin dall’infanzia, è un concetto integrato nella società. Ricordo il primo corso di sicurezza all’università: ci è stato subito spiegato come gestire un attacco, dove sono gli shelter e come trovarli».
Il 7 ottobre, nel giorno dell’attacco di Hamas, Alvisi si trovava in un Air b&b di Tel Aviv, per un weekend fuori città: «Ci siamo svegliati sotto una pioggia di missili, in pochissimo tempo abbiamo dovuto mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti. La tensione nella Striscia di Gaza andava avanti da tempo, ma nella nostra zona non si percepiva. Quello è stato un vero punto di svolta». Il resto della giornata è trascorso nella paura: «Si è capito subito che sarebbe stato qualcosa di grosso. Il senso di smarrimento e di preoccupazione generale mi hanno spinto a rientrare in Italia, almeno finché la situazione non fosse diventata più chiara».
L’allontanamento però è durato solo poche settimane: «Anche nel caso degli attacchi più gravi, il lavoro rallenta, anche con dilatazioni di decine di giorni, ma non si ferma mai del tutto. L’università chiude per un breve periodo e poi riapre. L’aspetto che spesso sfugge anche alla narrazione mediatica è la fluidità della situazione israeliana, dove tutto cambia nel giro di pochi minuti e nulla rimane mai davvero paralizzato: sei in aula, o in palestra, e ti viene comunicato che tra un’ora dovrai chiuderti in casa, perché scatta la zona rossa. Allo stesso modo, dopo giorni di silenzi e strade deserte ti svegli all’improvviso con il viavai di persone che vanno al lavoro e bambini che corrono a scuola». Di recente, il sistema di sicurezza ricorda quello dell’Italia ai tempi del Covid: zone rosse dove si può uscire solo per reperire beni di prima necessità e altre aree – arancioni, gialle o verdi – in cui le restrizioni si allentano progressivamente. «La quotidianità però non sembra troppo diversa, soprattutto per gli stranieri come me. Il turismo è calato, ma nelle zone di maggiore interesse, come Gerusalemme, rimane sempre vivo. La vita è cambiata principalmente per chi ha a che fare con le riserve, con i sistemi di difesa, gli “addetti al settore” che inevitabilmente si trovano in prima linea».
A favorire il senso di sicurezza della popolazione, i sistemi di difesa aerea all’avanguardia, un’intelligence avanzata per l’intercettamento dei missili, con diversi livelli di protezione, tra cui l’Iron Dome (la Cupola di Ferro, un sistema d’arma mobile messo a punto proprio in Israele, in grado di intercettare razzi a media velocità e proiettili balistici) che ha permesso di contenere le minacce aeree sul fronte interno, almeno prima delle ultime tensioni con l’Iran. «Tra gli episodi che mi hanno toccato più da vicino ci sono gli scontri con Hezbollah, vista la vicinanza di Haifa con il Libano. Nonostante le ripercussioni maggiori sulla quotidianità e le corse giornaliere ai rifugi, quando vengono lanciati centinaia di missili e quasi tutti vengono intercettati e distrutti si innesca un meccanismo psicologico di finta tranquillità: ti permette di andare avanti, ma è solo un’illusione. Nessuno ti garantisce che anche il prossimo attacco finirà così, e questa sensazione di stress sotto pelle si ripercuote sul sonno, sull’appetito, è qualcosa di difficile da spiegare a chi non l’ha vissuto».
Se l’escalation degli ultimi anni viene vissuta come un «continuo alzare l’asticella, alternando momenti di tensione a calma apparente» l’ultima tacca è stata segnata proprio dai raid iraniani: «Si è trattato di attacchi molto diversi dai precedenti, più critici, con munizioni capaci di bucare più volte la bolla del sistema di difesa. I danni sono stati più ingenti, come riportato dai Tg». All’inizio della guerra con l’Iran Alvisi si trovava in Italia, per una visita a casa che sarebbe dovuta durare solo pochi giorni. Ha scoperto da poco che riuscirà a tornare a Haifa solo il 17 luglio: «Non mi aspetto nulla di troppo diverso al mio rientro. Cresceranno la tensione e la preoccupazione per il futuro, ma tutto riprenderà da dove l’avevo lasciato». Anche dall’interno infatti, le previsioni sono impossibili e la vita si conta giorno per giorno «Personalmente, ho sempre cercato di non prendere una posizione. Vivere qui non basta per capire davvero la complessità del conflitto, perché comunque non potrà mai appartenerci. Il contatto con le persone locali ha fatto davvero la differenza per immergermi in un contesto altrimenti solo abbozzato. Solo recentemente ho capito quanto sia distorta in occidente la concezione del popolo israeliano: lo pensiamo soprattutto come europeo, ma circa la metà della popolazione proviene da Yemen, Giordania, Libano e zone limitrofe. Su questo tema mi ha aiutato molto anche la lettura del libro di Anna Momigliano Fondato sulla sabbia. Un viaggio nel futuro di Israele (Feltrinelli) dove i concetti alla base della crisi vengono snodati molto bene pur restando un testo di facile lettura».
Al di là degli aspetti militari, questi anni in Israele hanno aperto una serie di interrogativi sul senso di appartenenza, sulla complessità del conflitto e su come questo venga raccontato in Occidente: «Nonostante la narrazione del governo e dell’informazione locale che continua a essere molto incentrata sugli ideali, dalle ultime statistiche, seppur svolte a campione, il popolo israeliano risulta stanco degli scontri, e sempre più sfiduciato nei confronti del governo. Al tempo stesso, il popolo palestinese, nonostante non abbia uno stato pienamente riconosciuto, negli ultimi anni è stato bistrattato e penso sia giusto e normale provare empatia davanti a tanta sofferenza – conclude Alvisi -. Ma la situazione è infinitamente più radicata e sarebbe meglio non ridurre un contesto così delicato a una tifoseria stadio: è il primo conflitto vissuto nell’era dei social media, dove le narrazioni polarizzate si moltiplicano e le immagini si rincorrono sullo schermo senza contesto. Meme sulla guerra e informazioni superficiali, non solo feriscono, ma non fanno altro che ridicolizzare la complessità del problema».

 Haifa. Novembre 2024. Proteste contro il governo. Tutte le foto sono di Alex Alvisi
Haifa. Novembre 2024. Proteste contro il governo. Tutte le foto sono di Alex Alvisi
 Purim 2025 (carnevale ebraico). «Questa foto mi piace perché rappresenta Israele secondo il mio punto di vista. Un paese di contrasti e contraddizioni. Da una parte un clima festoso, dall’altro un monito al ritorno degli ostaggi».
Purim 2025 (carnevale ebraico). «Questa foto mi piace perché rappresenta Israele secondo il mio punto di vista. Un paese di contrasti e contraddizioni. Da una parte un clima festoso, dall’altro un monito al ritorno degli ostaggi».
 Haifa, maggio 2023
Haifa, maggio 2023
 Sui tetti di Gerusalemme. Agosto 2024.
Sui tetti di Gerusalemme. Agosto 2024.
 Tel Aviv. Gennaio 2025.
Tel Aviv. Gennaio 2025.
 Sderot, maggio 2025. Shelter mobile. Essendo nell’inviluppo di Gaza il tempo per correre al riparo in caso di lancio di missili è pressoché nullo (15 secondi) per cui la città è disseminata di shelter mobili. Qui di fianco alla stazione del bus.
Sderot, maggio 2025. Shelter mobile. Essendo nell’inviluppo di Gaza il tempo per correre al riparo in caso di lancio di missili è pressoché nullo (15 secondi) per cui la città è disseminata di shelter mobili. Qui di fianco alla stazione del bus.
 Tel Aviv, Aprile 2025.
Grattacieli e sinagoga
Tel Aviv, Aprile 2025.
Grattacieli e sinagoga
 Cesarea, maggio 2025.
Cesarea, maggio 2025.
 Sui tetti di Gerusalemme. Agosto 2024.
Sui tetti di Gerusalemme. Agosto 2024.
 memoriale della vecchia stazione di polizia di Sderot, assalita il 7 ottobre 2023
memoriale della vecchia stazione di polizia di Sderot, assalita il 7 ottobre 2023