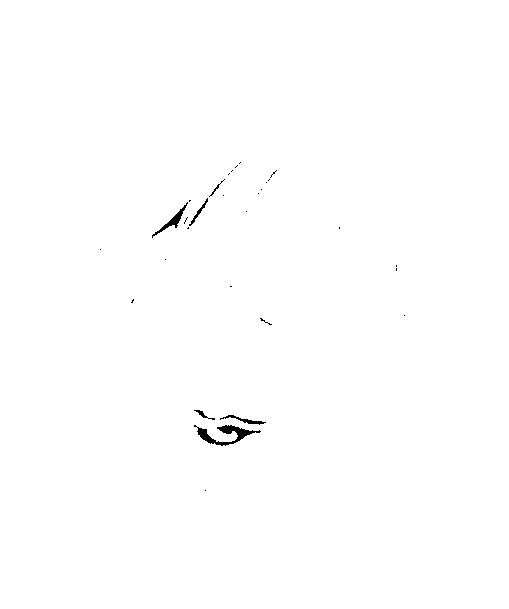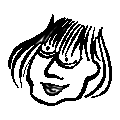Pubblichiamo un intervento sul tema della sicurezza urbana di Marina Mannucci, attivista ravennate per il clima e i diritti umani.

«Giove ci ha imposto due bisacce: dietro la schiena c’è quella piena dei nostri difetti, appesa al petto c’è la pesante bisaccia dei vizi degli altri. Per questo non possiamo vedere i nostri difetti, ma facciamo i censori non appena gli altri sbagliano»
Fedro, Fabulae, IV 10
Violenza e insicurezza sono all’origine di una trasformazione radicale delle città contemporanee e delle abitudini dei suoi abitanti. Il rischio è che il controllo e le politiche della sicurezza incrementino la frammentazione spaziale e sociale. Molte ricerche segnalano che l’inadeguatezza dell’azione pubblica sulla criminalità può condurre a adottare misure restrittive che impattano negativamente sulla qualità della vita e l’accessibilità della città. Nei casi più estremi, lo spazio pubblico si trasforma nello “spazio della paura”, nel quale alcune figure sociali – spesso i poveri e gli emarginati – vengono considerate invasive o aggressive. Frammentazione e controllo possono produrre una spirale negativa, in cui lo spazio urbano non si presta a sostenere la formazione di legami sociali. Le politiche dirette sulla geografia sociale dei quartieri e sulla natura dello spazio pubblico, sulle quali l’urbanistica e il Governo del Territorio operano con responsabilità diretta, possono provocare obiettivi di inclusione o, al contrario, di esclusione sociale. Società, amministrazione, politica ed economia influiscono sul territorio a livello locale, regionale e nazionale ed è perciò indispensabile avere una conoscenza dei processi decisionali che, consapevolmente o inconsapevolmente, sono di rilievo per il territorio; analizzarne le caratteristiche, il funzionamento e i problemi di attuazione e avviare strumenti di controllo (ricerca sulla governance e la policy) è un processo indispensabile per comprendere chi e che cosa provoca cambiamenti.
La gestione della complessità sociale implica la comprensione delle interazioni tra individui, gruppi, istituzioni e sistemi, nonché la capacità di adattarsi a contesti in continua evoluzione. Nel 2024 è ricorso il centenario della nascita di Danilo Dolci, uno dei protagonisti italiani del rinnovamento in ambito sociale e educativo del dopoguerra che ha promosso lo sviluppo non violento e creativo della comunità. Ripercorrere alcuni tratti del suo pensiero e delle pratiche non violente di quel periodo è propedeutico a una “lettura” degli accadimenti di “ordine pubblico” e “sicurezza a rischio” di cui in questi giorni c’è un confronto aperto sulla stampa locale della nostra città.
«C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato».
Danilo Dolci, Poema Umano, Messina, Mesogea, 2016

Danilo Dolci nasce nel 1924 a Sesana, in Friuli-Venezia-Giulia. Studia Architettura al Politecnico di Milano, dove la frequentazione delle realtà operaie lo aiuta a comprendere l’importanza delle mobilitazioni collettive per i diritti e l’emancipazione. Nel 1950, poco prima della laurea, Dolci lascia la città per raggiungere Nomadelfia, villaggio fondato da don Zeno Saltini per ospitare gli orfani di guerra; nel 1952 si trasferisce a Trappeto in provincia di Palermo dove viene a contatto con una situazione complessa causata da disoccupazione, degrado, ignoranza, analfabetismo, cattiva politica e illegalità. Attraverso progetti partecipativi, inizia il suo lavoro di impegno trasformativo che va oltre l’assistenza, includendo la promozione della nonviolenza, la lotta alla mafia e lo sviluppo del territorio. Impegno scientifico e civile che gli viene diffusamente riconosciuto; riceve una laurea honoris causa in filosofia dall’Università svizzera di Berna, una in Scienze dell’Educazione dall’Università di Bologna ed è più volte candidato al Nobel per la Pace. Tra i suoi estimatori vi è il filosofo e sociologo Jürgen Habermas; il sociologo e matematico – fondatore del Peace Research Institute Oslo – Johan Galtung; lo psicologo e psicoanalista Erich Fromm; il politico, giurista, tra i fondatori del Partito d’Azione e tra gli artefici della Costituzione repubblicana Piero Calamandrei; il filosofo, giurista, politologo, storico Norberto Bobbio; lo psicologo, biologo, pedagogista Jean Piaget; il filosofo, scrittore, drammaturgo e critico letterario francese Jean-Paul Sartre; il poeta, scrittore, regista, sceneggiatore e drammaturgo Pier Paolo Pasolini; il filosofo, matematico, attivista, saggista e esponente del movimento pacifista Bertrand Arthur William Russell e il filosofo, politico, antifascista e educatore, tra i primi in Italia a teorizzare il pensiero non violento gandhiano, Aldo Capitini. Il rapporto tra Danilo Dolci e Aldo Capitini è caratterizzato da una profonda stima reciproca e collaborazione, testimoniata da una ricca corrispondenza, in parte inedita. Dolci vede in Capitini una figura di riferimento ideale, mentre Capitini segue con attenzione l’opera di Dolci, trovando ispirazione per i suoi studi e approfondimenti nel campo civile, educativo e politico. Pur operando in contesti e con modalità differenti, entrambi sono figure chiave nel panorama italiano nel campo del degrado sociale, ponendo l’accento sulla non violenza e sull’importanza dell’azione partecipativa per il cambiamento. Dolci, con la sua azione diretta e le inchieste a Palermo, si concentra sulla lotta alla mafia e alla povertà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. Capitini sviluppa una teoria della non violenza basata sulla “concentrazione” e sull’educazione alla partecipazione democratica, mirando a superare le disuguaglianze e l’oppressione. Le pratiche di non violenza, dal dopoguerra a oggi, si sviluppano come strumenti di cambiamento sociale e comprendono azioni dirette, come digiuni e manifestazioni, forme di resistenza passiva, come l’obiezione di coscienza e il boicottaggio. L’obiettivo è quello di promuovere la pace, la giustizia e il cambiamento sociale attraverso mezzi non violenti, rifiutando la logica della violenza e della guerra.

Arrivando ai giorni nostri è in questa direzione che ha indirizzato il suo lavoro di ricerca anche Gabriella Falcicchio, pedagogista, docente universitaria, attivista del Movimento Nonviolento e Operatrice della nascita del Melograno di Bologna (L’atto atomico della nonviolenza. Relazioni, stili di vita, educazione: Aldo Capitini e la tradizione nonviolenta, 2022, Profeti scomodi, cattivi maestri. Imparare a educare con e per la nonviolenza, 2018, entrambi editi dalle Edizioni La Meridiana di Molfetta).
Gli approcci pedagogici e sociali di Capitini, Dolci e Falcicchio sono un’interessante fonte d’ispirazione per chi cerca soluzioni innovative e partecipative ai contemporanei problemi sociali e di sicurezza urbana; dinamiche in cui è sempre più spesso il mercato a sancire inclusioni ed esclusioni, privilegi e privazioni. Le questioni che riguardano il tipo di città in cui vorremmo vivere sono strettamente collegate al genere di persone che vogliamo essere e alle modalità di relazioni interpersonali (di genere, di classe, ambientali ecc.) che vogliamo intrattenere. Una gestione urbana con metodi non violenti utilizza tendenzialmente un approccio che promuove la partecipazione attiva di cittadine/i, la coesione sociale e la riqualificazione degli spazi urbani; include interventi di prevenzione situazionale, azioni per contrastare la marginalità e l’esclusione sociale, nonché la creazione di spazi pubblici accoglienti e sicuri. Questi progetti mirano a prevenire e risolvere conflitti attraverso il miglioramento della vivibilità e del decoro urbano, riducendo marginalità ed esclusione sociale. Esempi specifici includono un’attenzione alla creazione e diffusione di spazi verdi, centri comunitari e programmi di prevenzione della criminalità che coinvolgono attivamente la comunità locale: un ambiente che promuova la responsabilità individuale e collettiva, invece di alimentare dipendenze. Un approccio che richiede la promozione di interazioni costruttive tra i cittadine/i, per superare le frammentazioni e favorire la coesione sociale.
Per quanto riguarda i processi partecipativi a Ravenna, negli ultimi decenni, si sono formate/i ottime/i professioniste/i per promuovere l’equità sociale, la tutela dei diritti umani, della cui competenza professionale non si tiene adeguatamente conto. Le politiche di sicurezza urbana integrate con politiche della “cura”, come ci insegnano Capitini, Dolci e Falcicchio (e molte/i altre/i) mirano a creare ambienti urbani più vivibili e sicuri, affrontando non solo la criminalità ma anche il degrado sociale e le cause della marginalizzazione. Sono processi difficili, sempre aperti, che richiedono specifiche competenze in grado di analizzare e comprendere le complesse interazioni tra diverse identità sociali e che prevedono diverse fasi, dall’ascolto del territorio alla restituzione pubblica dei risultati. Un approccio che si concentra sulla prevenzione, il coinvolgimento della comunità e la riqualificazione degli spazi, andando oltre la semplice repressione.
«L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità»
Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri