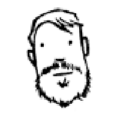La rappresentazione del sacro è uno dei τόποι più frequentati dall’arte: dalla pittura alla musica, gli esempi che si possono trarre sono innumerevoli e pieni di significato. Seppur minori nel numero, le dimostrazioni si possono trovare anche nell’opera lirica e uno dei più noti e importanti è quello messo in musica da Giuseppe Verdi su versi di Temistocle Solera: Nabucco. L’opera prende il titolo da un importante sovrano di Babilonia, Nabucodonosor II, che nel 586 a.C. distrusse il Primo Tempio di Gerusalemme e obbligò il popolo ebraico alla cattività babilonese. La vicenda mescola un po’ i vari riferimenti al re sparsi tra i libri di Daniele e Geremia e il libretto consegna a questa figura una duplice veste: nei primi due atti Nabucco è il re conquistatore che, vanagloriosamente, si erge a dio che, infine, da Dio è punito con la pazzia, mentre nei due atti conclusivi si assiste a un processo di redenzione che conduce fuori dalle tenebre della mente il sovrano babilonese che, grazie a un provvidenziale intervento divino, riprende il potere ripudiando il culto di Baal e «servendo a Jeovha». Questo viaggio agl’inferi e ritorno del re mesopotamico si regge grazie alla presenza di due importanti figure, la vera antagonista dell’opera, la superba Abigaille, e il pontefice ebraico Zaccaria. La prima è la personificazione del detto “covare una serpe in seno” poiché Nabucco la tratta come figlia senza curarsi della sua condizione di schiava e nonostante ciò questa attenta alla corona ben prima della pazzia regale. L’uomo di fede, invece, è specchio dell’umanità intera e contro il male reagisce col male salvo poi, dopo esserne stato schiacciato, accettare rassegnato le conseguenze affidandosi al disegno divino. Giuseppe Verdi giunse a quest’opera, terza nel suo corpus, nel 1842 dopo aver perso moglie e figli. Essendo uomo di fede è importante leggere il contenuto di Nabucco anche dal punto di vista religioso: ciò si ravvisa non solo nel manipolare musicalmente l’intreccio, ma anche nella scelta dei timbri e dell’orchestrazione.
È stato possibile ammirare la potenza di quest’opera al teatro Alighieri di Ravenna il 23 novembre, prima di tre rappresentazioni, all’interno dell’ormai consueto appuntamento “Trilogia d’Autunno” che Ravenna Festival promuove nel teatro romagnolo. Sono molti gli spunti di riflessione che questa messa in scena regala. Si può partire dalla regia, firmata come di consueto da Cristina Mazzavillani Muti, affiancata dal light designer Vincent Longuemare e dal visual designer Davide Broccoli sottolineando come l’ambientazione sia perfettamente calata nel periodo storico adeguato, con costumi e attrezzi di scena molto pertinenti ed evocativi (su tutte è mirabile l’idea della statua che si distrugge nel finale), tuttavia alla lunga l’abbondanza di proiezioni rende piatta un’opera tridimensionale e sicuramente troppo spesso i cantanti sono costretti a cantare dietro al tulle, con conseguente perdita di efficacia vocale.
La scelta di far precedere agli atti dei rumori abominevoli che dovrebbero essere evitati in ogni soundcheck che si rispetti è, invece, deprecabile. Basti pensare alla sacralità del preludio, all’intenso corale intonato dai tre tromboni e dal cimbasso, alla sua evocativa ieraticità e come questo acustico Moloch possa aver distrutto l’intima sacralità del momento.

Il cast vocale era composto da molti giovani tuttavia non sempre la gioventù è un beneficio, ma a volte si tramuta in svantaggio: talvolta accade che a monte di un debutto precoce risieda uno studio tecnico approssimativo. Quello che nella serata ravennate è emerso può essere considerato un incrocio tra questa motivazione e la classica debolezza temporanea. Lo Zaccaria di Evgeny Stavinski è il più convincente tra tutti i personaggi in gioco: il basso russo è sicuramente un giovane da tenere d’occhio per il bellissimo timbro e la grande sicurezza che potrebbe guadagnare affidandosi ancor di più a una tecnica che, sebbene non ancora granitica, appare comunque già ben acquisita. La pronuncia è sensibilmente migliorabile, tuttavia le premesse sono ottime.
Serban Vasile, nei panni di Nabucco, risulta molto incerto, specialmente nel secondo atto nel quale la sua voce appare molto opaca, probabilmente anche a causa della scelta registica di farlo cantare quasi nei camerini vista la lontananza delle sue azioni dal proscenio; dal terzo atto conquista spazio sia drammaturgicamente che vocalmente e nel quarto atto riscatta in parte le incertezze della prima metà dell’opera. Abigaille è certamente un ruolo molto impegnativo per il quale la giovane Alessandra Gioia forse non è ancora pronta: il soprano è messo a dura prova dalla vocalità richiesta da Verdi e le difficoltà d’intonazione negli attacchi delle note intorno al passaggio, unite alla disomogeneità tra i vari registri, rendono la figura della schiava usurpatrice ancora più terribile. Molto interessante, invece, il mezzosoprano Lucyna Jarząbek che, nei panni di Fenena, mette in gioco una personalità e scenica e vocale molto importante. Incredibile la sua intonazione nel terzetto del primo atto dove, mentre i colleghi pascolano tra improbabili temperamenti, la cantante polacca non perde la rotta grazie a una bussola interiore che dovrebbero acquistare tutti i musicisti.
Gli altri cantanti si perdono in una serata che non naufraga grazie anche al felicissimo supporto del Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”, diretto splendidamente da Martino Faggiani: raramente si ascolta una tale coesione e, data l’importanza che il coro riveste in quest’opera di Verdi, è sublime poterne godere.
Di tutt’altro apporto, purtroppo, la banda sul palco (allestita in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Verdi” di Ravenna) che non nasconde per un minuto il fatto di essere composta quasi integralmente da studenti di conservatorio. È certo bello vedere giovani che calcano le scene, tuttavia è questione morale salvaguardarli dalle brutte figure quando essi non sono ancora in grado di camminare senza guida.
Il capitolo orchestra è forse il più triste della serata: l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha abituato il pubblico ravennate a ben altre prestazioni perciò sentire l’intonazione biforcuta dei violini, gli attacchi imprecisi e molteplici cedimenti danno l’impressione che i recenti avvicendamenti sulle sedie più importanti non siano stati felici. A capo di tutto c’è il quasi incolpevole Alessandro Benigni, chiamato in extremis a sostituire sul podio Pietro Borgonovo: il direttore supplente si destreggia in un’inevitabile lettura epidermica dell’opera cercando con estrema fatica di limitare considerevolmente i danni.
In coda una considerazione. È interessante chiedersi quale apporto dia al significato drammaturgico dell’opera la presenza in scena di un boa constriptor: originario dell’America centro-meridionale, sembra alquanto improbabile che popolasse il palazzo di Nabucodonosor II.