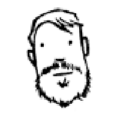I festeggiamenti del Bonci di Cesena per i 170 anni della propria storia rimandano all’inaugurazione del teatro, avvenuta il 15 agosto 1846 dopo una lunga storia di progetti intrapresi e abbandonati, che pure era riuscita a bruciare nei tempi la nascita dei teatri comunali di alcune città romagnole come Ravenna e Rimini. L’impresario romano Vincenzo Jacovacci, a cui era stato affidato nel 1846 il compito di celebrare la tanto attesa apertura al pubblico dell’edificio, corrispose in modo adeguato alle aspettative dei cesenati accorsi in massa all’evento. La scelta del Comune sull’organizzatore non era caduta a caso: per i giudizi dell’epoca si trattava del miglior impresario sulla piazza che, nonostante alcuni vizi conclamati – le fonti lo descrivono come uomo assai avido e tirchio –, poteva contare su una grande dimestichezza con gli artisti più accreditati del tempo: fra questi, addirittura Giuseppe Verdi che pur riconoscendone i limiti lo trovava simpatico e degno di grande stima. L’apertura della stagione con l’Ernani e I lombardi del grande compositore, chiamato ad inaugurare il teatro cesenate, non sortì però un grande entusiasmo in città nonostante la presenza di un’interprete lirica affermata come Teresa de Giuli-Bosi. Molto meglio andarono le repliche della Maria di Rohan di Gaetano Donizetti che avevano aperto la stagione e, un paio di settimane dopo, quelle del balletto della Beatrice di Gand per la coreografia di Domenico Ronzani. Ciò che non potè la musica riuscì alla silhouette sensuale dell’interprete principale, la ballerina di origine austriaca Fanny Elssler, all’epoca una delle stelle della danza internazionale.
A leggere le cronache del tempo, a Cesena venivano invitati gli artisti musicali e teatrali più in vista non solo in Italia, prima o poco dopo essere stati alla Scala di Milano, il teatro che funzionava da modello come edificio e scelte di programmazione. Nel 1778, proprio il Teatro milanese era stato infatti uno dei primi in Italia ad essere costruito seguendo un impianto a ferro di cavallo obbedendo alle tesi innovative per il tempo di Francesco Algarotti. Criticando la tradizione precedente che privilegiava la cavea a campana, il saggista indicava questa come la pianta migliore per la resa acustica. Diffuso solo alla metà del secolo successivo, il modello venne scelto anche dal progettista del Bonci di Cesena, l’architetto Vincenzo Ghinelli, che approdava nella città romagnola dopo una lunga esperienza di costruzione di teatri e di interventi architettonici nelle maggiori città marchigiane.
Il pubblico cesenate non aveva apprezzato solo le musiche, le danze e la grande festa organizzata in città per l’inaugurazione della prima stagione del teatro, ma ne aveva appoggiato anche la costruzione, sostenendo costi mirabolanti per l’epoca, arrivati a sfiorare le 490.000 lire. Il tutto non sorgeva dal nulla ma da una lunga tradizione teatrale che in Romagna aveva radici profonde: a Cesena, probabilmente le prime rappresentazioni pubbliche vennero realizzate nel periodo medievale, mentre in epoca moderna si hanno testimonianze di rappresentazioni teatrali per il 1560: una data, questa, che andrebbe approfondita in relazione al valore politico attribuito al teatro da alcuni esponenti della Legazione pontificia come il Presidente di Romagna Pier Donato Cesi, che sperimentarono la possibilità di pacificare la Romagna anche mediante rappresentazioni teatrali recitate dai rampolli delle famiglie aristocratiche, al tempo acerrime nemiche. Ad ogni buon conto, Cesena nel 1618 possedeva un teatro stabile nella sede di Palazzo Alidosi, poi Spada, che continuò la propria attività fra vicende alterne fino al 1843. Proprio alla metà del ‘700 è il famoso tombeur de femmes Giacomo Casanova ad assistere ad una rappresentazione nel teatro di Cesena, che – ironia della sorte – mette in scena proprio la Didone abbandonata di Metastasio.
Atterrato nel 1783 per ordine di Spada, il teatro verrà ricostruito in legno poco più di una decina di anni dopo: l’ennesima inaugurazione, avvenuta nel 1798, viene celebrata con l’opera buffa La donna volubile di Marcantonio Portogallo. Nonostante la frequentazione e la decisione da parte della Municipalità di accollarsi i costi della programmazione teatrale, l’edificio è considerato fin da subito sottodimensionato rispetto ai desideri e le necessità della cittadinanza. Dai primi decenni dell’Ottocento inizia così un percorso accidentato che porta a progettazioni talvolta molto sperimentali come quella dell’architetto Leandro Marconi, scartate perchè pensate per la sede non convincente del Palazzo comunale. L’idea che prende piede negli anni è quella di acquistare Palazzo Spada, che possiede una buona collocazione e lo spazio giusto: le trattative fra il Comune e il proprietario troveranno un approdo solo dopo una ventina di anni, nel 1842, quando – contestualmente all’acquisto – viene chiamato l’architetto Ghinelli a realizzare il nuovo progetto del teatro, consegnato in stesura definitiva praticamente subito, nell’aprile dello stesso anno.
Nonostante la lunga incubazione, basterà solo un anno dalla posa della prima pietra – avvenuta il 15 agosto 1843 – per concludere la costruzione, mentre altri due saranno necessari per completare le decorazioni dell’edificio, gli arredi e la fornitura delle apparecchiature. Una volta terminato, il progetto di Ghinelli si presenta come lo vediamo oggi: un edificio neoclassico non distante dal modello milanese di Piermarini di cui viene ampliato il primo ordine di archi in bugnato, coronato in entrambi i casi da una balconata. La facciata del Bonci viene scandita da un secondo ordine di ampie finestre intercalate a semicolonne che sorreggono la trabeazione, su cui viene impostato un frontone come a Milano.
Nella città romagnola il linguaggio della Scala si semplifica e si scalda grazie ad una forte semplificazione dei volumi e all’alternanza dei colori bianco e rosso mattone.
L’importanza non si incentra come nella capitale lombarda nella severità del bianco, ma nella scelta della collocazione, posta nel cuore della città su una piazza di rispetto che dà direttamente sulla via Emilia. L’idea è che qualunque forestiero arrivi tramite l’asse viario cittadino principale, posi lo sguardo sulla costruzione che deve costituire il simbolo della vita culturale e sociale delle élites cittadine. É il frontone esterno che rammenta a tutti i visitatori l’identità del luogo nei bassorilievi raffiguranti lo stemma cittadino e le personificazioni dei due fiumi prìncipi, il Savio e il Rubicone, mentre le decorazioni a cotto fra le lesene definiscono la funzione dell’edificio nelle figure di Apollo, Dioniso e delle nove Muse, protettrici delle arti.
Che l’edificio fosse una sorta di schermo su cui la cittadinanza poteva proiettare la propria autorappresentazione se ne ha testimonianza nella capacità dell’edificio, leggermente sovradimensionata per la reale popolazione dell’epoca. Sarebbero bastati meno di un migliaio di posti, ma il teatro viene organizzato su quattro ordini di palchi a cui si aggiunge il quinto, costituito dal loggione, in modo da ospitare contemporaneamente almeno 1200 persone. Rigorosamente separati dai plebei che si radunano nel loggione, la nobiltà cesenate – secondo le tradizionali leggi sociali applicate in tutta Italia – acquista i palchi ad essa riservati che passeranno poi in via ereditaria, mentre i posti in platea vengono occupati dai borghesi. Nonostante le rigide divisioni spaziali, il pubblico è abituato a concepire lo spazio come privato. Questo spiega il fatto che i palchi siano protetti dagli sguardi indiscreti dei vicini e che il pubblico interagisca con chi è in scena con urla, fischi, lanci di doni e fiori. C’è addirittura chi prosegue lo schiamazzo fuori dallo spazio teatrale, inseguendo personaggi pubblici e attori, trainando carrozze o testimoniando il proprio favore fin sotto alle finestre degli alberghi dove alloggiano attori, cantanti o musicisti. Ad attirare le attenzioni dei fans, sono le dive dell’Ottocento come le attrici drammatiche Adelaide Ristori e Irma Gramatica, o grandi attori come Ermete Novelli. Una particolare attenzione viene dedicata a un cesenate doc, il tenore Alessandro Bonci, che da apprendista calzolaio si trovò dapprima a calcare le scene del Regio di Parma, per proseguire le proprie esecuzioni in tutta Europa e negli Stati Uniti. Nel settembre 1927, avendo preso la decisione di ritirarsi dal lavoro, tornò nella sua città natale in occasione dell’intitolazione del teatro cittadino al suo nome. In quella serata, alla presenza di un teatro straripante di concittadini, cantò la Messa da requiem di Verdi ricevendo doni e un’acclamazione corale.
Solo la seconda guerra mondiale ha posto fine ad un certo divismo e alle intemperanze del pubblico: al Bonci, fin dagli anni ‘50 si susseguono alcune prime di rilievo e passano artisti del calibro di Vittorio Gassman, Salvo Randone, Lina Volonghi, Romolo Valli, Annamaria Guarnieri, Rossella Falck, Dario Fo e Franca Rame. Si tratta solo di alcuni dei grandi interpreti che calcano il palcoscenico del teatro nel susseguirsi degli anni. Il pubblico segue con attenzione, proseguendo la tradizionale passione verso tutte le arti teatrali: ciò che viene meno è solo quell’euforia effervescente che aveva contraddistinto in passato tutte le serate prima, durante e dopo lo spettacolo. Il pubblico è cambiato e forse solo un divo se ne ricorderà nel 1977. È Carmelo Bene, che ospite in città con l’indimenticabile Riccardo III, a metà della notte spalanca le finestre della propria camera d’albergo che dà sulla piazza e …si libera la vescica. Qualche cesenate ricorda ancora l’episodio (che è qualcosa di più di un racconto metropolitano) ma per i posteri Carmelo Bene sarà sempre e solo uno dei più grandi geni del teatro del ‘900 italiano.