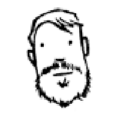Francesco Della Torre, il nostro “allievo enoico”, in occasione della 57ª edizione del Vinitaly a Verona, la più importante fiera enologica italiana, ha bisogno di alcuni consigli e rivolge alcune domande ad Alessandro Fogli, sommelier e titolare su Ravenna&Dintorni della rubrica sul vino, per approfondire un paio di concetti sempre più familiari nel mondo del vino.
FDT: Vinitaly non ha bisogno di presentazioni, Vinitaly è la città italiana del vino, visto come lavoro, passione e cultura. Vinitaly trasforma Verona in una capitale dal 6 al 9 aprile 2025, per la sua cinquantasettesima edizione. Tralasciando la descrizione accurata dell’evento, che è composto da 18 padiglioni nei quali sono ospitate le regioni italiane, vorrei concentrarmi con te, Alessandro, sia su alcune novità di cui è impossibile non parlare, sia di termini del vino che non tutti conoscono e che chiedono un intervento esperto. Il primo, legato a un evento all’interno della fiera, è organizzato da Unione Italiana Vini e Vinitaly, ed è dedicato ai vini dealcolati italiani per esplorare nuove opportunità di mercato. Il termine dealcolato non si presta a fraintendimenti, si parla di prodotti analcolici, ma non avendone mai assaggiato vorrei capire qualcosa di più, sia come processo sia come effettivamente possano inserirsi in un mercato chiuso come il vino. Il vantaggio, viste le norme legate alla guida, sembra enorme.
Alessandro Fogli: «Intanto, un po’ di contesto: l’Oms ha rivisto il consumo sicuro di alcol a “zero bicchieri” al giorno, sempre più giovani (le ultime statistiche stimano siano il 50%) decidono di non consumare alcolici, e tra gli adulti sempre più bevitori abituali di alcol decidono di diminuirne la frequenza (pensiamo, negli Usa, ma ormai stanno prendendo molto piede anche da noi, ai patetici Dry January e ai Sober October, che tolgono ogni anno due mesi di consumo ai 12 totali). Dunque in questa attuale e diffusa disaffezione verso il vino, le etichette dealcolate potrebbero, secondo alcuni, rappresentare una boccata di ossigeno, anche in termini di semplificazione o soluzione agli ostacoli che la politica e la sanità stanno mettendo in atto per disincentivare il consumo di alcol e i problemi che ne derivano. Tuttavia: i consumatori che scelgono il dealcolato lo fanno anche perché vogliono consumare meno calorie, ma il vino dealcolato ne contiene molte, visto che per enfatizzare gli aromi che la dealcolizzazione fa perdere (e che la presenza di alcol potenzia nel bicchiere) si aggiunge zucchero, che si percepisce perfettamente al palato, creando quel contrasto dolce/acidulo tipico dei vini dealcolati. Aggiungiamo a questo il fatto che per arrivare al prodotto dealcolato occorrono macchinari molto costosi e un consumo molto più elevato di energia elettrica, cosa che è orrendamente anti-ecologica e decisamente costosa per il consumatore finale. Detto tutto ciò (il discorso sarebbe molto più lungo ma non ha senso parlarne troppo esaustivamente), per quanto mi riguarda il vino dealcolato è imbevibile, ma non perché sia cattivo (ma nemmeno così buono…), semplicemente è una bevanda senz’anima, che non dovrebbe per legge nemmeno potersi chiamare vino. L’alcol è l’anima del vino, è l’elemento che gli dà calore, che supporta l’imprescindibile spalla acida, che tiene insieme i meravigliosi equilibri gustativi. Il paragone che mi viene in mente è che bere un vino dealcolato è come fare sesso con una bambola gonfiabile invece che con una persona in carne e ossa. Quindi, per chiudere, se vuoi fare una bevanda che si richiami al fascino del vino per puri scopi commerciali, falla, ma vi confido un piccolo segreto: esiste già e si chiama succo d’uva».
FDT: Torniamo ai tradizionali vini alcolici, e a una tipologia che invece non rappresenta una novità, ma pur essendo una voce ancora di nicchia si sta lentamente inserendo nel mercato enologico: i cosiddetti vini Piwi, i vini frutto dei vitigni resistenti.
AF: «In effetti ultimamente si parla molto dei “vitigni resistenti”, o Piwi appunto (acronimo del tedesco Pilzwiderstandfähig, ossia resistente alle crittogame, e Winterhart, ossia resistenti all’inverno), varietà di vite che manifestano una resistenza particolarmente elevata alle malattie fungine. Questi vitigni sono incroci che furono sviluppati tra il 1880 e il 1935 in Francia, con l’obiettivo di combinare la resistenza alle crittogame e alla fillossera delle viti americane alle qualità enologiche delle varietà europee. L’obiettivo (non realizzato) era quello di creare delle varietà senza portainnesto, ossia “franche di piede”. Comunque, dopo decenni di selezioni, questi incroci fanno ormai parte a tutti gli effetti della specie Vitis Vinifera. Per la maggior parte i Piwi sono di origine tedesca perché negli ultimi anni è stata la Germania il paese più impegnato nella selezione dei vitigni resistenti ai funghi, seguita dall’Austria e dalla Svizzera. In Italia sono Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia a guidare la ricerca sui Piwi, e i maggiori vitigni resistenti nel nostro paese sono Bronner, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Gamaret, Helios, Muscaris, Johanniter, Prior, Regent e Solaris (il mio preferito). Queste varietà sono ammesse alla vinificazione ma non sono tuttora utilizzabili per la produzione di vini a denominazione di origine. La cosa per me interessante è che utilizzando i Piwi i viticoltori hanno la possibilità di evitare completamente i trattamenti fitosanitari. Questo non vuol dire che non possano sorgere problemi di altra natura, quali ad esempio virosi o insetti, ma comunque a oggi i vitigni resistenti offrono una buona soluzione per chi ricerca una viticoltura senza chimica».
FDT: L’Emilia-Romagna del vino è sempre presente a Verona nello storico padiglione 1, associato quest’anno, per la prima volta, al ristorante pluristellato per eccellenza nella nostra regione, La Francescana di Massimo Bottura che festeggia nell’occasione i 30 anni di attività. L’abbinamento cibo-vino è un tema affascinante e sconfinato, e il solo fatto di aver scomodato Bottura la dice lunga. C’è qualche piccolo accorgimento per iniziare questo percorso sconfinato? C’è una sorta di ABC iniziale che potresti suggerire, o è sempre e solo questione di gusti?
AF: «L’AIS, l’Associazione italiana sommelier, dedica tutto l’ultimo anno dei suoi corsi agli abbinamenti cibo-vino, e non a caso, visto che il matrimonio tra i due, quando è centrato, è davvero un’esperienza sensoriale di grande gioia. In questa sede non si possono prendere in esame tutti gli elementi e le caratteristiche, del vino e del cibo, che occorrerebbe considerare per un abbinamento perfetto, tuttavia almeno un paio di schemi di base ci vogliono, ad esempio quello che divide gli abbinamenti in contrapposizione e concordanza. Seguendo questo schema, ecco allora che ad alimenti che presentano grassezza, untuosità, sapidità, tendenza amarognola, tendenza acida, tendenza dolce e succulenza, si affiancherà un vino che le contrasta, mentre ad alimenti che hanno caratteristiche di dolcezza, speziatura, aromaticità e persistenza occorre abbinare un vino che rispetti questi tratti (l’esempio più immediato è quello dei dessert, che chiamano solo vini dolci, sia fermi che frizzanti). Da questa semplice divisione si apre l’infinito mondo degli abbinamenti, che va dalle differenze tra vini bianchi, rossi, rosati e bollicine alle mille possibilità all’interno delle varie categorie, vista l’ovvia differenza, ad esempio, tra un Pinot nero e un Sagrantino di Montefalco, o tra un Sauternes e un Barolo chinato».
E anche quest’anno, conosciamo tante cose in più su questo mondo. Arrivederci a Vinitaly e al prossimo appuntamento.