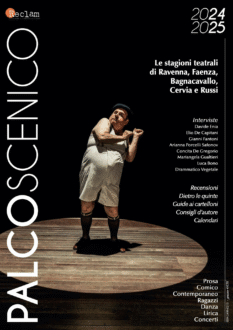Riparte martedì 18 febbraio il corso di Psicologia urbana Aps
«Aiutare le donne a riconoscere le dinamiche di potere in famiglia e nei luoghi di lavoro, fornendo loro strumenti per porre confini alle svalutazioni e disparità» è questo l’obiettivo del corso proposto dall’associazione Psicologia Urbana e Creativa Aps (in collaborazione con Casa delle donne e a Linea Rosa) che prenderà il via martedì 18 febbraio, dalle 18.30 alle 20.45 alla Casa delle Donne (via Maggiore 120).
Il ciclo si estenderà per i cinque martedì successivi, sempre allo stesso orario, per concludersi martedì 25 marzo. A settembre verrà lanciato anche un secondo corso, sempre dedicato alle donne.
Il corso, realizzato in compartecipazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune e sostenuto dai piani di Zona della Regione, è tenuto dalle psicologhe e psicoterapeute Giancarla Tisselli, Giulia Zannoni, Chiara Gnani, Serafina Lo Nigro. Uno degli obiettivi è il cambiamento delle relazioni di potere fra le persone al fine di rendere possibile una cultura della non violenza.
«Il percorso rivolto alle donne insegna a riconoscere il maltrattamento psicologico che si può manifestare attraverso critiche, ricatti, offese, ridefinizioni della realtà, commenti sul corpo della donna e sulla sua intelligenza – spiega il team di psicologhe – questo tipo di violenza è spesso volta a ferire l’identità della donna e ad abbassarne il potere e l’autostima, aiuta a trovare nuovi criteri per leggere la propria identità. Già dalle piccole prevaricazioni o svalutazioni ripetute si rischia di avviare un’escalation di prepotenza e di rabbia che invece potrebbero essere sostituiti da comportamenti alternativi alla violenza».
Verranno presentate tecniche per il riconoscimento e il contrasto della violenza domestica, a partire dall’ ascolto di sé, delle proprie emozioni e bisogni, per favorire modalità di comunicazione positiva, assertiva, empatica, e non violenta. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente indirizzo: psicologiaurbanaecreativaaps@gmail.com. La partecipazione ai corsi comporta un contributo di 10 euro per i materiali forniti e l’iscrizione a Psicologia Urbana e Creativa (10 euro).