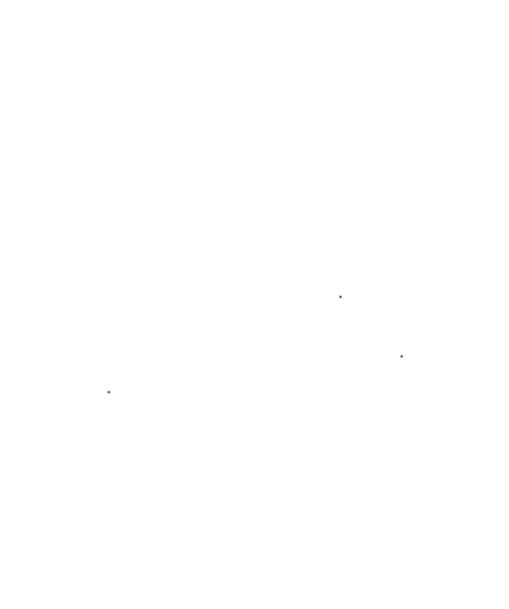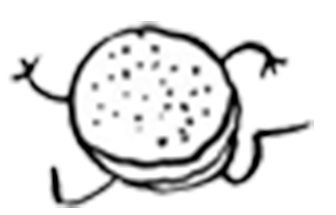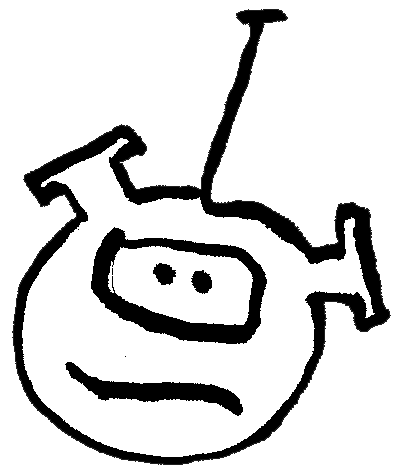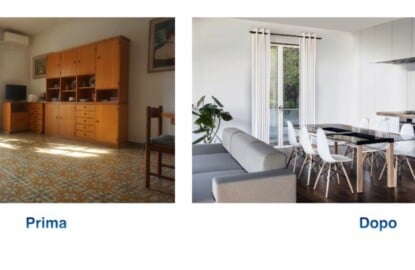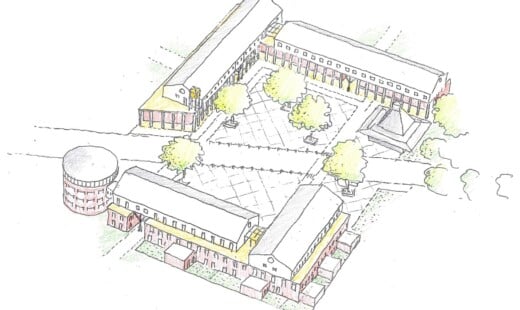«La missione non è finita. Ora dobbiamo tutti lavorare per fare in modo che chi è ancora imprigionato in Israele torni a casa». Sono le parole di Carlo Alberto Biasioli, il 39enne operatore culturale ravennate che ha partecipato alla Global Sumud Flotilla, portando da skipper la sua barca – la “Morgana” – a una cinquantina di miglia dalla costa palestinese. Lo contattiamo al telefono, il giorno dopo il suo ritorno in Italia. «Sono sconvolto per quello che è successo in queste ore a quello che è stato un mio compagno di cella, australiano: è stato picchiato e gli è stato strappato il passaporto in faccia. C’è ancora tanta gente imprigionata in balia di Israele, che può fare un po’ quello che vuole. Io, per esempio, sono libero per il rotto della cuffia: abbiamo firmato un documento in cui semplicemente chiedevamo di lasciare il Paese prima possibile, senza addossarci nessuna colpa, ma mi risulta che sia stato firmato da tutti gli italiani. Eppure, ne hanno liberati solo alcuni, me compreso, con una scelta del tutto casuale».
Come sei stato trattato durante la reclusione?
«Sono stati momenti molto brutti. D’altronde mi aspettavo cose brutte, ma non così tanto. Davvero situazioni preoccupanti, scandalose, indecenti dal punto di vista dei diritti umani. Ci è stato chiesto però dall’organizzazione della Flotilla di non rivelare troppi dettagli fino a che tutti gli attivisti non saranno liberati, per evitare ulteriori soprusi».
I parlamentari hanno dichiarato che vi avrebbero trattato come dei terroristi…
«Loro non possono saperlo. Sono stati trattati in modo molto differente da noi. L’unico politico che ha seguito un iter come il nostro è stato Paolo Romano. Gli altri sono stati subito rilasciati, mi sono sentito un cittadino di serie B. Credo sia stata un’ingiustizia. Mi aspettavo che i politici facessero da scudo a tutti gli altri, diventassero un simbolo, invece sono stati i primi a tornare in Italia».
Cosa resta di questa esperienza?
«Nessuno in passato era riuscito ad arrivare a 9 miglia dalla costa di Gaza, come c’è riuscita invece una barca delle nostra missione. Ma quello che davvero rimane è l’essere riusciti a svegliare la coscienza di così tante persone, vedere le manifestazioni in tutto il mondo, sentire la forza della gente che ci supportava. Anche al nostro arrivo a Malpensa, nonostante fossimo solo 7 (la maggior parte degli italiani è atterrata a Roma, ndr), abbiamo ricevuto un’accoglienza fantastica. Mi sono sentito molto amato e compreso. Era evidente che la Flotilla non potesse risolvere la questione palestinese, ma è stato un ottimo inizio e se continueremo a insistere potremo incidere ancora di più».
E le polemiche?
«Si è detto che non avevamo aiuti a bordo, cosa assolutamente falsa. Noi, in particolare, avevamo caricato gli scatoloni dalla ong Music for Peace. A chi parla sui social di “crociera” o di pubblicità credo non valga nemmeno la pena rispondere».
Durante il viaggio avete subito anche attacchi dai droni.
«È stato un viaggio molto duro, la notte dei droni è stata particolarmente preoccupante. Mai, naturalmente, mi era capitato di sentire granate esplodermi vicino, tre in totale. Molto pericoloso. Fortunatamente nessuno si è fatto male, anche se ci sono state persone stordite, che hanno riportato danni provvisori. Nelle notti successive ci siamo riparati in acque territoriali greche, per evitare ulteriori attacchi».
Qui alcuni hanno lasciato la missione. Ci hai pensato anche tu?
«Quando è sceso lo skipper della mia barca, in qualità di primo ufficiale, ho sentito la responsabilità di mettermi al timone da skipper e di portare avanti la missione. Sono riuscito ad arrivare a circa 50 miglia dalla costa palestinese e ne sono orgoglioso».
Com’è stato l’abbordaggio israeliano?
«Prima ci hanno intimato di fermarci, ma eravamo in acque internazionali e non ne avevano il diritto: abbiamo proseguito. Fino a che non si è approcciata a noi una nave militare molto grande, con svariati gommoni e motovedette, che ci hanno circondato. Erano le 2.30 di notte. Militari israeliani sono saliti a bordo e ci hanno puntato i mitra, hanno spaccato le telecamere e bloccato la connessione a internet: ci hanno preso prigionieri. I militari erano accompagnati da videomaker che hanno ripreso tutto e si sono mostrati premurosi di fronte alle telecamere, offrendoci cibo e acqua, che abbiamo rifiutato, essendo solo un gesto di facciata per il videomaker».
Poi cosa è successo?
«Siamo stati trasferiti dopo un viaggio di 12 ore al porto di Ashdod, dove abbiamo aspettato seduti sul cemento 4 ore sotto il sole, in attesa del ministro, che ci ha dato dei terroristi. Quindi ci hanno smistato nei vari centri di reclusione. Non ci hanno permesso di fare telefonate, né di richiedere un avvocato. Fortunatamente l’organizzazione della Flotilla aveva già firmato una procura con un gruppo di avvocati palestinesi che lavora in Israele e che ci ha assistito con grande competenza. Si sono presentati loro, senza bisogno di essere chiamati. Erano 15-16 persone, tutte molto preparate, in quel momento mi sono sentito protetto».
Hai mai avuto paura di non riuscire a tornare?
«Sì, ho avuto paura. Anche perché mancavano completamente le comunicazioni. Anche quando ci hanno portato verso l’aereo, siamo passati davanti a un carcere e ho avuto paura che ci stessero solo trasferendo. Siamo stati in 16 in una cella da 8, era una situazione davvero estrema. Anche quando ci hanno liberato, l’obiettivo degli israeliani era quello di umiliarci: l’unica cosa che mi hanno lasciato tra i miei effetti personali è il paio di mutande che avevo in cella. Ci hanno fatto andare via con tute da carcerati e ciabatte ridotte male. Dei vestiti nuovi ce li hanno consegnati in Turchia dei volontari che li avevano comprati per noi grazie a delle donazioni».
Cosa farai ora?
«Prima di tutto andrò a parlare ovunque per cercare di tenere alta l’attenzione sulla Flotilla fino a quando non saranno liberati tutti. Poi non lo so, di certo nulla sarà più come prima. Non avevo mai fatto attivismo, ma dopo aver visto quanto marcio c’è nel mondo, e quante ingiustizie, in futuro non potrà che continuare a fare l’attivista».

 Screenshot
Screenshot