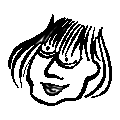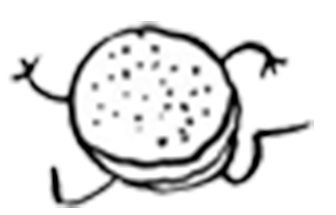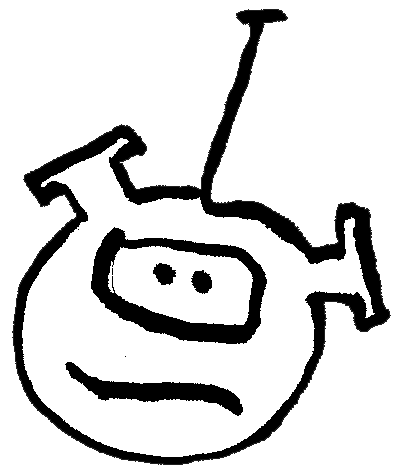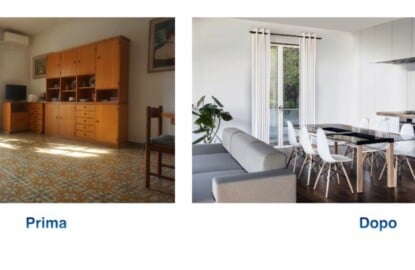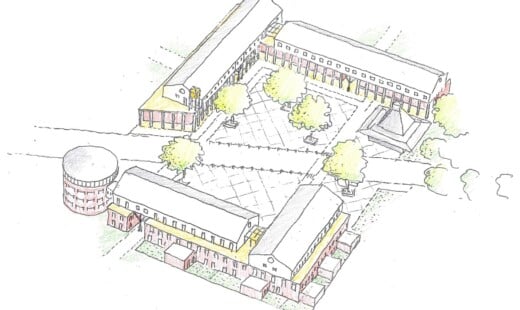La chiave che gira nella toppa dello studio del professore, un pomeriggio qualunque di una studentessa universitaria che si trasforma in un incubo. Letizia Venturini ha 25 anni ed è nata a Lugo. Qualche anno fa, la sua vita è cambiata a seguito delle violenze subite dal relatore della sua tesi in servizi sociali. Alla paura di denunciare si aggiunge il percorso giuridico che la porta a ripercorrere ancora e ancora quel giorno, poi il bisogno di ritrovarsi e un viaggio intorno al mondo che l’ha portata a una nuova consapevolezza: «Non ci si può far distruggere dal dolore, bisogna trasformarlo in qualcos’altro». Oggi ha «perso il conto» dei paesi visitati e la sua storia, raccontata in Quanto lontano dovrai correre (Mondadori) è la prima della collana Altrove, curata dallo scrittore Gianluca Gotto. Tra i suoi progetti, anche il podcast Souvenir «Nato per far viaggiare anche chi non può o per dare coraggio a chi vorrebbe farlo».
Venturini presenterà il suo libro d’esordio alla libreria Coop del Globo di Lugo, venerdì 28 novembre. In programma per il prossimo gennaio, anche una presentazione al Mercato Coperto di Ravenna.
Quanto lontano dovrai correre è una storia di rinascita, che parte però da un episodio di violenza. È stato difficile per lei metterlo su carta?
«No, anzi, possiamo dire che è stata la parte più semplice. Il dolore aveva bisogno di uscire e sapevo di star facendo qualcosa di utile per molte altre donne. La scrittura è sempre stata il mio sogno, è venuto quasi naturale».
Può raccontarci qualcosa di quel giorno?
«Sono state le sei ore più lunghe della mia vita. Tutto è cambiato in un secondo, una figura di riferimento, che rispetti e da cui ti aspetti protezione diventa il mostro. Mi ha avvicinata con gentilezza, illusa con prospettive di carriera e poi, una volta chiusi a chiave nel suo studio è iniziato l’incubo: insulti sul mio corpo, sulla mia personalità, la mia intelligenza. Tutto per affossarmi. Poi le molestie: la descrizione dettagliata dei suoi desideri sessuali, la normalizzazione di quella dinamica di abuso e potere che si era ripetuta su altre studentesse prima di me. Penso di aver scampato il peggio solo perché a causa di un’operazione era impossibilitato a spingersi oltre. Trovare la forza per parlarne subito è stato fondamentale».
La denuncia ha dato il via alla fase legale. Come si è conclusa?
«Il percorso giudiziario è durato circa un anno. Se confrontato a quello di altre donne è stato breve, ma comunque doloroso. Raccontare ogni volta la storia mi obbligava a riviverla. Questo mi ha permesso di metabolizzare i fatti, ma è stato difficile. La vicenda si è chiusa con un patteggiamento. Il professore ha perso il lavoro ed è stato allontanato dall’università. La sentenza è stata di 1 anno e 8 mesi con condizionale della pena. Per me ho chiesto il risarcimento minimo, a patto che risarcisse anche tutte le altre donne apparse come testimoni».
Cosa significa per lei aver pubblicato la sua storia il 25 novembre, nella data simbolo della lotta alla violenza sulle donne?
«Significa che una speranza c’è. Non ho voluto scrivere un libro sulla violenza, perché non voglio una visione negativa e non voglio dare a “lui” ulteriore importanza. Volevo trasmettere un messaggio di speranza, per far capire alle donne che non sono sole e che dalla violenza si può uscire. È stato un collettivo di donne a salvarmi. Della polizia non mi davo, avevo paura che non mi credessero. Così ho trovato il collettivo, conosciuto le storie delle altre donne e realizzato che quello che mi era successo era reale, non avevo esagerato e la colpa non era mia. Credo che un mondo senza violenza sia utopico. Spero però che tutte le donne riescano a trovare e dimostrare la propria forza e sappiano che luoghi di aiuto e ascolto esistono e sono lì per loro».
Questo episodio di violenza è stato anche la spinta per iniziare a viaggiare. Che tipo di motivazione le ha dato?
«Ero un foglio bianco, avevo bisogno di riscrivere la mia storia. La violenza ha segnato un prima e un dopo: prima c’era la laurea alle porte, progetti per il futuro, sogni e lavoro. Dopo, la perdita della prospettiva, l’annullamento del rapporto con il mio corpo, con le parole del professore ancora impresse in testa, la fame emotiva e le abbuffate. Volevo lasciare l’università, tanto quegli studi non mi sarebbero più serviti a niente, ma non volevo che si prendesse anche quella parte di me. Mi sono laureata e sono partita. Ho sempre amato viaggiare e cercavo un modo per ricostruirmi attraverso nuove esperienze e allonarami da una dimensione in cui agli occhi di tutti ero solo la vittima del mostro».
Nel suo libro però spiega che non sono i viaggi a far ritrovare sé stessi, ma un lavoro personale e introspettivo.
«I viaggi sono uno strumento di crescita, e spesso velocizzano il processo di guarigione. Ma tutto parte dalla consapevolezza: non serve andare dall’altra parte del mondo per ritrovarsi e non è detto che una volta che si è dall’altra parte del mondo ci si ritrovi. È la consapevolezza con cui parti, o con cui resti a casa, a fare la differenza. Certo, a casa è più difficile, perché il viaggio stimola, mette in gioco, offre esperienze diverse e tiene sempre sull’attenti. Viaggiare in solitaria, poi, porta a misurarsi con sè stessi e a cercare non solo il bello, ma anche la propria interorità: diciamo che è più facile ritrovarsi tra templi, ashram e curandele che su una spiaggia paradisiaca di Bali…».
La carriera da travel blogger come e quando è iniziata? E i viaggi organizzati?
«Nel tempo, e per caso. Non chiamatemi travel blogger però, credo che quel ruolo non mi rispecchi. Ho iniziato a postare sui social per tenere aggiornati amici e parenti. Qualche video è diventato virale e le altre persone sono arrivate in modo inaspettato. Credo che a colpire sia stata la mia spontaneità e lo sguardo genuino sul mondo. Quando ho visto i numeri crescere ho pensato di diventare una blogger, ma quel tipo di narrazione non mi appartiene. Il messaggio che voglio lanciare non è quello del “viaggio rivelatore” nel luogo da cartolina. Anzi, ho sempre viaggiato all’arrembaggio, in maniera molto “local” e questo ha incuriosito le persone che mi seguono. I viaggi organizzati sono nati così, dalla richiesta di chi voleva viaggiare con me e come me: tempi lenti, luoghi lontani dal turismo di massa, sostenibilità. Non ci sposta ogni due giorni alla ricerca dello scatto perfetto, ci si ferma in luogo, si conosce la gente del posto e si aiuta come si può».
L’incontro con Gotto invece com’è avvenuto?
«Con Gianluca si è creata una bellissima connessione, anche qui in modo casuale. Ho iniziato a leggere i suoi libri anni fa, proprio dopo la violenza. Cercavo qualcosa che mi facesse stare meglio. Una sera però gli ho scritto su Instagram, arrabbiata: le sue parole erano bellissime, ma come si fa a seguirle quando si sta così male? Lui mi ha risposto che quello che mi è successo non è bello, ma non posso cambiarlo. Posso cambiare solo quel che viene dopo. In quel momento inviai la richiesta di passaporto e decisi di laurearmi il prima possibile. Qualche tempo dopo, il destino ha fatto sì che ci incrociassimo in Thailandia, per il tempo di un pranzo. Lui ha preso a cuore la mia storia, e quando ho iniziato a scriverla l’ho contattato per dirglielo. Mi ha risposto che avrebbe voluto chiedermelo lui stesso. Così si è chiuso il cerchio»