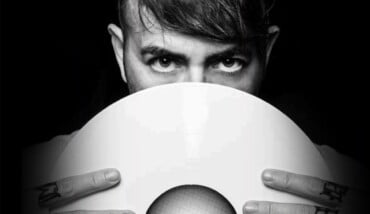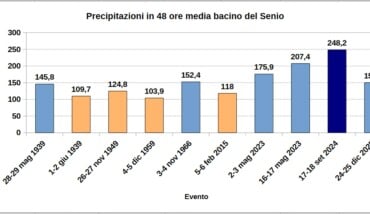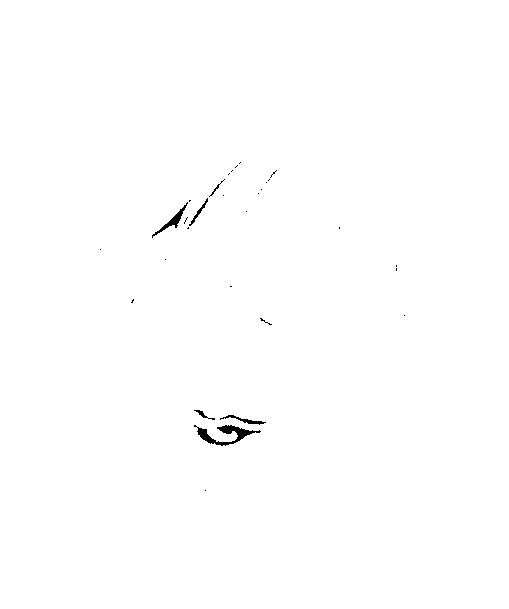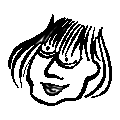Formatasi tra teatro e filosofia, Maia Cornacchia lavora da quasi 25 anni a stretto contatto con la Fondazione Gigi Ghirotti di Genova che offre assistenza gratuita, cure palliative domiciliari e in hospice ai malati terminali. «Ho scelto di occuparmi di chi muore dopo la morte di mio padre – racconta Cornacchia –. Non mi sentivo pronta, e ascoltavo solo il mio dolore. Poco prima che se ne andasse però, sono riuscita ad ascoltare davvero lui che, a differenza mia, era pronto. Ho sentito il bisogno di spiegare a tutti l’importanza di ascoltare chi muore, non solo per loro, ma per noi». I suoi insegnanti più grandi però, «sono stati i bambini», con cui ha portato avanti percorsi di drammatizzazione e animazione teatrale in ambito scolastico. Le sue ricerche filosofiche hanno portato nel 1985 alla creazione della Pratica di Lavoro Organico: un esercizio di ascolto e contatto col presente. La filosofa è stata protagonista di un incontro alla Biblioteca Oriani di Ravenna, lo scorso 22 novembre, in occasione dello spettacolo sul fine vita I’m nowhere / Desvanecimiento, del polacco Rakowski.
Cosa si può imparare dal lavoro con i malati terminali?
«A vivere. Può sembrare un pensiero banale, ma stare vicino a chi muore, e imparare ad ascoltare davvero chi muore, è il modo più chiaro per vedere l’intreccio indissolubile tra vita e morte. Tutto il mio lavoro si basa sul “sentire”: ognuno di noi è unico e irripetibile come una goccia, ma in quanto goccia fa parte di qualcosa di più grande, come l’acqua. In quella dimensione, l’io e l’altro diventano un’unica cosa. Da questo punto di vista, credo che i bambini piccoli siano stati i miei migliori maestri, ancora poco formati come individui singoli e impercettibilmente legati a quell’insieme. In questa prospettiva, un malato terminale assomiglia a un bambino piccolo: si allontana dalla dimensione fisica della vita per avvicinarsi a quella più sottile, invisibile».
La società di oggi sta cercando di allontanare la morte?
«Assolutamente sì, c’è una grande rimozione della morte. Non ci sono più situazioni di condivisione della morte al di fuori dei funerali. Anche su quelli poi, vigono ancora troppi tabù: un funerale dovrebbe essere un momento di alternanza tra gioia e dolore, senza regole e con spazio per tutto: lacrime e risate, bello e brutto, così come accade dentro ognuno di noi. Si tende a scacciare la morte solo perché non la si vede nel suo intreccio con la vita. Si pensa alla morte come un’unica tappa alla fine della vita, ma non è così. Quella è solo una delle sue manifestazioni, ma si tratta di un’esperienza continua, che spesso non riusciamo a leggere. Anche le parole nascono e muoiono nel momento in cui le pronunciamo: se la nostra ultima parola non morisse, non ci sarebbe spazio per quella dopo. Fare spazio alla vita è una delle funzioni principali della morte».
Quanto influisce il contesto culturale sul tema del fine vita?
«Sicuramente siamo tutti molto condizionati dal contesto culturale in cui siamo immersi. Citando Jung, è più facile attenersi a quello che è stabilito e considerato “bene” o “male” per tutti, piuttosto che prendere ogni volta la responsabilità di interrogarsi al riguardo. Vivere senza costrutti, come un bambino, ci renderebbe la vita più semplice».
I bambini, quindi, sarebbero più pronti ad affrontare il tema della morte rispetto agli adulti?
«Assolutamente sì. Al tempo stesso però, sono dipendenti da noi e sensibili ai nostri stati d’animo. Tendiamo a passare loro una serie di condizionamenti pesanti, spesso in buona fede. Capita che quando un bambino perda un genitore non lo si porti al funerale o si eviti di parlare del lutto in maniera approfondita. Sono gesti fatti con un intento di protezione, ma sortiscono l’effetto contrario, lasciando i più piccoli soli col proprio dolore».
Esiste un modo giusto per affrontare l’argomento?
«Trovo che termini come “giusto” o “sbagliato” siano troppo stretti rispetto alla ricchezza della vita. Anche qui, l’ascolto è fondamentale. Il fulcro del mio lavoro è quello di far ritrovare la percezione di essere goccia nell’acqua. La prima lezione della morte è quella di lasciare andare: secondo i nativi americani, chi è su un cammino di consapevolezza non dovrebbe avere “aspettative, attaccamenti o giudizi”. Spesso ci attacchiamo alle cose anche se non ci danno più vita, e non ci fa bene. In ne, bisogna imparare ad accogliere il dolore, perché l’unico modo per sentire davvero la gioia è attraversarlo, e imparare a ritrovare lo straordinario nell’ordinario».
Il teatro fa bene ad approcciarsi a questi temi?
«Deve farlo. Più interagiamo con la morte, più sarà facile correggere la brutta abitudine di rimuoverla dalle nostre vite. Avere a che fare con la morte aiuta ad apprezzare il valore della vita, e anche invecchiare può diventare un cammino di libertà. La paura di morire è la madre di tutte le paure: è paura dell’ignoto, dell’incontrollabile. Ma stare insieme alle proprie paure è l’unico modo per trasformarle in forza, e questo i teatranti lo sanno bene, perché spesso è ciò che trasmette energia sul palco. Abitare la nostra paura e famigliarizzare con la morte rende tutto più facile».
E per quello che riguarda chi resta invece?
«In effetti, la morte riguarda soprattutto chi resta. Come scrive Epicuro, non ha senso preoccuparsi della propria morte: quando c’è lei non ci sei tu, e viceversa. La sofferenza spaventa di più, ma le cure palliative hanno raggiunto livelli eccezionali. Elaborare il lutto è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticarci che la luce delle stelle che vediamo viene da astri morti milioni di anni fa. Lo stesso vale per le persone che non ci sono più, ma che continuano a illuminare le nostre vite, in modo del tutto soggettivo. C’è chi ha la sensibilità per percepire una presenza sottile e chi le porta ogni giorno con sé, tra mente e cuore».