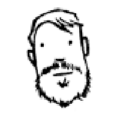Un paio di mesi fa, nel corso di una ricerca sul collezionismo d’arte romagnolo fra ‘600 e ‘800, ho come al solito preventivato un passaggio all’Archivio Piancastelli di Forlì: una tappa praticamente obbligata per chi fa ricerca in Romagna, data la mole preziosa del materiale qui raccolto. Prenoto la visita – perchè, come si dirà, lo spazio per i ricercatori è talmente ridotto che senza avviso si rischia di fare un giro a vuoto – e, come spesso mi è accaduto, fra le carte forlivesi faccio un bingo perfetto. Con gioia mi ritrovo fra le mani un memoriale manoscritto di 50 pagine della metà dell’Ottocento che racconta con dovizia di particolari quanto accaduto durante il passaggio delle armate napoleoniche a Ravenna, le lotte per il potere locale, i retroscena dei personaggi politici ravennati più influenti visti dagli occhi di un semplice cittadino e non dalle “veline” autorizzate dell’epoca, e soprattutto scopro dove è finita una bella collezione di dipinti creata da un sensale di Ravenna, un piccolo borghese di assoluta fede giacobina, salito alla ribalta cittadina come mangiapreti e poi caduto in disgrazia.

L’episodio di ricerca, i cui frutti sono stati utilizzati per un bel convegno presso il Dipartimento dei Beni Culturali di Ravenna, è stato l’ultimo di una serie di felici ritrovamenti nel corso di varie ricerche che mi hanno confermato – e non solo a me – la ricchezza e l’assoluta importanza di questa raccolta, creata nel corso di una vita da Carlo Piancastelli.
Ospitato al primo piano della Biblioteca Saffi di Forlì in Corso della Repubblica, negli ultimi anni l’Archivio è balzato alle cronache italiane a causa del crollo del soffitto di un una stanza nell’inverno del 2012, ma prima di seguire le solite sventure che (s)finiscono il patrimonio italiano e capire gli sviluppi attuali di questa vicenda, vale la pena spendere due parole per comprendere di cosa stiamo parlando.
Carlo Piancastelli (1867-1938) nasce a Imola da un’agiata famiglia di proprietari terrieri di Fusignano: già prima di laurearsi a Roma in Giurisprudenza nel 1888, si palesa in lui il genio insano che colpisce tutti i veri collezionisti. La malattia della raccolta lo porta prima ad interessarsi di monete – e di fatto getta in quegli anni le basi per una raccolta numismatica oggi riconosciuta a livello internazionale – poi a dilagare verso libri, documenti, disegni, cartoline, manoscritti e carte a stampa, lettere e incisioni. L’unico limite concesso è l’argomento “Romagna” che può essere incrociato nelle sue raccolte in ogni senso spazio-temporale. Non importa chi, quando, dove e perché, al collezionista importa piuttosto che si tratti di materiale prodotto, scritto o semplicemente riferito alla Romagna, sia nel caso di una produzione di alto livello culturale che relativa alla vita quotidiana e popolare. L’eccezionalità della raccolta è tale che Dino Campana la definisce «un patrimonio che da solo rappresenta buona parte di ciò che in Italia e fuori fa testimonianza della storia e della cultura della nostra regione».
Non importa quindi la tipologia dei materiali – oltre ai libri e alla documentazione ci sono anche spartiti musicali, ritagli di giornale, ceramiche e dipinti –, non importano forse neanche i modi di acquisizione del patrimonio: oltre al materiale acquistato inizialmente a Roma durante le grandi aste pubbliche di alcuni archivi nobiliari e poi nel tempo presso librai e antiquari in Italia e all’estero, a Ravenna c’è chi giura che Piancastelli abbia sottratto alcuni documenti anche alla Biblioteca Classense.
Sospendiamo il giudizio e l’accusa per seguire invece le sorti della raccolta. Arriviamo quindi agli anni ‘30, quando Piancastelli decide che tutto il frutto della sua passione, stipato ordinatamente fra il primo e il secondo piano del proprio palazzo privato di Fusignano, deve confluire in un luogo pubblico. Viene contattata prima la stessa Biblioteca Classense ma i rapporti che intercorrono fra Piancastelli e i gerarchi fascisti di Ravenna, che malignano sulla sua vita privata, mandano a monte il progetto. Quindi, par spét – per dirla alla romagnola – il bibliofilo si rivolge alla concorrenza e tutto quel ben di Dio passa alla biblioteca comunale di Forlì: prima un paio di sezioni nel 1933, poi il grosso della raccolta dopo la sua morte, avvenuta il 19 febbraio 1938.
Passiamo ai numeri da bibliofili intersecandoli con la tipologia delle sezioni: parliamo di un fondo librario di circa 55.000 volumi di varie epoche (nota come Biblioteca Romagnola) arricchito da manoscritti, ceramiche, cartoline, monete, incisioni, dipinti, spartiti musicali che vanno dal XII al XX secolo, oggi allestiti e sorvegliati con cura dalla conservatrice Antonella Imolesi in alcune sale del piano superiore della Biblioteca Saffi, ospitata nel settecentesco Palazzo del Merenda.
Più di 173.000 documenti fra pergamene, ritratti incisi, autografi e disegni, ritagli di giornale e opuscoli fanno parte delle Carte Romagna, sistemate in 708 cassette dove potreste imbattervi in alcune opere manoscritte del poeta Vincenzo Monti, negli archivi dei papi cesenati Pio VI e Pio VII, in quelli degli incisori settencenteschi Francesco Rosaspina e Luigi Rossini o del pittore faentino Tommaso Minardi; sempre dentro alle cassettiere giacciono documenti di musicisti come Arcangelo Corelli e Gioacchino Rossini, perfino una lettera di Leibniz. Nella Sezione Autografi suddivisa in due macroaree temporali, sono conservate complessivamente più di 50.000 carte manoscritte da personaggi non romagnoli fra cui Machiavelli, Lucrezia Borgia, Tasso, Voltaire e Rousseau, fino a personalità quali Alfieri, Leopardi, Manzoni, a musicisti come Verdi e Puccini, e politici del calibro di Napoleone e Cavour. A queste sezioni vanno ad aggiungersene altre dedicate alla Musica – con spartiti di Rossini e Corelli –, ai Manoscritti composti da cronache delle città romagnole dal Medioevo all’Ottocento, agli Stampatori, comprendenti rari incunaboli italiani e quasi 700 volumi prodotti in Romagna. 20.000 sono invece le stampe e i disegni che costiuiscono una sezione a sé stante, che comprendono stampe devozionali e satiriche, mappe, carte geografiche, materiali iconografici legati a luoghi e città romagnole e infine ritratti di personaggi del territorio, mentre più di 35.000 sono le Cartoline, legate sempre come il resto del materiale al territorio. Chiudono la raccolta il monetiere composto da oltre 5.000 monete in prevalenza della Roma imperiale, una discreta quadreria con ritratti di personaggi romagnoli e opere eseguite da autori antichi come i Ramenghi padre e figlio, il ravennate Luca Longhi o l’imolese Innocenzo Francucci, oltre a ceramiche, sete dipinte e sigilli, pergamene e miniature, ex libris, biglietti da visita, terracotte e gessi. Per chi conosce l’importanza degli archivi basti dire che Piancastelli riuscì ad acquistare gli archivi della famiglia Spreti di Ravenna o di personaggi come Francesco Miserocchi, collezionista ravennate di documenti risorgimentali, e raccolse documenti appartenenti alle grandi signorie rinascimentali della Romagna – i Manfredi, i Malatesta e gli Sforza – con prolungamenti fino ai Bentivoglio di Bologna.
Sopra la dott.ssa Antonella Imolesi Pozzi, responsabile dei Fondi Antichi, Manoscritti e delle Raccolte Piancastelli e una serie di volumi dedicati ad alcune collezioni artistiche e documentarie presenti nelle Raccolte Piancastelli
Terminata la lunga sfilza numerica che ben rende la vastità e la ricchezza del patrimonio, occorre passare alla cronaca più recenti: il 29 novembre 2012, il soffitto della Sala dei rari della Piancastelli implode a causa di infiltrazioni e cedimenti della struttura causati dalla forte nevicata dell’inverno precedente. Nonostante l’inoltro di varie segnalazioni di crepe e cadute di calcinacci, soprassedendo a un soffitto puntellato e un progetto di ristrutturazione già deciso ma rimasto à la carte, il mancato intervento causa il crollo del controsoffito: per fortuna, questa “cronaca di un crollo annunciato” non fa vittime fra i presenti e non causa danni al patrimonio. Nella distrazione della stampa nazionale – occupata dai grandi saccheggi e disastri delle biblioteche dei Girolamini di Napoli, dell’Universitaria di Pisa e dell’Istituto degli Studi filosofici di Napoli – sulla Soprintendente ai Beni Librari della Regione, sull’ex sindaco di Forlì Roberto Balzani e sul suo assessore alla Cultura Patrick Leech iniziano a piovere le lettere degli archivisti, dei bibliotecari e degli studiosi di tutto il mondo per sollecitare la cura della collezione e il ripristino degli spazi: la risposta lapidaria di Leech è che il crollo non era prevedibile (sic) e che “non ci sono soldi”. L’affermazione fortunatamente viene controbilanciata dall’impegno per restaurare i danni circoscritti all’area e la chiusura dell’archivio si prolunga fino all’aprile 2014, quando Balzani – ormai a fine mandato – dichiara ufficialmente che «le tre sale più preziose del nostro diamante patrimoniale sono restituite alla città, ai funzionari preposti e agli studiosi», aggiungendo che però «molto resta ancora da fare».
A maggio dello stesso anno il nuovo sindaco di Forlì, Davide Drei, candidato del Pd sostenuto da varie liste civiche, sceglie una Giunta dichiaratamente rosa fra cui si distingue la nuova assessora alla Cultura – Elisa Giovannetti – una quarantenne estranea alla politica ma con le carte in regola per gli incarichi che va a coprire: Laurea in Scienze della Comunicazione, diploma di archivista e Master in Conservazione e gestione delle raccolte e collezioni in archivio e biblioteca, con varie esperienze di lavoro in archivi di varie città della regione. Quello che convince è l’attivazione di un progetto per la riqualificazione delle biblioteche di Forlì, senza dimenticare il Fondo Piancastelli e la parte storica della Saffi, e la ristrutturazione complessiva del Palazzo del Merenda sulla base di un piano economico quinquennale fra i 3 e i 5 milioni di euro, sostenuto sia da finanziamenti diretti del Comune per 500mila euro all’anno che da fondi strutturali europei. L’idea è buona, il progetto appare credibile e ben pianificato, con scadenze che sembrano realistiche, ma …C’è sempre un “ma” quando in Italia si parla di cultura. Anche se a questa parola non si mette mano alla pistola come sosteneva qualche nazi, in realtà basta molto meno. Notizia shock di inizio giugno giugno 2016: in conferenza stampa il sindaco Drei revoca tutte le deleghe ai suoi otto assessori, fra cui quella della Giovannetti. Senza entrare in merito ai motivi della grave crisi del governo cittadino, va da sé che non possiamo non veder allontanarsi il progetto della Biblioteca, il recupero di Palazzo del Merenda, il ruolo nuovo dell’Archivio Piancastelli, che dopo tre anni e mezzo ha ancora un accesso su prenotazione, due-tre posti al massimo per i ricercatori, un accesso che pare una gara al giro dell’oca e – senza nulla togliere alla professionalità e gentilezza del personale che vi lavora – un servizio nettamente sottodimensionato rispetto alle necessità dell’utenza e all’importanza della raccolta.
(… ma Piancastelli, avrebbe fatto meglio a scegliere la Classense?).