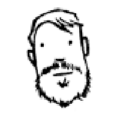«La Bellezza di un libro come oggetto non può prescindere dal suo contenuto. Non c’è infatti sopruso maggiore di un libro stupido rilegato lussuosamente»
Ennio Flaiano, Appunti, 1950-1972 (postumo, in Diario degli errori)
Collezionista e editore, Danilo Montanari opera nel mondo dei libri dal 1980. Ha pubblicato centinaia di volumi, in gran parte di arte
contemporanea, con una particolare attenzione ai libri d’artista. Nel 2013 l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna ne ha ospitato la collezione, una ricca documentazione della storia del libro d’artista dagli anni ’60 a oggi ed anche del suo sodalizio con Giulio Paolini. Il catalogo Una biblioteca d’artista. La collezione e le edizioni di Danilo Montanari, stampato in quell’occasione, oltre a un testo di Maura Picciau, direttrice del Museo nazionale delle tradizioni popolari di Roma, contiene una serie di contributi sul tema, alcune testimonianze autografe e progetti di artisti con i quali Danilo Montanari ha collaborato nel corso del tempo.
«La nascita del libro d’artista si situa all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, quando le avanguardie, forti delle esperienze futuriste di Fortunato Depero e Tullio d’Albisola e dei poemi-oggetto surrealisti e dada degli anni Venti e Trenta, nel rifiutare il concetto elitario del capolavoro come oggetto unico, scelsero di utilizzare i mezzi di comunicazione di massa: fotografia, grafica pubblicitaria, fotocopia, video. Tale nuova configurazione del libro venne esplorata contemporaneamente in Europa e in America […] e portò in tempi brevi all’azzeramento della realtà dell’oggetto in favore dell’enunciazione concettuale, come nel caso delle cento pagine bianche di Piero Manzoni […]. L’apparizione del libro d’artista […] va annoverata tra i sintomi di una esigenza di confronto fuori dalle istituzioni e dal circuito delle gallerie. Scelto dapprima perché non usurato, il supporto libro è stato inteso nei successivi sviluppi quale sede di progetti innovativi per materiali e tecniche» (Antonio Mustari, Libro d’artista contemporaneo, in Il libro d’artista, a cura di Giorgio Maffei, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003, pp. 119-120). Il libro d’artista, per potersi studiare e tramandare, necessita di editori, mercanti, collezionisti, conservatori e divulgatori. In Europa e nel mondo sono diversi gli eventi che offrono occasione a collezionisti e bibliofili d’incontrarsi e aggiornarsi in merito alle proposte degli editori e degli artisti.
Di seguito l’intervista a Danilo Montanari, al quale ho chiesto di raccontarmi alcuni suoi momenti di vita.
«Sono nato a Marina di Ravenna negli anni Cinquanta, periodo in cui in quel territorio presero avvio importanti cambiamenti. Sono cresciuto nell’ultima strada a ovest di Marina, poco distante dal Marchesato, in una piccola costruzione vicino a dove una volta c’era l’Ospedaletto; a duecento metri un boschetto, a est il mare. Quello era tutto il mio mondo, chiuso, ristretto, protetto. In quegli anni ho ascoltato storie legate al paese, al mare e alla costa: siamo gente che naviga sotto riva, per non perder l’orientamento. A quei tempi il mercato del pesce di Marina era il più importante di tutto l’Adriatico, un vero spettacolo che si riproponeva tutti i pomeriggi. Nel tempo sono poi avvenute diverse trasformazioni e, tra queste, la più significativa è stata, negli anni Sessanta, la costruzione delle due dighe foranee. Più o meno nello stesso periodo, in paese, Michelangelo Antonioni girava alcune sequenze del film Il deserto rosso, tra le fabbriche e i capanni della palizzata. Sono gli anni in cui anche Pasolini rimase affascinato, forse turbato, da quel paesaggio violento e turbinoso. Una storia che mi ha segnato: penso che attorno a Marina si giochino le sorti di Ravenna. Il modo in cui s’interviene su Marina di Ravenna è indicativo per comprendere il destino della città. Prendiamo ad esempio la così detta “palizzata” di Marina che si è evoluta nel corso del secolo passato da “palè”, intricate palafitte di legno che sostenevano un tavolato, all’attuale lunga strada in mezzo al mare, una portaerei in cemento non ancora restituita alla vita con un progetto d’arredo e per la quale mi prendo il merito, se così si può dire, di aver fatto mettere, almeno, le panchine. E poi c’è tutta la questione di Marinara, emblematica per leggere anche le vicende politiche e gli intrecci di potere di Ravenna negli ultimi decenni, se mai qualcuno vorrà occuparsene. “Non si uccidono così anche i cavalli?”.
Giunto al Liceo, inizia la mia frequentazione di Ravenna, un passaggio difficile perché non mi sono mai sentito cittadino. Sono gli anni in cui mi avvicino alla politica come molti della mia generazione, dapprima con gli anarchici di “Umanità nova”, poi, negli anni Settanta, inizia la mia esperienza con Lotta Continua, vissuta con passione fino al 1976. Un periodo altamente formativo fatto di conoscenze affascinanti, di realtà e di persone, una scuola di valori che consentì di acquisire competenze nel campo della comunicazione e delle relazioni. Eravamo convinti che la classe operaia fosse al centro del progresso – e forse lo era – ma le cose sono cambiate rapidamente. Di pari passo frequentavo il Bar Mosaico. Una fase tumultuosa e controversa della mia vita per la diversità e qualità di relazioni che si potevano instaurare. In quel luogo d’incontro frequentato da giovani donne e giovani uomini, si radunava una sorta di umanità popolare, intellettuali, operai, studenti con un’egemonia culturale della sinistra rivoluzionaria, aperti tuttavia a sollecitazioni diverse e con una buona dose di tolleranza per tutte le diversità. Il venerdì sera, studentesse e studenti universitari fuori sede tornavano in città e portavano al bar i loro racconti facendo sì che idee diverse e innovative s’incrociassero, rendendo quel luogo uno spazio d’impegno oltre che di divertimento. Di lì passavano tutte le storie, nel bene e nel male. Dal 1977, poi, fino al 1983, ho abitato in una sorta di comune in via Salara. Eravamo quattro nuclei, con spazi riservati e spazi comuni, era un luogo aperto sempre affollato.
In quegli anni mi mantenevo agli studi lavorando d’estate come bagnino di salvataggio, esperienza durata per un decennio. Erano tempi in cui fare il bagnino era rischioso. Oggi s’impara a nuotare dall’infanzia in piscina, allora solo la gente di mare sapeva nuotare. Era ancora un’epoca pionieristica. Alcuni tra i più esperti erano pescatori e poi c’eravamo noi studenti, ma cresciuti sul mare, legati da amicizia e spirito di solidarietà con quel tanto di sfrontatezza verso la vita che trasformava ogni giornata in qualcosa da ricordare. E così è, infatti, per noi, ancora oggi. Poi la sera si andava allo Xenos o al Joly (volgarmente “e’ giolli”), senza pagare perché in qualche modo eravamo un’attrazione.
La mia attività professionale si è concretizzata in modo inaspettato: da ragazzo avrei voluto fare prima il marinaio e poi lo scrittore. Per quanto riguarda il marinaio mi sono fermato a bagnino… A scrivere ho anche provato, ma ho capito ben presto che non avrei avuto la tenuta per farlo e neanche il talento necessario. Ho iniziato l’avventura di editore perché ero affascinato dal mondo dei libri, anche se non mi aspettavo che sarebbe diventato il lavoro della mia vita. Penso di aver avuto molta fortuna e sono riconoscente a Massimo Casamenti, col quale ho condiviso esperienze professionali importanti, dal laboratorio della cooperativa Supergruppo alla Casa Editrice Essegi, e a Giulio Guberti, critico d’arte e scrittore, per avermi introdotto in questo mondo. Non di meno sono riconoscente ad Alvaro Becattini che m’insegnò a pensare i libri d’artista. Io di mio sono abbastanza avventuriero, una caratteristica che nel mondo dell’editoria aiuta; ho dovuto cercare strade sempre nuove e fortunatamente le ho trovate con esiti anche significativi, così almeno credo. Artisti come Mario Schifano, Giulio Paolini, Maurizio Cattelan, o l’antiquario Giorgio Maffei, sono persone che ho frequentato a lungo e che, oltre ad avermi regalato la loro amicizia, mi hanno permesso di aprirmi ad altre relazioni introducendomi in ambienti davvero lontani dalla casa di via Garibaldi. L’arte è una zona franca, si lavora spesso nell’effimero, i valori e le tendenze cambiano con estrema rapidità e si devono sapere cogliere in anticipo le nuove direzioni; nel contempo, è necessario valutare cosa sarà recuperato dal passato.
Nei primi anni dell’attività editoriale ci si occupava prevalentemente di cataloghi di mostre – era il periodo d’oro degli assessorati alla cultura. Iniziative spesso fini a se stesse, grande clamore all’inaugurazione delle mostre, poi il silenzio e la rimozione, con la rara eccezione delle tre, quattro esposizioni che hanno fatto epoca.
Di gran lunga più interessanti le edizioni d’artista, che sono, esse stesse, opere, in genere firmate e numerate. A volte possono essere anche un oggetto unico (unique).
Negli anni, l’attenzione verso queste produzioni artistiche di nicchia è cresciuta ed ha una sua presenza stabile anche nelle fiere d’arte. In Italia, solo in questi anni si sta costruendo un collezionismo privato. In altri Paesi, in particolare negli Stati Uniti e nel nord Europa, questo processo è stato avviato da molto più tempo.
Nei grandi musei internazionali, dal Centre Pompidou di Parigi allo Stedelijk di Amsterdam, dal MoMA di New York al Moderna Museet di Stoccolma, si possono trovare importanti raccolte di libri d’artista e questo consente di poter fare anche ricerca. Il maggiore evento dedicato a questo genere di opere d’arte si tiene a ottobre al PS1 di New York ed è l’Art Book Fair: una fiera di editori e di librai antiquari con circa trecento espositori da tutto il mondo alla quale partecipo ormai da diversi anni.
Ci tengo particolarmente a citare un evento culturale curioso e al tempo stesso di qualità che si svolge a Ravenna da alcuni anni: il Festival dell’editoria indipendente “Fahrenheit 39”, curato dall’Associazione Culturale Strativari. Un appuntamento di livello internazionale, per professionisti, ricercatori e operatori del settore e che mantiene una propria identità di ricerca attraverso un rigore curatoriale e una forte impronta sperimentale.
Riguardo alla politica culturale della città, dalla quale, trovandomi spesso fuori Ravenna, mi sono allontanato, sono dell’idea che le iniziative siano spesso autoreferenziali e questo è un atteggiamento che non premia. Non aiuta ritenersi sempre i migliori, per il semplice fatto che non sempre lo siamo. Il ceto medio culturale ha una conoscenza scarsa della storia e della cultura di questa città, carenza che si riflette in una sua non sempre corretta valorizzazione. Inoltre ci sono molte realtà disperse che non hanno la buona abitudine di comunicare tra loro.
Manca uno sguardo lungimirante e complessivo, un Corrado Ricci o un Luigi Rava purtroppo capitano ogni qualche secolo, ma anche l’attenzione alla conduzione corrente è deficitaria. Basti l’esempio di Galla Placidia, dove un cartello recita “mausoleo del secondo quarto del quindicesimo secolo”. Per non parlare del rapporto irriverente con gli architetti, da Giovanni Michelucci a Renzo Piano, o, più modestamente, anche solo Stefano Boeri. L’anima agraria della città finisce con il prevalere. E anche Forlì, al confronto, sembra Parigi. Poi c’è il secolare problema dei collegamenti ferroviari che nessuno sembra volere seriamente affrontare (preferendo perdere tempo e denari per progetti improbabili come il bypass sul Candiano (ricordate?) destinati a naufragare.
Inoltre la fase industriale in declino induce a riflettere su un prevedibile degrado ambientale e impoverimento economico del territorio (le aree delle ex raffinerie che nessuno vuole bonificare o le acque altamente inquinate del Candiano nel suo ramo terminale). Si pone con urgenza la necessità di uno sforzo creativo collettivo, e sarà necessaria soprattutto una capacità di saper immaginare libera e indipendente. Tenendo sempre presente che le trasformazioni, se non sono ben pensate, possono essere anche violente e deturpare un territorio per sempre, come appunto insegna la storia recente».