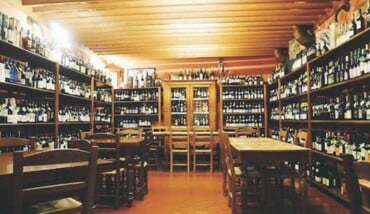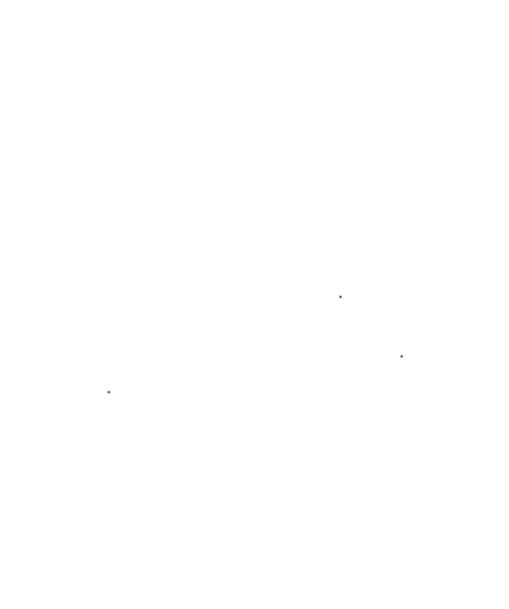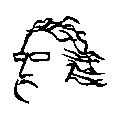L’incontro con il vignaiolo e musicista di Castel Raniero Pietro Bandini, in arte Quinzân, è stato oltremodo appagante sotto vari aspetti, da quello umano, a quello ovviamente legato al vino, fino a quello artistico. Questo perché Pietro racconta cose interessantissime, è un cantautore originale e di grande talento specializzato in poetici testi in dialetto romagnolo (nonché organizzatore della storica rassegna folk Musica nelle aie) e, soprattutto, fa dei vini impossibili da dimenticare. Vini che affondano le radici nelle tradizioni delle colline faentine, realizzati con il massimo rispetto per la natura.
Pietro, da quanto sei nel mondo del vino?
«La mia prima pigiatura l’ho fatta nel 1971, quando ero un bambino, con mio babbo, che era arrivato qui a Castel Raniero alla fine del 1970. Lui faceva vino anche prima, sulle orme di suo padre, in un altro podere. Quando arrivò qui non aveva molta attrezzatura ma cominciò subito a fare qualcosa, poi si attrezzò un po’ e andò avanti così, facendo vino da vendere sfuso, tendenzialmente. Io ho deciso di prendere in mano la cantina nei primi anni del 2000, con l’idea però di arrivare a imbottigliare. In quel momento iniziò anche la fattoria didattica, e ai bambini che facevano il percorso della vendemmia e del vino facevo vedere delle bottiglie complete di etichetta – era Centesimino, che allora chiamavamo Savignone Rosso – che facevo solo a scopo didattico, non erano regolari, perché appunto la cantina era praticamente come prima e ancora non imbottigliavo. Però fu proprio una di queste bottiglie a far conoscere a Luigi Veronelli il Centesimino».
Questa è davvero una storia interessante.
«In effetti sì. Era il 2002, Veronelli, in quel momento 76enne, aveva scritto un articolo molto bello e si era firmato con l’indirizzo di posta elettronica. Allora gli scrissi per dirgli che mi aveva colpito tantissimo che nell’articolo avesse messo a fuoco alla perfezione tutte le tematiche fondamentali dell’agricoltura di quel momento. Veronelli mi rispose, chiedendomi cosa facevo, così gli raccontai della fattoria didattica e della cantina e lui chiese se gli potevo mandare qualcosa da assaggiare. Avevo solo quelle bottiglie didattiche, ma comunque gliene mandai una. Quindi mi telefonò per dirmi che quel vino non lo conosceva, ne voleva capire di più e mi venne a trovare. Era il 2003, parlammo tanto, assaggiò il vino e finì lì. Poi, dopo qualche tempo, senza dirmi nulla, iniziò a pubblicare articoli sul mio vino sul Corriere della Sera, sulla rivista dei sommelier, fino addirittura ad arrivare alla sua ultima guida (quella del 2004) I vini di Veronelli,
dove indicò il mio Centesimino tra i migliori venti vini d’Italia. Bellissimo eh, ma fu anche un problema, perché tutti cominciarono a chiamarmi, anche dall’estero, per acquistare quel vino, ma io non ne avevo, e i lavori per completare la cantina sarebbero durati ancora qualche anno. Veronelli poi è morto poco dopo e non ha potuto vedere la cantina finita, ed è un peccato, perché ci teneva».
Approfondiamo un po’ il Centesimino.
«Il mio si chiama Romeo, come mio nonno, che fondò la cantina un centinaio d’anni fa. L’abbiamo sempre avuto in famiglia. Quando negli anni ‘50 Pietro Pianori, detto Zàntesmen, ha ritrovato una pianta di questa varietà in un cortile a Faenza e ha portato le sue marze nel suo podere Terbato, vicino a Oriolo dei Fichi, mio nonno volle anche lui gli innesti, e da allora l’abbiamo avuto. Le piante che abbiamo ora sono le figlie in parte dirette di quelle piante di allora. Il Centesimino è un vino davvero straordinario, perché ha sentori che sono completamente personali, non sono paragonabili a niente, io lo amo molto».
Quinzân, che è sia il tuo nome d’arte che quello della cantina, invece da dove viene?
«Quinzân è il soprannome della mia famiglia da più di 200 anni. Era il nome di un podere vicino a San Giorgio in Ceparano, sopra a Modigliana; quando i miei avi nell’800 si trasferirono da là a sotto la via Emilia, in zona Albereto, li chiamavano “quelli che vengono da Quinzân”, ed è rimasto».
Raccontami un po’ di qualcuno degli altri tuoi vini, che tra l’altro hanno etichette bellissime.
«Per le etichette la mia fortuna è l’amicizia storica con Marilena Benini di Cotignola, grafica e pittrice che ha anche cantato con me per qualche anno. Il nome di ogni vino è anche il titolo di una mia canzone. Partendo dal bianco, faccio solo trebbiano e ne ho sempre prodotto una sola versione fino all’anno scorso, da quando ho iniziato a farne due. Uno è il Din Don, nome di una ninna nanna in dialetto che mi cantava mia mamma. Fa una macerazione breve, non va mai oltre una settimana. L’altra versione è Inción. Questo fa una macerazione più lunga, è quasi un orange, molto più complesso, tannico, più impegnativo, ma molto interessante. Tra i rossi c’è Io coltivo la musica nelle aie, che non ho sempre in vendita, perché è quello che produco espressamente per i musicisti del festival. È uno dei pochissimi vini che faccio non in purezza, ed è sangiovese al 50% con porzioni variabili di Centesimino e merlot. Il mio sangiovese in purezza si chiama invece Lòm a mêrz, non vuole essere particolarmente impegnativo, è asciutto, adatto al pasto. Fa fermentazione spontanea e macerazione in cemento, poi affinamento in acciaio. Lo Stuglè, che vuol dire “disteso”, è poi un merlot, di cui volevo un’espressione che fosse un po’ diversa da quelli che conoscevo. Ne sono soddisfatto, perché è in effetti un po’ diverso, non si sente quel sentore erbaceo tipico, è molto morbido. È l’unico che produco senza la prima parte in cemento, fa acciaio e basta. Voglio infine citare il passito di Centesimino: mentre il secco si chiama Romeo, la versione passita si chiama “una Rosa”, perché Rosa era il nome di mia nonna, e quindi la stessa uva li unisce».

In assaggio: Centesimino e trebbiano
Sono rimasto molto colpito dai vini di Quinzân, ma vorrei spendere due parole in più su quelli a mio avviso più particolari. Romeo, 2022 Centesimino Ravenna Igt, è un vino che non può lasciare indifferenti, o lo adori o non fa per te. Il bouquet, netto ed elegante, è dominato dalla rosa, che torna con coerenza anche al palato (esplosivo), diventando davvero connotante. Un vino diverso, di grande equilibrio, morbido e raffinatissimo. Discorso diverso per l’Inciòn, un trebbiano di lunga macerazione molto complesso e cangiante, non per tutti.