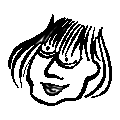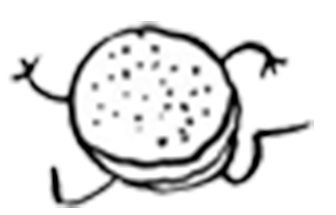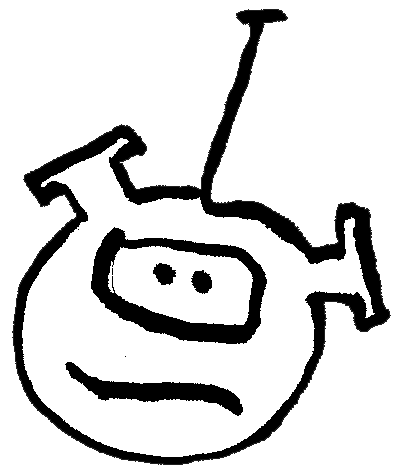Dalle cantine di Firenze al premio Ubu. Una scalata magnifica, quella di Sotterraneo. Daniele Villa, Sara Bonaventura e Claudio Cirri sono partiti dal “vero” basso, ma il cursus honorum è avanzato spedito, fino al recente premio Ubu al miglior spettacolo del 2018 con Overload.
Dopo 10 anni di assenza, il prossimo 1 febbraio il giovane collettivo fiorentino (sono ragazzi nati agli inizi degli anni ’80) torna a Ravenna, al Rasi, proprio con lo spettacolo premiato e acclamato dalla critica, che affronta in modo peculiare e ironico gli effetti del sovraccarico cognitivo dovuto all’abuso dei media digitali. Ne ho parlato con Villa, classe ’82.
È la prima volta che venite a Ravenna?
«Siamo stati al Rasi ere geologiche fa. Era il 2009 e portavamo lo spettacolo Post it».
Era l’inizio della vostra carriera.
«Sì, era il nostro secondo spettacolo».
Come nasce il vostro gruppo?
«La storia è di una banalità sconvolgente. Eravamo tutti amici universitari con conoscenze in comune e abbiamo cominciato a provare in un garage sotto il livello della strada. Da qui il nostro nome. Abbiamo deciso, quasi per gioco, di mettere in piedi uno spettacolo originale. Nessuno voleva mettere in scena un testo già scritto e a nessuno andava di far da regista, così ci siamo dati la forma del collettivo. Sempre per gioco ci siamo iscritti al Premo Scenario: in modo imprevisto e imprevedibile siamo arrivati fino in fondo e siamo entrati in finale. Era l’autunno del 2005. Così abbiamo deciso di continuare. Anche senza essere pagati, all’inizio».
Da dove nasce l’amore per il teatro?
«Ognuno di noi ha la sua storia. Di 5 componenti del gruppo, 4 erano già iscritti a diverse tipologie di corsi, laboratori o scuole teatrali. Io ho studiato media e giornalismo, ma volevo continuare a creare, a qualunque livello. Ero in bilico fra cinema, letteratura e teatro. Ho incontrato un gruppo che era una bolla di determinazione e talento, e così sono finito in questo ambito. Nel quale mi sento molto a mio agio».
Mi ha parlato di una struttura fluida del gruppo, in cui nessuno voleva un ruolo definito. Dopo quasi 15 anni, la divisione dei ruoli si è fatta più netta?
«La scelta non era di tipo ideologico, non pensavamo che il collettivo fosse migliore perché più democratico. Era dettata da uno stato di fatto: nessuno di noi si sentiva nelle condizione di essere regista. Volevamo lavorare in modo orizzontale: una ricchezza ma anche un limite, in termini di confusione. Oggi io, Sara e Claudio abbiamo salvato una struttura orizzontale ma con metodologie più chiare: io scrivo e dirigo il lavoro da fuori, gli altri intervengono su quello che scrivo e dirigono il lavoro da dentro».
Vi definite avant-pop. Cosa significa per voi fare arte d’avanguardia e popolare?
«L’etichetta è un furto bello e buono da un movimento letterario americano a cavallo fra gli ’80 e i ’90 – al quale possiamo ricondurre anche David Foster Wallace. L’idea è che si possa lavorare con l’immaginario collettivo, che tutti conosciamo e consumiamo in modo più o meno consapevole, ma in termini di pensiero complesso e profondità, di critica dura e articolata. Invece di contrapporre all’incanto del mainstream (televisivo prima, digitale oggi) l’incanto di una piccola riserva indiana super-colta, trincerata nella complessità e nel cripticismo, preferiamo il disincanto di chi attinge all’immaginario collettivo a piene mani ma ribaltandolo, disinnescandolo e cercando uno sguardo critico. Non essere alienati dal proprio tempo, ma starci dentro in modo dinamitardo».
Avete fratelli poetici nella scena italiana contemporanea?
«Direi di sì, anche se è meglio lasciare questi ragionamenti ai critici. La riconfigurazione dell’universo mainstream-pop attraversa tutta la nostra generazione, ognuno con la propria poetica, credo. Penso a Babilonia Teatro, al Collettivo Cinetico, agli Anagoor, che ricercano il pop nell’antichità».
Ha citato Foster Wallace, il demiurgo del vostro Overload. Nello spettacolo, oltre alle novità formali, mi hanno colpito molto i contenuti. Perché affrontare un tema così poco “teatrale” come il sovraccarico cognitivo indotto dalla comunicazione digitale?
«Alcuni hanno detto che facciamo “filosofia in azione”. È una definizione che mi piace molto. Riflettiamo sulle trasformazioni della società, cercando di fotografarle con lo strumento del teatro. Spesso ci confrontiamo assieme, alla ricerca di un’urgenza condivisa: cosa ci sta a cuore del nostro tempo? Di cosa è necessario parlare, che cosa ci mette in allarme? Per Overload qualcuno lesse la notizia dell’abbassamento della soglia dell’attenzione umana al sotto di quella di un pesce rosso, e restammo folgorati. Per poi scoprire, qualche articolo dopo, che si trattava di una fake news. Noi stessi eravamo stati vittime di una notizia falsa. Parlare della metamorfosi mediatica della realtà a teatro non pone alcun problema: uno strumento live millenario come il teatro è capace di parlare di tutto».
Una riflessione molto importante dello spettacolo è quella sull’ironia, che viene definita ottimo strumento di critica, ma non di risoluzione ai problemi del presente.
«Sì, quella è una frase vera di Wallace. Ma bisogna distinguere. Quella che pervade il web è un’ironia per catturare il consenso, è una risata narcotica, che ci fa sorvolare sui problemi. È una risata reazionaria. Per me il riso è un’altra cosa. Cervantes, Rabelais, il teatro dell’assurdo mi hanno insegnato a considerare il riso per quello che veramente è, ovvero il retaggio ancestrale di chi digrigna i denti, dell’animale che simula una lotta. A me la risata interessa quando rovescia i punti di vista, quando ci svela la nostra risibilità di umani, la nostra stupidità, la nostra ignoranza e insufficienza. Il riso deve mettere a disagio, non limitarsi ad essere un semplice strumento d’evasione».
Oltre a Wallace quali altri studi o saggi ha utilizzato per la scrittura?
«Pensa che l’idea di usare testi di Wallace e di raccontare la sua vita è arrivata in una fase di lavoro quasi conclusiva. Prima Wallace doveva tenere una conferenza sull’attenzione; in questa conferenza, poi cestinata, citavo lavori di Byung-Chul Han, di Yves Citton, di Fabio Merlini e molti altri. Libri che parlano sostanzialmente di come i media digitali stiano trasformando il nostro comportamento».
Lei come combatte la distrazione digitale?
«Mi piace pensare a una sorta di dieta culturale: bisogna essere selettivi nei contenuti. Siamo in una fase di bulimia mediatica che rischia di intossicarci. Sapere anche che cosa si sceglie e perché: avere coscienza della propria scelta. Non credo invece in nessun tipo di alienazione: questa è una trasformazione epocale, nel quale non c’è un fuori ma solo un dentro».
In una presentazione avete citato una bellissima definizione di Orson Welles che parla del teatro come di un “fabulous invalid”, un malato immaginario che è sempre sul punto di morire e invece non muore mai. Oggi com’è l’encefalogramma del teatro italiano?
«L’Italia esprime una grande vitalità teatrale. Forse anche a causa della ristrettezza economica, che come ogni difficoltà ti spinge a trovare risposte inedite. Ma questo non deve diventare un alibi. La nostra repubblica è fondata sulla cultura oltre che sul lavoro. Cultura non soggetta alle leggi del mercato. Il teatro è un rituale laico collettivo nel quale coltiviamo spirito critico, intelligenza e una visione più complessa della realtà; dunque uno strumento di democrazia. E come anticorpo dovrebbe essere foraggiato di più, con vere risorse e con veri sviluppi legislativi».