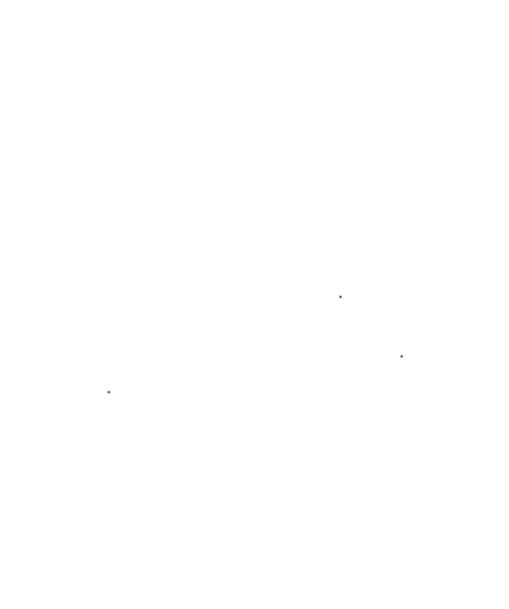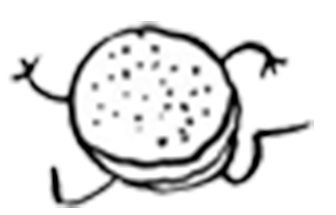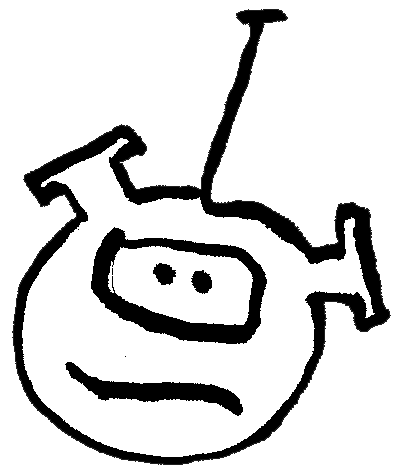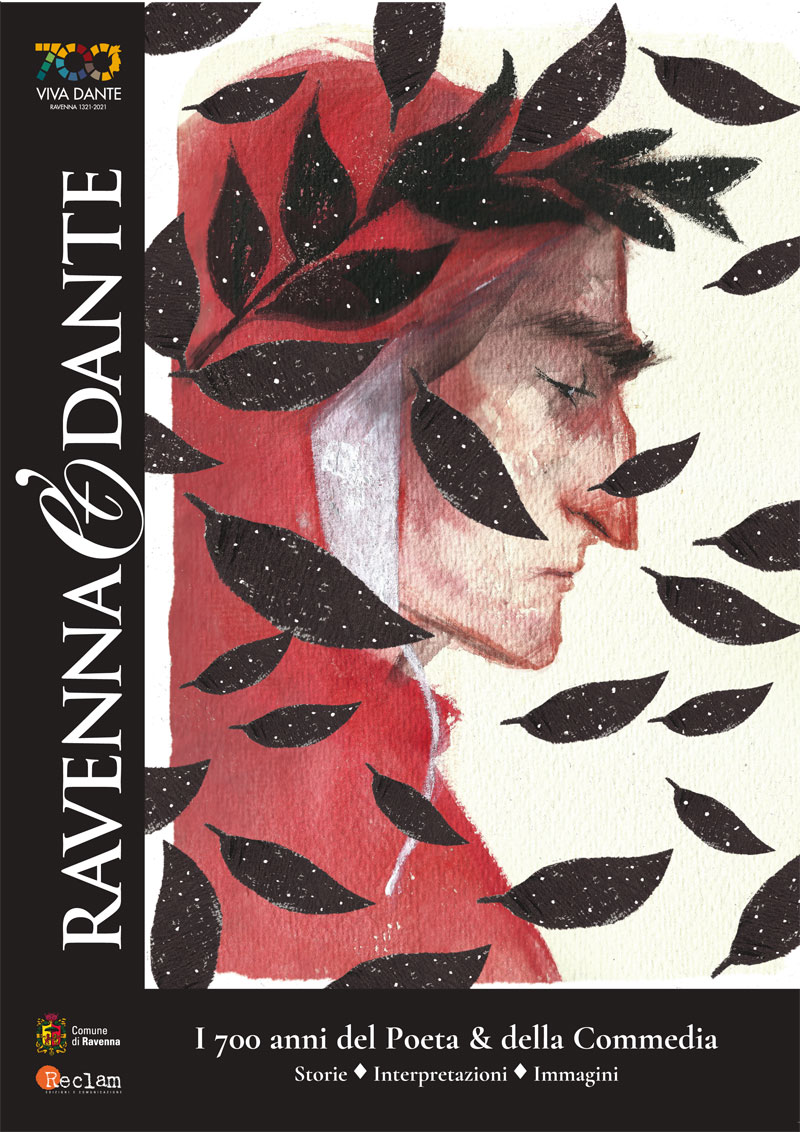Sabato 8 aprile, nella cornice di Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, si terrà l’incontro “Tradurre o Tradire,” nell’ambito di SanMauroCheLegge, che vedrà protagonisti lo scr
ittore Andrea Tarabbia e il traduttore Fabio Cremonesi, voce italiana di Kent Haruf, autore che ha conquistato un vasto pubblico con la Trilogia della pianura, che NN Editore ha pubblicato a partire dall’ultimo volume, Benedizione. Abbiamo raggiunto al telefono Cremonesi, per parlare sia di questo straordinario scrittore e sia del mestiere del traduttore.
Il fatto che si parli di traduzione nell’ambito di un piccolo festival dedicato alla lettura dimostra che questo mestiere ha acquistato una maggiore visibilità.
«È vero, e per una serie di motivi. Negli ultimi anni c’è stato un grosso lavoro da parte di certi colleghi per dare più spazio al ruolo del traduttore. Penso a eventi come l’Autore Invisibile voluto da Ilide Carmignani al Salone del Libro di Torino, eventi nati per gli addetti ai lavori, ma che hanno finito per interessare il grande pubblico. E poi c’è sempre più gente che mastica almeno una lingua straniera e che riesce a rendersi conto della difficoltà che la traduzione comporta. Infine, la consapevolezza da parte del pubblico è anche frutto dell’esplosione dell’editoria indipendente degli ultimi vent’anni, che ha dato visibilità all’intera filiera editoriale».
Nonostante Canto della pianura fosse già uscito per Rizzoli nel 2000, è stata NNE a far riscoprire e amare Kent Haruf al pubblico italiano. Come mai questo successo tardivo?
«Pur nella sua apparente semplicità, Haruf era un autore in anticipo sui tempi. Quando uscì Canto della pianura trionfava una narrativa che interpretava la realtà con l’ironia e il cinismo. Erano gli anni successivi alla fine del mondo bipolare che avevamo conosciuto con la guerra fredda, anni che hanno coinciso con la fine delle narrazioni politiche di derivazione marxiana o liberale. Con il venir meno di tali strumenti di interpretazione della realtà, non sapevamo più come affrontare le grandi questioni della vita e per 25 anni le abbiamo affrontate con l’ironia, prendendone le distanze. Haruf fa esattamente l’opposto: non conosce l’ironia, né tantomeno il cinismo. Parla della morte di una persona cara, del nascere di un amore, delle grandi questioni che riguardano tutti, senza prenderne le distanze, affrontandole di petto».
 Haruf è un autore profondamente americano, nello stile, nei temi, nell’ambientazione…
Haruf è un autore profondamente americano, nello stile, nei temi, nell’ambientazione…
«Nato nel 1943, Haruf si è formato sulla grande narrativa statunitense degli anni ’50 e ’60, una narrativa sostanzialmente rurale, dal punto di vista delle tematiche e della temperatura emotiva. Parlo soprattutto di Steinbeck, di Hemingway solo in misura minore. Poi vi sono analogie con gli scrittori della sua generazione, come Carver, da cui però lo separa una differenza enorme nello sguardo: quello di Carver è drammatico e disperato, laddove lo sguardo di Haruf è luminoso e pieno di fiducia nell’umanità. So che è paragone ardito, ma ho riscontrato anche la presenza di un grande nome della narrativa postmoderna come Don DeLillo, non per le tematiche o per il modo di raccontarle, ma per l’attenzione agli sguardi e ai corpi, per la capacità di ritrarre la psicologia di un personaggio dal modo in cui occupa lo spazio».
I romanzi di Haruf sono tutti ambientati a Holt, un paese immaginario del Colorado. L’ambientazione assume un’importanza fondamentale, e il paesaggio è un elemento costante.
«Haruf non interpreta mai né dà giudizi morali. Si limita a descrivere il paesaggio, ciò che fanno le persone e lo spazio in cui si muovono, e a decifrare le loro parole, come se raccontasse con una macchina da presa. Non dice mai quello che i personaggi pensano né spiega il perché delle loro azioni, lasciando quindi spazio all’interpretazione e alla sensibilità del lettore. Anche gli animali hanno un’importanza fondamentale. In ogni romanzo ci sono delle scene intere, a volte piuttosto brutali, che parlano di animali e che hanno una funzione narrativa precisa. Gli animali non sono una metafora, come nelle favole di Fedro, ma delle chiavi per leggere in controluce le ragioni degli eventi e delle scelte».
Lo stile di Haruf è semplice, la lingua spoglia e precisa al tempo stesso. Ma non sempre un linguaggio semplice corrisponde a una traduzione facile. Quali sono state le maggiori difficoltà nel tradurlo?
«Innanzitutto, i libri scritti bene sono sempre più facili da tradurre, la cosa più difficile per un traduttore è tradurre i libri scritti male. Il testo ben congegnato ti sostiene sempre nelle scelte traduttive, mentre quello scritto male ti lascia soltanto con dei dubbi. I dialoghi di Haruf sono tanto meravigliosi che avevo la sensazione che si traducessero da soli, come se una vocina me li dettasse all’orecchio. Le parti narrative sono diverse, prima di tutto perché il lessico è talvolta complicato; per esempio, il lessico della zootecnia è difficile da capire sia in inglese sia in italiano, per chi non se ne intende. Poi c’è l’aspetto legato alle scelte lessicali. Benedizione, in cui ogni parola è centellinata, mi ha posto di fronte a scelte difficili: quando il lessico è ridotto a 500–600 parole e un termine ricorre trenta volte, è necessario trovare un unico traducente che vada bene in ogni contesto. Questo richiede un lungo lavoro, lavoro che è però l’aspetto più bello di questo mestiere».
Haruf è scomparso nel 2014, poco prima della pubblicazione in Italia di Benedizione. È stato un ostacolo non poterti confrontare con lui?
«Direi di no. Quando ho tradotto Benedizione era ancora vivo, è morto mentre stavo finendo. Soltanto alla fine, non sapendo della sua scomparsa, gli ho mandato un’e-mail, in cui però non c’era neanche una richiesta di chiarimento, ma in cui esprimevo la mia felicità per aver lavorato a un libro così bello e la soddisfazione per la possibilità di dare il mio piccolo contributo per farlo conoscere ai lettori italiani».
Le nostre anime di notte, l’ultimo romanzo di Haruf uscito a febbraio, ha già scalato le classifiche. Quali sono gli elementi che lo accomunano alla trilogia, oltre al ritorno a Holt?
«In primis, la sua voce, riconoscibile fin dalla prima frase, da quel “And then”, un incipit assolutamente “harufiano”. Poi c’è il suo sguardo luminoso e pieno di grazia. La differenza fondamentale è invece nel tempo. Innanzitutto, nel tempo che lui aveva a disposizione, ovvero 5 o 6 mesi anziché 5 o 6 anni. È sorprendente, oltre a dimostrare la grandezza dell’uomo, il fatto che una persona a cui è stata diagnosticata una malattia terminale abbia voglia di rimettersi in discussione come scrittore. All’interno del romanzo, poi, la percezione del tempo cambia completamente: nella trilogia è circolare, scandito dalle stagioni, mentre i riferimenti cronologici sono scarsissimi. In Le nostre anime di notte il tempo è lineare, con un inizio, uno svolgimento e una fine, e sembra incombere su tutti, a partire dai due anziani protagonisti che si stanno dando un’ultima chance in un ambito della vita in cui non pensavano di poterne più avere, chance che vivono all’insegna dell’urgenza. Il tempo non influenza soltanto la trama e la psicologia dei personaggi, ma anche lo stile: è un libro in cui si sente l’urgenza, in cui la scrittura non è perfetta come nella trilogia, ma più veloce, più incentrata sul contenuto».
Haruf era molto disciplinato: per lui la scrittura era un “hard work” e scriveva e leggeva tutti i giorni, chiuso nel suo capanno di legno. Si può dire lo stesso della traduzione?
«Sì, questo discorso vale ancora di più per la traduzione, perché, mentre scrivere è un’arte, tradurre è artigianato, benché abbia la sua parte di creatività. Per tradurre bisogna leggere molto, fare possibilmente revisioni sulle traduzioni dei colleghi e poi tradurre, tradurre tanto, con l’idea che questo allenamento renda le nostre traduzioni sempre un po’ migliori».