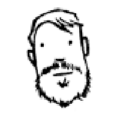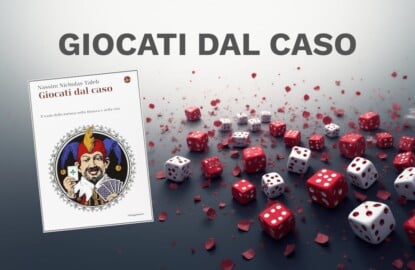Ogni autunno, con l’avvicinarsi di novembre, nelle case e nei forni della Romagna meridionale ritorna un profumo che sa di tempo passato. È quello della piada dei morti, o pida ad mórt in dialetto: una focaccia dolce che non è soltanto cibo, ma memoria collettiva.
Un dolce che racconta il legame profondo tra il pane, la comunità e il ricordo di chi non c’è più.
Il nome può trarre in inganno: non è la classica piadina, bensì un pane dolce lievitato, arricchito con frutta secca, uvetta e, in alcune varianti, semi di anice. Nelle campagne di un tempo era preparata per la Commemorazione dei Defunti, come simbolo di memoria e di condivisione.
Si offriva agli antenati, si distribuiva ai poveri come atto di carità e, in certe aree, si lasciava sul davanzale la notte del 2 novembre, perché le anime dei cari potessero nutrirsi del suo profumo.
La ricchezza degli ingredienti – noci, pinoli, uvetta, mandorle, miele o saba – aveva una forte carica simbolica: l’uva passita richiamava il ciclo della vita, i frutti a guscio rappresentavano abbondanza e rinnovamento. Prepararla era un rito domestico, familiare, quasi liturgico.
Sebbene oggi la tradizione sia più viva nel territorio riminese, un tempo la piada dei morti era diffusa in tutta la Romagna, con varianti locali che ne arricchivano l’identità.
A Cesena e Forlì si usavano spesso semi di anice e saba (mosto cotto), che donavano un aroma antico e intenso; a Ravenna si aggiungevano talvolta canditi e una sottile glassa di zucchero; a Rimini l’impasto era più semplice e leggero, dominato dal profumo di noci e mandorle; nelle zone appenniniche parte dello zucchero era sostituita con miele di castagno, per un dolce più scuro e rustico.
In tutte le sue forme, la piada dei morti è il riflesso di un tempo in cui la comunità si stringeva per onorare la memoria attraverso il cibo, in un equilibrio fra sacro e quotidiano.
Oggi non è più un’usanza domestica, ma sopravvive come prodotto stagionale nei forni e nelle pasticcerie, soprattutto tra ottobre e novembre. Continuare a prepararla significa tenere viva una tradizione che, come il lievito, si tramanda solo se accudita.
È un dolce che parla al cuore della Romagna: unisce passato e presente, e ricorda che spezzare e condividere il pane è forse il gesto più antico per restare uniti, anche oltre il tempo.
Il significato di offrire cibo ai defunti
L’offerta di cibo ai defunti è un rito antichissimo, comune a molte culture del mondo. Dai banchetti funebri dell’antica Roma alle tavole imbandite del Día de los Muertos in Messico, il gesto di nutrire simbolicamente chi è passato oltre rappresenta un modo per mantenere il dialogo con gli antenati.
In Romagna, come in gran parte dell’Italia contadina, la notte tra l’1 e il 2 novembre si lasciavano sul tavolo pane, vino o dolci, convinti che le anime dei cari tornassero a visitare la casa. Il cibo era offerto non solo come nutrimento, ma come ponte tra i vivi e i morti, un segno di continuità e di affetto.
Anche la piada dei morti si inserisce in questa logica simbolica: è il dolce che parla ai sensi, ma anche alla memoria, celebrando la vita attraverso il ricordo.

ECCO COME PREPARARE LA TRADIZIONALE PIADA DEI MORTI
Ingredienti (per 2 piade grandi): 500 grammi di farina 0; 150 grammi di zucchero semolato; 100 grammi di burro morbido (meglio se di centrifuga); 150 grammi di latte tiepido; 15 grammi di lievito di birra fresco (o 5 g di secco); 2 uova medie; 100 grammi di uvetta ammollata in acqua o in rum; 80 grammi di gherigli di noci; 50 grammi di pinoli; 50 grammi di mandorle; scorza di 1 limone non trattato; 1 cucchiaio di semi di anice (facoltativo, tipico del forlivese e cesenate); un pizzico di sale.
Preparazione. Sciogliere il lievito nel latte tiepido con un cucchiaino di zucchero e lasciarlo attivare. In una ciotola capiente mescolare farina, zucchero e sale. Aggiungere uova, scorza di limone e il lievito sciolto. Impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo, quindi incorporare gradualmente il burro morbido e infine l’uvetta strizzata. Coprire e lasciare lievitare per circa due ore, finché raddoppia di volume. Dividere l’impasto in due parti, formare due focacce e disporle su teglie rivestite di carta for- no. Spennellare con un tuorlo sbattuto e decorare con la frutta secca in superficie. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per 30–35 minuti, finché dorata.
Il risultato è una focaccia morbida e profumata, che conserva in ogni morso il sapore della tradizione e il calore del ricordo.