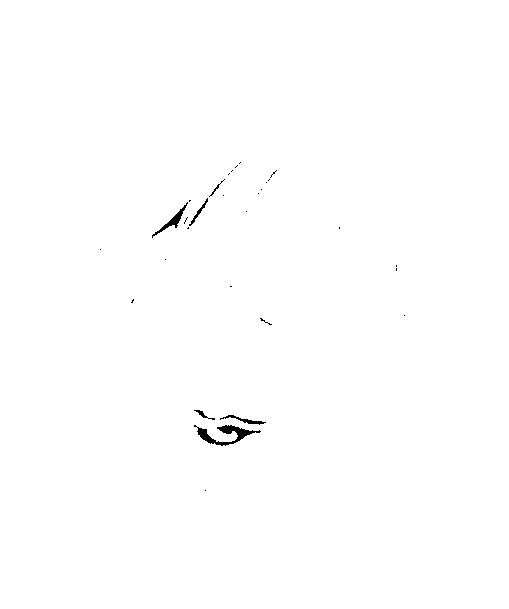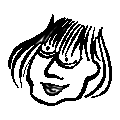Il ciambellone romagnolo è un dolce tipico del nostro territorio che, negli anni, ha resistito al cambiamento. È rimasto fermo, non per inerzia, ma per fedeltà: è una preparazione che custodisce gesti antichi, ingredienti poveri e sapori sinceri. È l’archetipo del dolce domestico, rustico e contadino, sopravvissuto alla modernità senza mai cedere all’omologazione. Nessun effetto scenico, nessuna glassa decorativa, nessuna variante: solo la semplicità della farina, delle uova, dello zucchero e di un grasso (un tempo rigorosamente strutto, oggi il burro). In dialetto, lo chiamano anche brazadèla, da braccio: perché si portava sottobraccio, avvolto in un canovaccio, verso la casa della sposa, o come dono pasquale nei pranzi di famiglia.
Il ciambellone romagnolo è un dolce tipico del nostro territorio che, negli anni, ha resistito al cambiamento. È rimasto fermo, non per inerzia, ma per fedeltà: è una preparazione che custodisce gesti antichi, ingredienti poveri e sapori sinceri. È l’archetipo del dolce domestico, rustico e contadino, sopravvissuto alla modernità senza mai cedere all’omologazione. Nessun effetto scenico, nessuna glassa decorativa, nessuna variante: solo la semplicità della farina, delle uova, dello zucchero e di un grasso (un tempo rigorosamente strutto, oggi il burro). In dialetto, lo chiamano anche brazadèla, da braccio: perché si portava sottobraccio, avvolto in un canovaccio, verso la casa della sposa, o come dono pasquale nei pranzi di famiglia.
La sua storia è infatti legata a quella dei suoi riti: non c’era festa importante, né domenica che si rispettasse, senza il ciambellone. Si inzuppava nel latte o nel tè alla mattina e nel Sangiovese a fine cena: era quasi una abitudine che sanciva la fine di una giornata, una coccola gratificante.
Ancora, veniva preparato nei giorni che precedevano la Pasqua, spesso insieme alle uova benedette, e donato ai bambini in cambio di una poesia o di un saluto in dialetto. Era presente nei banchetti nuziali come augurio di fertilità e prosperità, o al termine delle veglie funebri, come dolce del conforto. Era simbolo dell’abbondanza, non per ricchezza di ingredienti ma per significato affettivo: riempiva la casa del suo profumo e durava giorni, tagliato a fette spesse e conservato in credenza, accanto al pane raffermo e al formaggio stagionato.
Ogni famiglia aveva la sua brazadèla: più asciutta o più soffice, arricchita con un bicchierino di anice, con scorza di limone o con l’ultima saba dell’autunno.
In alcune case si cospargeva la superficie con granella di zucchero o zucchero semolato, altrove si lasciava nuda. Le versioni più antiche escludevano il lievito chimico e lo sostituivano con bicarbonato o ammoniaca. La cottura avveniva nei forni a legna o, nei paesi di montagna, sotto campane di terracotta coperte di brace.
Un aneddoto raccolto da un’anziana fornaia di Modigliana racconta di come, durante la guerra, si preparasse una versione “del fronte”, senza uova né zucchero, sostituiti da acqua di cottura delle castagne e un po’ di miele. Il dolce risultava scuro e tenace, ma nessuno osava lamentarsi: era pur sempre ciambellone e quello bastava. Oggi, sulle tavole moderne, questo è un dolce che fatica a competere con la pasticceria contemporanea, ma resiste nella sua funzione primaria di torta “da credenza” identitaria, da tagliare senza cerimonia e da offrire con naturalezza. Il suo ritorno nelle cucine domestiche, anche grazie alla riscoperta dei dolci della nonna, coincide con il desiderio di autenticità, di cibo semplice, essenziale e genuino.
Nei panifici di Ravenna, Cesena, Forlì e nei piccoli forni di paese, si trova ancora preparata come un tempo. E spesso viene servita anche nelle osterie tradizionali come chiusura del pasto, accompagnata da un bicchiere di albana dolce o di cagnina.
Non chiamatelo “ciambella”!
Oggi si tende a chiamare “ciambella” qualsiasi dolce a forma di anello, ma per chi conosce la tradizione romagnola, il nostro ciambellone è tutta un’altra storia (e non ha neppure la forma ad anello!): non è soffice né spugnoso come le ciambelle da colazione stile plumcake. Niente glasse e niente ripieni. È un dolce asciutto, compatto e con una crosta croccante, pensato per essere intinto. In passato, la sua consistenza secca aveva una funzione ben precisa: serviva per conservarsi a lungo senza alterarsi. Al contrario, la ciambella moderna (soffice, arricchita con yogurt, creme o coperture glassate) è una derivazione borghese sviluppatasi nell’Ottocento, con l’avvento dei lieviti chimici e delle ricette da salotto. Due dolci, due storie.

LA RICETTA – Il ciambellone di casa mia
Si parte mettendo 500 grammi di farina di tipo 1 (anche di tipo 0 o tipo 2 vanno bene, mai 00!) in una ciotola capiente. Si uniscono 300 grammi di zucchero semolato, 200 grammi di burro a temperatura ambiente, meglio se di centrifuga, 30 grammi di strutto, tre uova medie e un aroma: la scorza grattugiata di un limone bio oppure i semi di mezzo baccello di vaniglia, secondo la stagione o l’umore. Si aggiunge una bustina di lievito per dolci rigorosamente non vanigliato (16 grammi).
L’impasto va lavorato con decisione, preferibilmente in planetaria con gancio a foglia, fino a ottenere una massa omogenea e compatta. Ora si divide la massa in due o tre porzioni, si modella ogni parte per ottenere un cilindro, quindi si trasferisce su una teglia rivestita di carta da forno. Si spennella con latte e si cosparge la superficie con zucchero di canna (a me non piace lo zucchero in granella … mi ricorda la Citrosodina!).
Si cuoce in forno statico a 180°C per 30-35 minuti, regolando i tempi in base alla dimensione delle forme. La superficie deve risultare dorata, anche all’interno delle crepe che si formano in superficie.
È un ciambellone sobrio, pensato per essere intinto nel latte a colazione, nel tè a pomeriggio e nel sangiovese la sera, come vuole l’uso romagnolo.