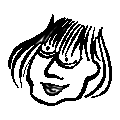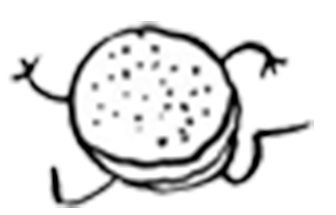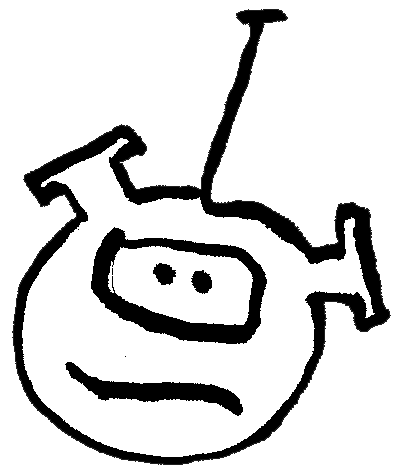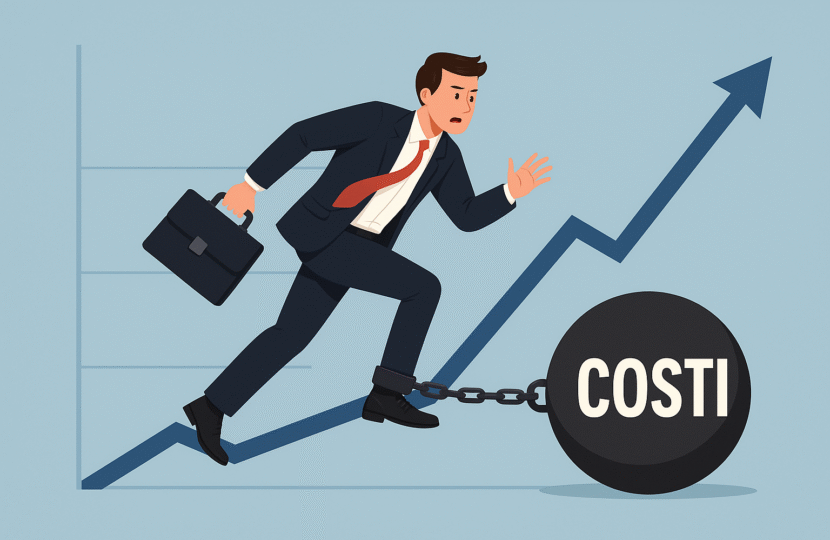Ce lo ricordiamo tutti per i suoi monologhi a “Parla con me”: un personaggio bizzarro, accento romano nasale, folti capelli neri e lungo pizzetto. Ascanio Celestini è oggi più arruffato e più bianco, ma il suo timbro, crudo e sognante al tempo stesso, è sempre quello.
Ce lo ricordiamo tutti per i suoi monologhi a “Parla con me”: un personaggio bizzarro, accento romano nasale, folti capelli neri e lungo pizzetto. Ascanio Celestini è oggi più arruffato e più bianco, ma il suo timbro, crudo e sognante al tempo stesso, è sempre quello.
Celestini sarà a Ravenna giovedì 16 maggio, per la prima volta ospite del teatro Alighieri, per lanciare la seconda edizione del festival Polis. In scena lo spettacolo Laika, monologo accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei, che racconta la vita degli ultimi, sullo sfondo di borgate romane povere e violente.
Ne ho parlato, in anteprima, con Celestini, partendo dal contestato spettacolo della scorsa stagione all’Arena delle balle di paglia.
IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO, DEL FESTIVAL POLIS 2019
L’ultima volta che l’abbiamo vista nei paraggi è stato all’Arena di Cotignola, l’anno scorso.
«Sì, a Cotignola portai La ballata dei senzatetto, raccolta che integra racconti tratti da Laika, da Pueblo e dallo spettacolo che concluderà la trilogia. Sono storie legate a un ambiente ben preciso: due parcheggi, un supermercato, un grande magazzino, un condominio popolare e un bar. Il riassunto di un mondo in cui vivono figure di cui parliamo soltanto se accade qualcosa di eclatante».
Mi colpì la reazione del pubblico, che esplose durante un passaggio dedicato al mondo degli zingari. Non si era capito che si trattava di portare all’estremo dei luoghi comuni. Anche in Laika c’è questo rapporto complesso col politically correct?
«In parte sì. In Laika il personaggio che viene colpito è un barbone che vive nel parcheggio del supermercato. Il politicamente corretto molto spesso è una maschera. In questi giorni ho fatto degli incontri in carcere, e parlando coi detenuti ho ribadito più volte il fatto che le parole servono per dire le cose. Il problema non sono le parole, ma come viviamo. Io li chiamo “zingari” o “rom”, ma cambia poco. La parola più corretta, più pulita, che sarebbe “nomadi”, è in realtà sbagliata. Chiamiamo “campi nomadi” posti che in realtà sono accampamenti stanziali».
La correttezza diventa retorica pericolosa.
«Esatto. A Cotignola quello che è successo è un po’ strano. Normalmente lo spettatore si rende conto che a parlare è il personaggio e non l’attore, ma alle volte non capita. Da un certo punto di vista è una cosa positiva: vuol dire che lo spettatore si è sentito chiamato in causa».
I suoi spettacoli nascono sempre da una ricerca. Per Laika ha vissuto con i suoi personaggi, “sul campo”?
«Alcune storie sono di persone che conosco della borgata in cui vivo. Altre le ho raccolte partendo da interviste con facchini che lavorano nei magazzini della logistica. Nel 2002 seguii la vicenda di un gruppo di lavoratori precari di un grande call center. Già allora era chiaro che cosa stava diventando il mercato del lavoro. Non c’era solo uno sfruttamento del lavoratore, ma proprio un declassamento. I lavoratori non erano più trattati come tali, ma come ragazzini che facevano un lavoretto. E a chi fa un lavoretto, non gli dai un salario, ma una paghetta. È un problema sempre più forte e presente nel mercato del lavoro».
Fin dal titolo, Laika rimanda alla Guerra Fredda, alla corsa allo spazio, al sacrificio inutile di quella cagnetta russa che, con gli occhi di oggi, fa una certa impressione. Chi sono oggi le nostre “laike”?
«Il protagonista se lo chiede: perché hanno scelto proprio Laika? Perché era un cane di strada, più resistente degli altri; e perché sacrificare un cane di razza sarebbe stato più difficile. Molto spesso chi viene sacrificato è oggi l’ultimo della categoria: chi vive in un quartiere periferico, il rom, l’immigrato. Diventa il bersaglio delle battaglie più miserabili».
A cosa si riferisce?
«Penso ai fatti di Torre Maura (l’intervista è stata realizzata prima dei fatti di Casal Bruciato, ndr): si trattava di poche decine di rom che venivano portate in case popolari, in un quartiere dove dovremmo aspettarci solidarietà tra persone che vivono in condizioni sfavorevoli. Penso alla scena miserabile del pane calpestato. Già solo vederlo, quel pane, fa tristezza: monodose, dentro la plastica, non è neanche la pagnotta condivisa sul tavolo, quella dell’ultima cena, di Gesù Cristo che spezza il pane. Quello è già tagliato e porzionato, freddo, igienico. Pensare che c’è qualcuno che lo toglie dalla bocca a quelli che dovrebbero mangiarlo… Non è una guerra fra poveri, è una guerra contro la povertà, contro l’essere umano».
Ha detto che una cosa importante, per lei, è instillare il dubbio col suo teatro. Le sue storie però mi sono sempre sembrate molto chiare e schierate. Come si inserisce il dubbio in queste storie?
«Una volta ho fatto Laika a Milano. Fuori dal teatro, tutte le sere, c’era un africano che vendeva le rose. Qualcuno si aspettava che, dopo la visione, gli spettatori inteneriti gli avrebbero comprato i fiori. E invece l’africano non ebbe alcun incremento della vendita. Io non credo che la funzione del teatro sia politica, che debba cambiare il pensiero delle persone o spingere all’azione. Credo che il teatro sia un’opportunità, per chi la vuole cogliere, di conoscere qualcosa dell’essere umano. Il politico viene dopo, non deve essere il primo problema dell’artista. Se l’artista comincia a pensare: adesso affronto questa storia perché voglio fare conoscere questo scandalo, fa un pessimo servizio all’arte. Rischia di fare qualcosa di lodevole ma di noioso. L’artista ha la possibilità di raccontare l’uomo, e con questi miei spettacoli racconto un’umanità che vive ai margini dei margini: barboni, immigrati, prostitute. Credo che in queste figure l’umanità sia più leggibile».
Perché?
«È più difficile per un barbone, per un malato o per un detenuto mostrare un’immagine di se stesso mascherata. Dentro un cella per otto persone non si riesce a dare di sé l’immagine desiderata. Ci si mostra per quello che si è. L’amministratore delegato di una multinazionale racconta se stesso come vuole. Dove l’uomo è più visibile, lì c’è per me un maggiore interesse letterario».
Forse è proprio questa nudità degli ultimi che, sempre di più, ci infastidisce?
«Ho appena pubblicato un libro di barzellette per Einaudi. In ogni barzelletta c’è qualcosa di nudo e di sporco. Sono quasi sempre scorrette, sia per far ridere, sia perché portano a galla un marcio del quale possiamo parlare solo se ne ridiamo. Del razzismo ne possiamo parlare o ridendo, o diventando razzisti. In questa scorrettezza c’è anche una verità, molto semplice: la barzelletta crea un ponte. Nella barzelletta si arriva subito al dunque, con tre parole. È una specie d’ascensore dell’inconscio».
Wittgenstein diceva che la storia della filosofia poteva ridursi in una collezione di barzellette. In ogni barzelletta c’è una parte di verità secondo lei?
«Più che una verità, c’è una concretezza. Pensiamo a un sopravvissuto della Shoà che racconta una barzelletta sugli incontri fra ebrei e Hitler ad Auschwitz: può sembrare una cosa tremenda, ma è un modo per affrontare il discorso».
Una catarsi?
«Sì, esatto. È chiaro che la barzelletta può offendere, ma è offensiva perché la sua finalità è suscitare il riso. Se qualcuno si offende, non si può censurare la barzelletta. Se non ne ridiamo più, significa che non siamo più capaci di affrontare quell’argomento».