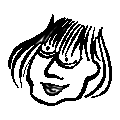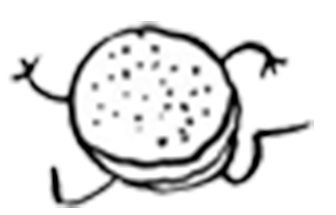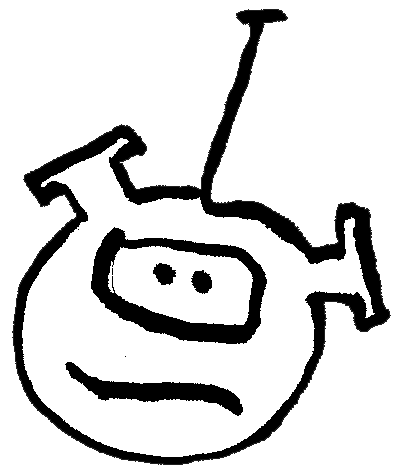Romeo Castellucci, cesenate classe ’60, tra i fondatori della compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, è uno dei più importanti registi europei.
Romeo Castellucci, cesenate classe ’60, tra i fondatori della compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, è uno dei più importanti registi europei.
La Triennale di Milano l’ha scelto come Grand Invité, ovvero come principale artista collaboratore per il triennio 2021-2024.
Recentemente è stato ospite dell’Università della Calabria con un incontro intitolato “Che cos’è guardare?”. In questi mesi di pandemia abbiamo fatto soprattutto questo, mi pare: siamo rimasti a guardare. Cos’è stato questo “guardare”, per tutti noi?
«Questo periodo ha acutizzato una condizione esistenziale che già esisteva: il nostro sguardo è completamente diseducato, disfunzionale, distratto. Non sa scegliere e non sa farsi scegliere. È orizzontale, illustrativo, non conosce le differenze: ha molto a che fare col rumore bianco. Ci sono rimasti pochi ambiti in cui lo sguardo può essere risvegliato nella sua potenza e nella sua meraviglia. Guardare è meraviglioso, lo diceva Giacometti: è un fatto straordinario saper guardare, vedere la profondità del campo o di un volto. In quali luoghi questa esperienza può essere ancora sconcertante? Io credo, nonostante tutto, che questo sia il dominio dell’arte – e nello specifico del teatro, laddove lo sguardo si risveglia, si riconfigura, ti mette in crisi».
Lei lavora fra le immagini. C’è stata un’immagine che l’ha colpito, durante la pandemia? Cosa si porta negli occhi di quest’anno?
 «Le immagini che ci arrivano attraverso i media, ripetute milioni di volte, perdono la loro icasticità e il dialogo con lo spettatore. Nonostante tutto, un’immagine per me significante rimane quella del Papa in piazza San Pietro. Per qualcuno è un’immagine costruita, retorica, furba. Potrebbe essere, ma non m’importa l’intenzione, è paradossalmente onesta. Dice qualcosa non solo rispetto al tempo attuale del Covid: parla del deserto in cui viviamo, a prescindere dalla pandemia. La comunità dileguata, la solitudine, la voce che grida nel deserto. È un’immagine sostanziale di questa epoca, molto potente».
«Le immagini che ci arrivano attraverso i media, ripetute milioni di volte, perdono la loro icasticità e il dialogo con lo spettatore. Nonostante tutto, un’immagine per me significante rimane quella del Papa in piazza San Pietro. Per qualcuno è un’immagine costruita, retorica, furba. Potrebbe essere, ma non m’importa l’intenzione, è paradossalmente onesta. Dice qualcosa non solo rispetto al tempo attuale del Covid: parla del deserto in cui viviamo, a prescindere dalla pandemia. La comunità dileguata, la solitudine, la voce che grida nel deserto. È un’immagine sostanziale di questa epoca, molto potente».
Ripete spesso che il teatro è la più carnale delle arti. Per un anno la carne è dovuta scomparire. Qualsiasi tentativo di teatro a distanza è destinato a fallire?
«Ma certo. Anzi: non si dà, non è. Il teatro è solo quella cosa lì: non si può mediare. Possiamo fare del teatro documentato, sì, ma rimangono documentari. Il teatro è per definizione “di presenza”, è l’arte pericolosa. Se lo riprendi con una telecamera diventa un’altra cosa. Non ci sono altre possibilità».
L’unica possibilità è aspettare?
«Aspettare, farlo in modo clandestino, non lo so. Ma il teatro su internet fa ridere. È una scemenza, una piccola volgarità. Hanno parlato di un teatro su Netflix, o qualcosa di simile: è una stupidaggine incredibile, una naïveté, un pensiero ministeriale. Se qualcuno pensa una cosa del genere, significa che il teatro non sa cos’è».
Sarà Grand Invité alla Triennale di Milano fino al 2024. Durante la conferenza di presentazione ha detto che “hai bisogno di questa città più di quanto essa non ne abbia di te”. Perché?
«Milano è proiettata nel teatro europeo. La Triennale è uno spazio, fra i pochissimi in Italia, direi “rinascimentale”, ovvero in cui è possibile mettere a confronto diversi linguaggi. È un luogo – o meglio, spero lo sarà – di pensiero, un luogo fondativo per le arti viventi, innestate nel corpo della città. Vorrei, attraverso la Triennale, raggiungere le realtà milanesi, le più disparate. Ogni teatro compie un ritratto della propria città, con i suoi abitanti e le sue tensioni sociali: trovo che Milano abbia grandissime potenzialità».
Il lockdown ha fatto saltare diverse sue produzioni, tra cui un Don Giovanni al Festival di Salisburgo e Bros, un’opera sulla violenza e sulla polizia. Ci stava lavorando quando sono state diffuse le immagini della morte di George Floyd. In un’intervista ha detto che la realtà aveva superato la finzione, e non sarebbe stato più possibile mettere in scena questo lavoro. Mi ha colpito molto questa idea.
«È vero. Avevo immaginato questo lavoro sulla polizia. Non è solo una stupida e bislacca critica, è un oggetto più oscuro: la polizia viene intesa come una fratellanza primitiva, rivelando certe strutture antropologiche delle confraternite. Ma c’è anche un aspetto legato alla storia del cinema: non si dà cinema senza polizia, a partire dal cinema muto, in cui è protagonista assoluta. Basti pensare alla filmografia di quel genio di Buster Keaton. La polizia è sempre stata al servizio del caos, garantiva le gag e la comicità. Mentre lo stavo costruendo ho visto le immagini di Minneapolis e mi sono detto che questo lavoro non poteva essere più fatto: la realtà era più potente di qualsiasi immaginazione. Poi riflettendo e correggendo il tiro ho deciso di riprenderlo, e alla fine lo farò: avrà una prima tappa al Kunstenfestivaldesarts, a Bruxelles, e in Italia saremo proprio alla Triennale a novembre, se tutto va bene».
Si dice sempre che il teatro è essenziale alla comunità, che è insostituibile. Sono belle frasi, ma le sale sono mezze vuote, e lo erano anche prima del virus. Perché?
«Capisco perfettamente la gente che non va a teatro. È il figlio di un dio minore. Non ci sono cose interessanti, urgenti, belle. La colpa è degli artisti, non certo del pubblico. Non è mai colpa del pubblico o di qualcun altro! Che ne so, di Berlusconi, per essere banali. Ha tante colpe, intendiamoci, e se c’è qualcuno che ha distrutto la cultura di questo paese è lui; ma non possiamo aggrapparci a questa superstizione. Il pubblico che colpe ha? Deve pagare un biglietto per vedere qualcosa che sa già? O andare solo per convenzione? Ci sono delle concorrenze che vanno tenute in considerazione: noi le snobbiamo, ma hanno la loro potenza. Ci sanno fare, e giochiamo su terreni pericolosamente vicini. Questa è una sfida che gli artisti devono conoscere e combattere. Non basta dire “io sono migliore”. Chi l’ha detto? Dove sta scritto che si deve andare a teatro? Non si tratta di morale o di etica: io vado dove godo di più. Finché il teatro rimarrà debole, ripetitivo, letterario e illustrativo, è logico che il pubblico non ci vada. Io stesso non andrei a vedere la maggior parte degli spettacoli, perché sono oggettivamente brutti: noiosi, stereotipati, moralisti. Non lo dico per snobismo: ci sono nomi per cui faccio anche migliaia di chilometri, come Christoph Marthaler. Perché quando il teatro funziona è un’esperienza straordinaria, che nessun film o programma televisivo ti potrà mai dare. Mai. Ti fa tremare i polsi, ti mette in contraddizione, ti fa piangere. Un’esperienza che ricorderai per tutta la vita».
Per essere veri artisti c’è bisogno di essere distanti dal proprio tempo per capirlo meglio? Oppure no?
«Sì. È essenziale essere inattuali, proprio per queste ragioni. Ma non per essere avulsi sulla torre d’avorio: detesto l’idea sacerdotale di artista. È più semplicemente il fatto di dover usare un’altra lingua per parlare della nostra, Un’altra immagine per fare il ritratto di ciò che siamo. Entrare nella fibra di questa realtà significherebbe far parte dello spettacolo che è diventato la nostra società, come diceva Guy Debord. Il compito dell’artista non è quello di descrivere, illustrare o criticare: è quello di creare un problema, aumentare le domande e non risolverle con formule moralistiche. Fa parte della filosofia del teatro, è il suo destino. Può essere spiacevole, essere investito da problemi senza soluzione ma è una spiacevolezza che onora la tua intelligenza e la tua maturità di spettatore».