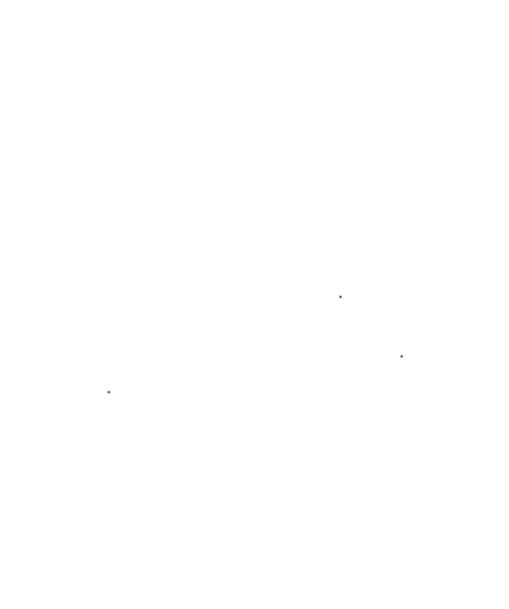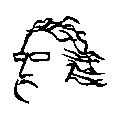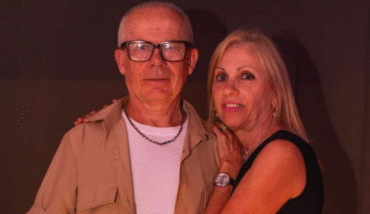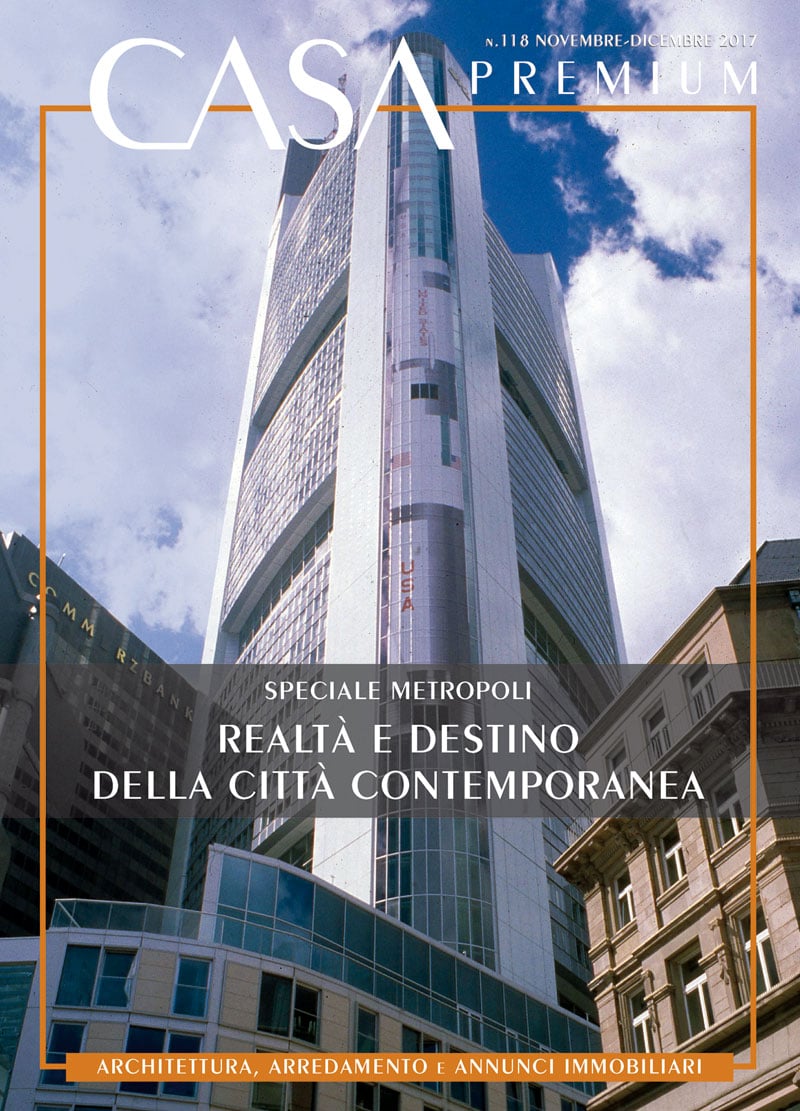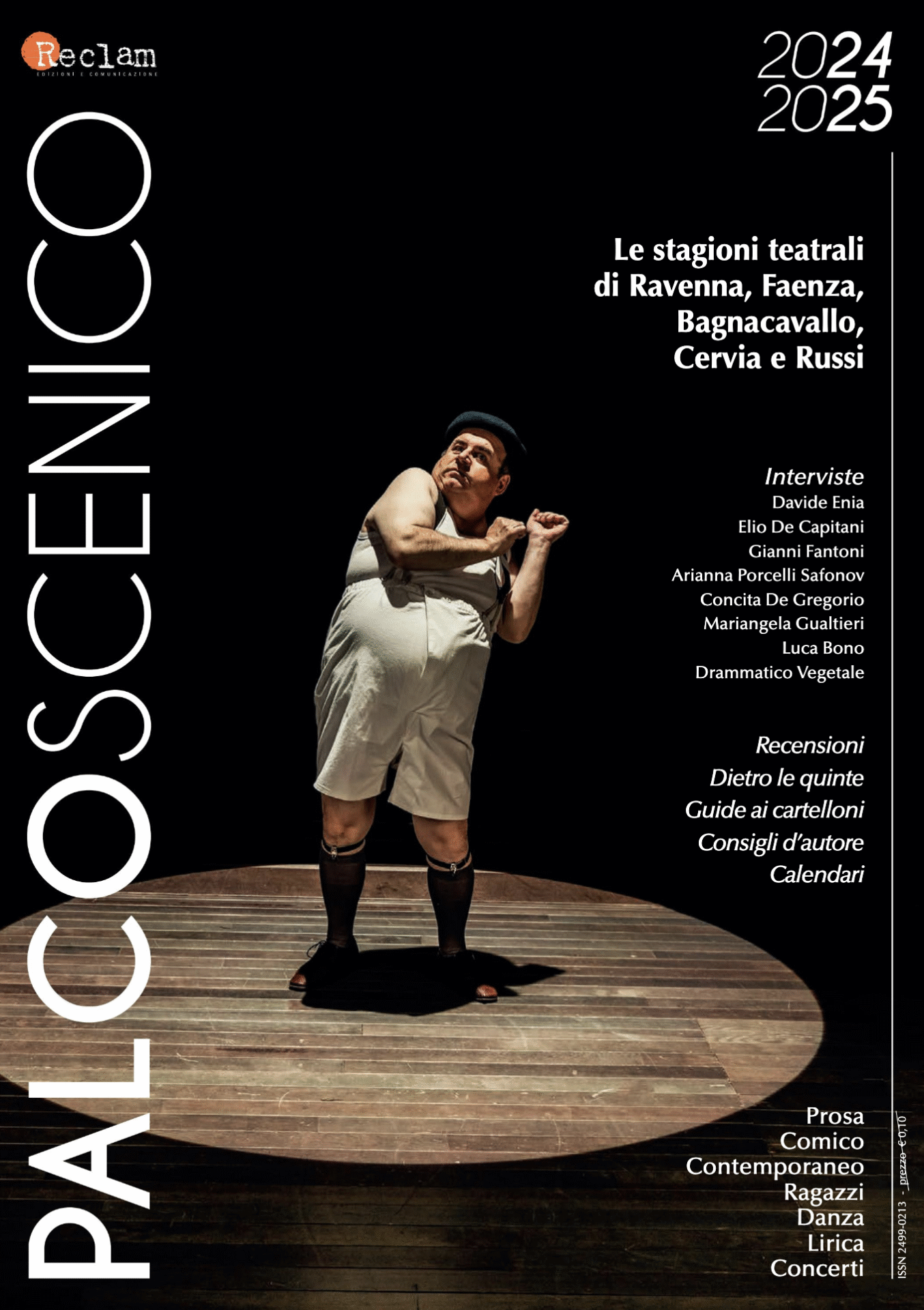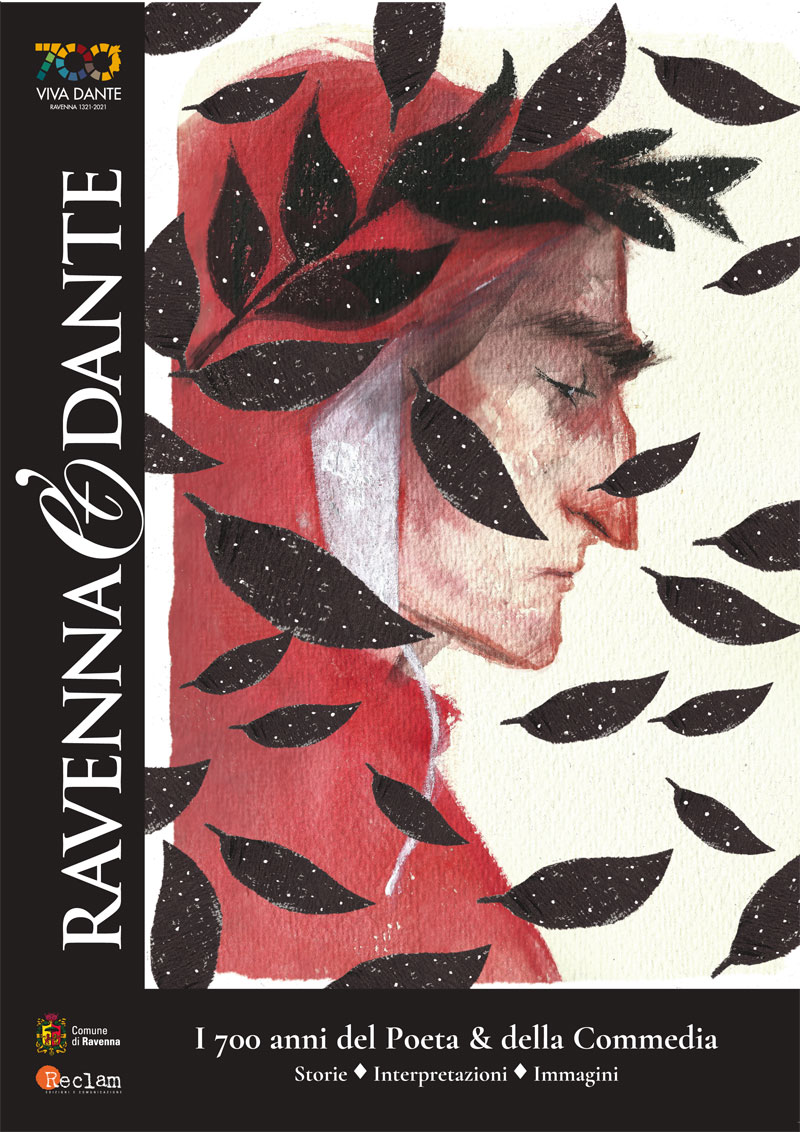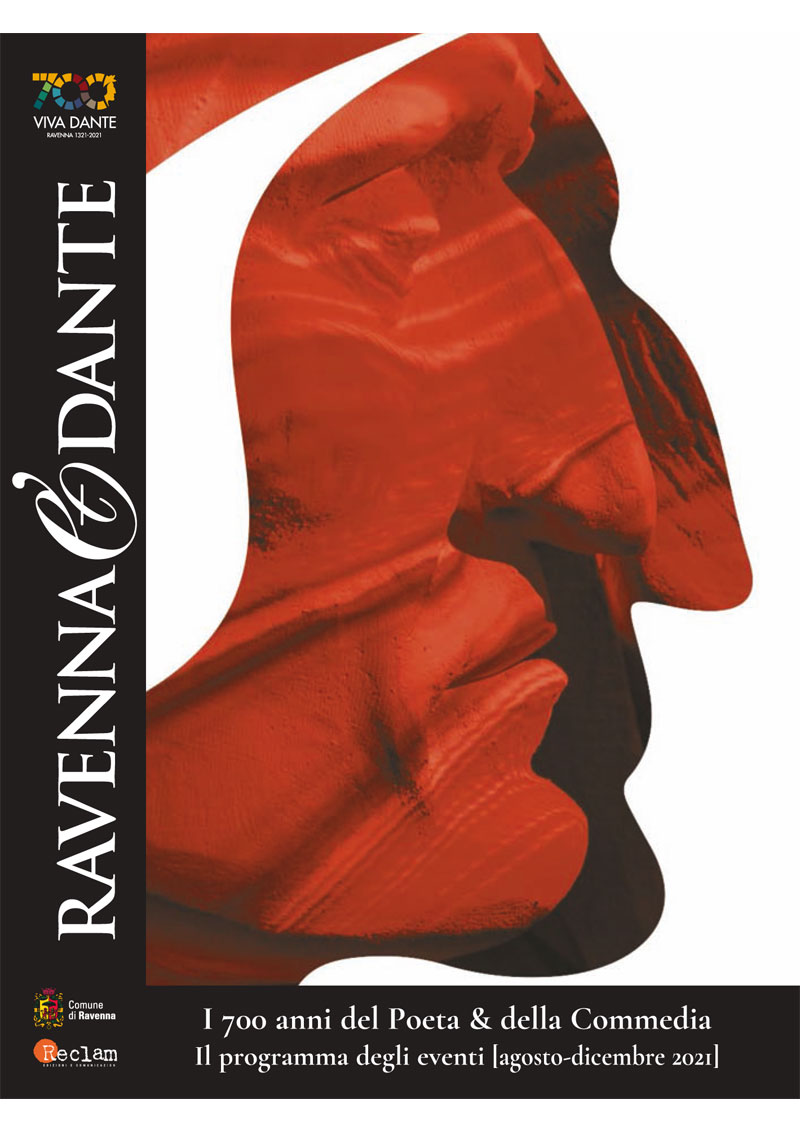Due sono i problemi principali per il nostro mare: le ondate di calore sempre più frequenti che causano morie di esseri viventi e l’aumento dei cosiddetti contaminanti emergenti nelle acque come farmaci per uso umano o sostanze chimiche attaccate alle microplastiche. La sintesi è dell’ecologo marino Massimo Ponti, professore associato dell’università di Bologna e coordinatore della laurea magistrale in Biologia marina al campus di Ravenna. Nella sua attività di ricerca si occupa di interazioni tra specie e degli effetti delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici nelle comunità marine costiere del Mar Mediterraneo e tropicali.
Due sono i problemi principali per il nostro mare: le ondate di calore sempre più frequenti che causano morie di esseri viventi e l’aumento dei cosiddetti contaminanti emergenti nelle acque come farmaci per uso umano o sostanze chimiche attaccate alle microplastiche. La sintesi è dell’ecologo marino Massimo Ponti, professore associato dell’università di Bologna e coordinatore della laurea magistrale in Biologia marina al campus di Ravenna. Nella sua attività di ricerca si occupa di interazioni tra specie e degli effetti delle attività antropiche e dei cambiamenti climatici nelle comunità marine costiere del Mar Mediterraneo e tropicali.
Professor Ponti, partiamo dalla carta di identità del mare Adriatico.
«L’Adriatico settentrionale è un mare molto particolare: è molto confinato, risente molto dell’apporto dei fiumi ed è poco profondo. Da Ravenna a Pola, in Croazia, in linea d’aria ci sono circa 130 km e la profondità arriva al massimo a 50 metri. Ai miei studenti dico sempre che se guardano una carta nautica è come avere una carta tridimensionale perché in proporzione lo spessore del foglio di carta è superiore alla profondità dell’Adriatico. Per queste ragioni alcuni ricercatori lo paragonano a un ambiente lagunare, ma io non sono d’accordo».
 Questa conformazione incide sulle sue condizioni?
Questa conformazione incide sulle sue condizioni?
«La modesta massa di acqua fa sì che sia il più freddo e il più caldo di tutto il Mediterraneo. In inverno la temperatura superficiale sotto costa arriva anche a 6 gradi e in laguna ghiaccia, mentre il Tirreno ad esempio non scende mai sotto 10-11 gradi. E in estate l’Adriatico può arrivare anche a 30 gradi: il 30 luglio davanti a Ravenna erano 28,7, temperature maldiviane. E così l’acqua si stratifica: sotto a 12-15 metri di profondità l’acqua rimane attorno a 14-16 gradi e quando la differenza è così ampia è come se avessi due strati separati, come olio e acqua: non c’è interscambio. La conseguenza è che sul fondo continuano processi biologici che consumano ossigeno ma da sopra non ne arriva e si possono verificare crisi anossiche».
Rispetto al passato, in cosa è cambiato?
«Il cambio principale è stata la riduzione di fosfati e nitrati riversati in acqua: i primi sono stati vietati nei detersivi dal 2013 e i secondi perché l’agricoltura è più attenta nell’uso dei concimi e abbiamo molti più depuratori. Di fatto erano dei nutrienti che concimavano il mare causando qualche volta uno sviluppo abnorme di alghe. Quindi su questo aspetto possiamo dire che l’uomo è riuscito a fare tanto. Però dobbiamo ancora prendere le misure con il nuovo scenario».
 Cosa significa?
Cosa significa?
«È come se avessimo avuto un mare “dopato”: era un motore che produceva tantissimo, sosteneva una produzione ittica notevole e aveva comportato un enorme sviluppo della flotta peschereccia con potenziamento delle tecniche e degli strumenti. Ora non è più così ma il settore pesca non si è ancora adeguato».
Il colore dell’acqua da cosa è determinato?
«La riduzione di trasparenza è causata da tutto ciò che è in sospensione e può essere di varia natura. Non è inquinamento chimico perché le sostanze chimiche si sciolgono. Il colore è dato dai sedimenti solidi sospesi di dimensioni non visibili a occhio nudo: in questo periodo ad esempio basta una mareggiata per rimettere in sospensione i fanghi che sono in quantità maggiori sui fondali dopo l’alluvione. Ma il colore può cambiare anche se l’acqua è ricca di fitoplancton: alghe unicellulari che raggiungono densità di milioni di cellule per litro e a seconda della specie vanno dal verde al rosso al marrone».
Che problemi causa la presenza massiccia di alghe?
«Semplificando, la biomassa algale produce ossigeno e poi lo consuma e finisce sul fondo dove va in decomposizione e abbiamo le acque maleodoranti. In alcuni casi se la decomposizione avviene in ambiente senza ossigeno si arriva a produrre metano e solfuri che danno il classico odore di uovo marcio che capita in laguna. E se cominciano a morire le alghe poi muore tutto il resto degli organismi».
Il colore però non è un indicatore dell’inquinamento. Post alluvione abbiamo imparato che la balneabilità dipende dalle concentrazioni dei batteri escherichia coli e enterococchi intestinali. C’è altro da tenere sotto controllo?
«Possono esserci sostanze chimiche che vengono misurate dalle agenzie ambientali. Nella nostra zona però non sono un grosso problema perché gli impianti di produzione trattano i rifiuti».
Lei si sente di fare il bagno in sicurezza?
«Nei primi giorni post alluvione no, ma adesso sì».
 I cambiamenti del clima stanno cambiando il mare?
I cambiamenti del clima stanno cambiando il mare?
«L’effetto principale è sulla temperatura. C’è l’aumento della temperatura media e ci sono le ondate di calore. Il primo causa l’innalzamento del livello perché una massa d’acqua più calda aumenta di volume. Gli scenari più pessimistici dei modelli storici ora sono diventati gli scenari più ottimistici. Lo scenario più catastrofico è lo scioglimento dei ghiacciai in Antartide: vorrebbe dire un aumento di sei metri del livello del mare. Lo scenario più prossimo però è lo scioglimento entro fine secolo dei ghiacciai principalmente continentali. Questo vorrebbe dire un aumento di circa mezzo metro».
E invece le ondate di calore che effetto hanno?
«Il pericolo maggiore è in autunno, quando gli organismi marini arrivano dalla sofferenza estiva in cui si alimentano meno e hanno speso le loro energie nei cicli riproduttivi. Se l’acqua è calda è un disastro e avvengono morie. Accade dagli anni ’90 ma la cadenza del fenomeno è passata da quinquennale a annuale. Il fenomeno è più evidente sui fondali rocciosi quindi per noi è meno esplicito ma l’abbiamo visto in passato con le morie di cozze».
Le attività umane incidono sulla qualità del mare. Turismo di massa sulla costa e crociere quanto pesano?
«Non molto. Le navi da da crociera hanno il trattamento dei rifiuti a bordo e non scaricano nulla nei porti. E per il turismo estivo l’importante è avere depuratori per il trattamento delle acque di scarico considerando che in certi mesi la pressione della popolazione decuplica».
Quali attività economiche sono più impattanti?
«La pesca a strascico è distruttiva. Si usa per vongole e canocchie, ad esempio, e rovina i fondali con le turbo soffianti. Stiamo pescando troppo e con tecniche distruttive».
Le plastiche sono il grande tema da affrontare per la salute del mare?
«È più corretto parlare di contaminanti emergenti, non in senso di galleggianti ma in senso di arrivati all’attenzione della comunità scientifica. E non si tratta solo delle note microplastiche. Queste causano danni per effetto meccanico: bloccano la respirazione e finiscono negli esseri viventi. Poi c’è tutto un altro fronte che ancora dobbiamo scoprire ed è quello delle sostanze chimiche veicolate da queste microplastiche: vernici, coloranti, filtri anti UV. Tutte sostanze attaccate ai polimeri di cui non conosciamo gli effetti. E poi aumentano le molecole di farmaci umani e fitofarmaci in agricoltura che non vengono trattenute dai depuratori. Servono per curare virus e batteri dell’uomo e limitare insetti dannosi nei campi, ma ancora si conosce pochissimo di quali siano i loro effetti sugli organismi marini, dai virus e batteri utili, fino ai pesci e cetacei, e quindi quali siano le conseguenze sugli ecosistemi marini».