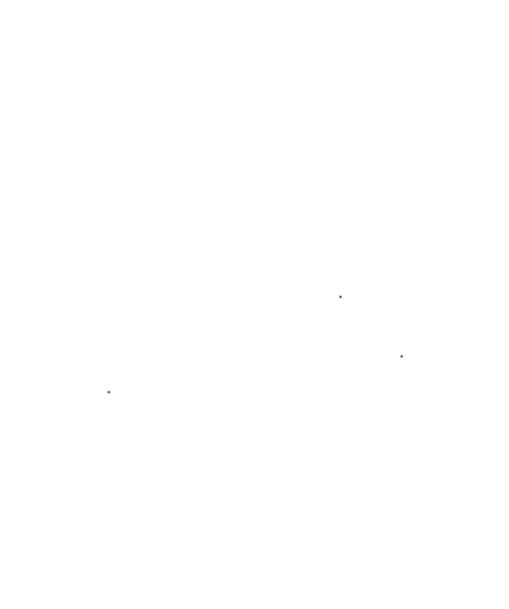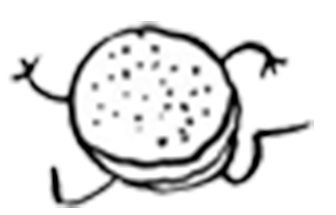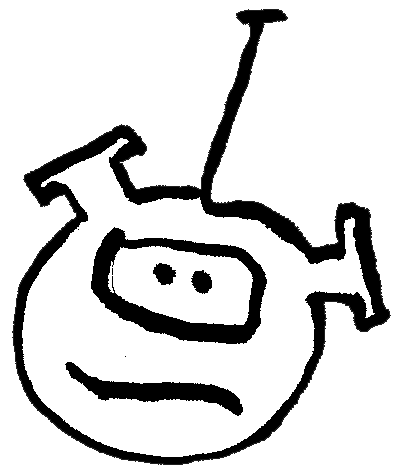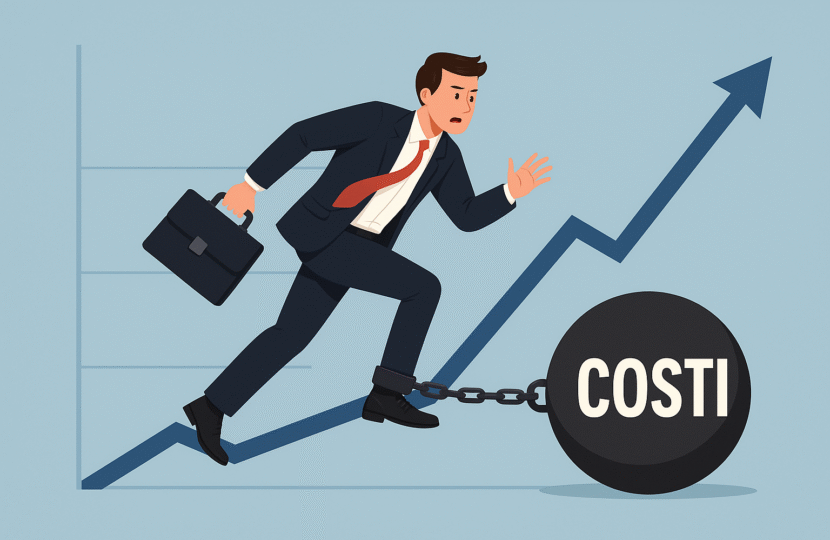Ravennate d’origine, classe 1971, Alex Majoli è una delle stelle più luminose del firmamento cittadino degli ultimi decenni.
Fotoreporter di fama internazionale, negli anni Novanta, ad appena vent’anni, ha lasciato il luogo natale per documentare i conflitti nei Balcani. Sono seguiti ulteriori viaggi ed esperienze – tra queste, il reportage sull’ospedale psichiatrico dell’isola greca di Lero, poi racchiuso nel suo primo libro fotograco Leros – e soprattutto la collaborazione con l’agenzia fotografica Magnum, di cui è stato presidente tra il 2011 e il 2014.
Una carriera piena di soddisfazioni per un ex ragazzo di provincia appassionato e desideroso di scoprire il mondo e le sue complessità.
Oggi Majoli vive con la sua famiglia tra New York e la Sicilia rimanendo però legato alle sue radici romagnole, come dimostra l’aver accettato per il secondo anno di fila l’incarico di direttore artistico del SI Fest, il festival di fotografia di Savignano su Rubicone, in programma dall’8 al 10 settembre e nei weekend del 16-17 e 23-24 settembre (a questo link il programma).
Lo abbiamo contatto per farci raccontare della nuova edizione, ma anche del suo rapporto con l’Italia, il giornalismo e, naturalmente, la fotografia.
Alex, quale impronta ha voluto dare al festival?
«Quando il sindaco di Savignano, Filippo Giovannini, e lo storico ideatore del festival, Mario Beltrambini, mi hanno contattato la prima volta, due anni fa, ho detto loro che se avessi accettato avrei fatto qualcosa di completamente differente rispetto al passato e rivolto agli studenti della città. Ho cercato di creare un programma che potesse essere utile a loro: l’idea era che i docenti avrebbero usato le fotografie per insegnare la loro materia, un modo per educare alle immagini spiegando allo stesso tempo discipline come la letteratura, la matematica e la scienza. L’anno scorso, quando ho finito il festival, il sindaco mi ha chiesto di replicare il mio ruolo di direttore artistico per il secondo anno e io gli ho chiesto se in città ci fossero anche delle carceri. Sembrava una battuta, ma io avevo già da tempo in mente un progetto con i detenuti».
La novità di quest’anno, infatti, è soprattutto il progetto nelle carceri dal titolo “Testimone oculare”. In cosa consiste? Qual è lo scopo?
«Il progetto nasce in collaborazione con la Casa Circondariale di Forlì. Quattro fotografi (Arianna Arcara, Cristina De Middel, Lorenzo Vitturi, Marco Zanella) si sono messi a disposizione di sei detenuti che hanno chiesto loro di fotografare tutto ciò che volevano vedere del mondo esterno. I detenuti hanno poi ricevuto anche dei libri di fotografia da leggere e da sfogliare, abbiamo creato un’interazione con loro».
Ha iniziato la sua carriera da fotoreporter nel 1989, documentando il conflitto in Jugoslavia. Allora aveva solo 18 anni. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta, a intraprendere un percorso lavorativo fatto anche di situazioni spesso molto difficili e pericolose?
«Faccio il fotografo da quando avevo 15 anni. Ho iniziato come assistente del mio maestro Daniele Casadio, dello Studio F45, che era specializzato in ritratto. Fotografavamo le piattaforme in costruzione a Marina di Ravenna, ma mi occupavo anche di matrimoni e di arte. In seguito, ho conosciuto Ettore Malanca, socio di Casadio; era un fotogiornalista e quando tornava in città dopo aver realizzato un progetto raccontava sempre dei suoi viaggi e del suo lavoro. Rimasi colpito: mi appassionava l’idea di viaggiare facendo fotografie. Da qui ho iniziato il mio lavoro di fotoreporter, che mi ha poi portato a fotografare anche i conflitti».
Che aiuto può dare la fotografia nel raccontare i fatti?
«Per molto tempo la fotografia, specialmente in Italia, è stata considerata l’illustrazione delle parole scritte dai giornalisti, con la differenza che la fotografia mostrava delle cose realmente successe, mentre le parole potevano inventare. C’è sempre stato uno scontro fra queste due arti, quella del parlare e quella del fotografare. In realtà, se ci pensiamo, anche la fotografia è una grande bugia. In un’ideale agorà in cui tutti devono trovare una forma per raccontare la verità, la fotografia è forse quella che porta più ambiguità perché si è obbligati a osservare attraverso lo sguardo del fotografo, che è sempre soggettivo. Certo, la fotografia ritrae un fatto realmente accaduto, ma sempre secondo l’interpretazione di chi la osserva; questi è sia il fotografo che la realizza, sia l’osservatore che la contempla, il quale attribuisce ad essa significati diversi anche in base al proprio vissuto e al proprio bagaglio emotivo».
Quali sono le caratteristiche che una “buona” fotografia deve avere?
«Non esiste una “buona” fotografia, come non esiste una buona opera d’arte. Esistono delle esperienze e degli esperimenti. La fotografia deve partire da un percorso sincero, spontaneo e genuino compiuto dal fotografo. Quando poi viene assimilata dalla persona che la osserva, lui o lei dovrà decidere cosa è quella cosa lì, cosa gli provoca a seconda del suo background storico e culturale. Una buona fotografia tocca i nervi di una persona, ma può essere “buona” per qualcuno e “non buona” per qualcun altro».
Oggi vive tra New York e Scicli, in Sicilia. Cosa ne pensa del giornalismo italiano? Rispetto a quello estero fa più o meno ricorso alla fotografia come strumento di indagine e testimonianza?
«Negli Stati Uniti la tradizione giornalistica basata sulle tre regole – where, when e what – vale ancora. Per ogni cosa che viene scritta c’è un fact-check, cioè un sistema per cui quando un giornalista scrive un pezzo, un suo collega controlla alla fonte se quello che ha scritto è vero. Negli Stati Uniti il giornalismo è una cosa seria, anche se poi non è detto che racconti la verità, si tratta pur sempre di uno sguardo soggettivo sulle cose. In Europa, invece, questa cosa del fact-checking praticamente non esiste. Per quanto riguarda la fotografia vale lo stesso principio: negli Usa le didascalie delle foto vengono controllate molto bene, quello che scrivi deve essere accurato. In Italia o in Europa non c’è questa attenzione, non fa parte della nostra cultura. Noi siamo più visionari, anche più creativi nel trovare soluzioni, mentre gli americani sono più pragmatici e rigidi».
E con Ravenna che rapporto ha? La considera ancora casa sua?
«Mio padre vive ancora a Ravenna, come anche amici storici e una parte della mia famiglia. Ma non la considero più casa. È una città perfetta, non ha niente di sbagliato, tutto funziona. Io però non riesco a vivere dove tutto funziona bene, non imparerò mai nulla. Ho bisogno di imparare dai luoghi in cui ti svegli alla mattina e c’è un problema da risolvere».
Adesso, oltre al festival, a cosa sta lavorando?
«Dopo il festival continuerò un grosso progetto che ho da tanti anni in Brasile e che diventerà anch’esso un libro. Nel frattempo, sto lavorando alla sceneggiatura di una sorta di documentario-film basato su una mia vicenda personale. Non ha ancora un titolo però, non so bene in quale forma uscirà».