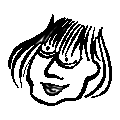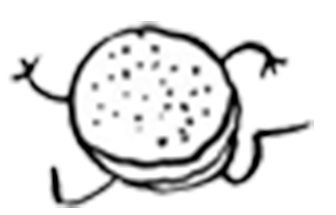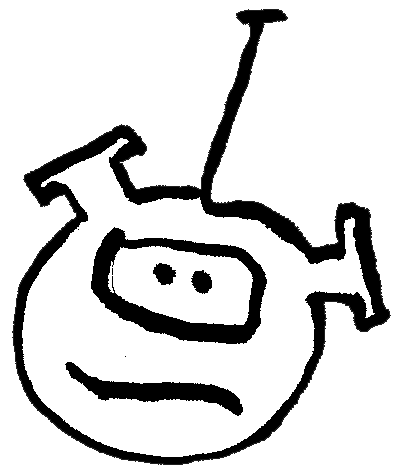L’infanzia segnata dalla guerra, il desiderio di vivere ascoltando e raccontando storie, il teatro, gli incontri, i viaggi attraverso i cinque continenti, di stazione in stazione. E poi l’impegno civile, lo sguardo attento alle ingiustizie del presente: la guerra, il terrorismo, le offese ai bambini, alle donne, alla natura. Dacia Maraini parla di sé, delle tappe e delle ragioni di un lungo percorso di scrittura e di vita.
L’infanzia segnata dalla guerra, il desiderio di vivere ascoltando e raccontando storie, il teatro, gli incontri, i viaggi attraverso i cinque continenti, di stazione in stazione. E poi l’impegno civile, lo sguardo attento alle ingiustizie del presente: la guerra, il terrorismo, le offese ai bambini, alle donne, alla natura. Dacia Maraini parla di sé, delle tappe e delle ragioni di un lungo percorso di scrittura e di vita.
In dialogo con Matteo Cavezzali, Maraini sarà protagonista dell’ultimo appuntamento di “Scritture di Frontiera” sabato 3 ottobre alle 11 alla Biblioteca Classense (posti esauriti, in streaming sulla pagina Facebook di ScrittRa festival), l’iniziativa nata dalla collaborazione tra ScrittuRa festival è l’assessorato all’immigrazione del Comune di Ravenna. L’incontro si terrà poi anche alle 21 al palasport di Lugo.
La sua famiglia è sempre stata in movimento, una famiglia migrante.
«Mia nonna paterna era mezza polacca e mezza inglese, si chiamava Yoї Pawloska Crosse e scriveva. Era una donna straordinaria, nel 1912 si metteva uno zaino in spalla e andava viaggiando a piedi per il mondo, cosa quasi impensabile per una donna allora: aveva un gran coraggio e un grande spirito di avventura. Un personaggio fantastico che ora sta di nuovo suscitando interesse, so che sono in corso di scrittura due biografie su di lei in Inghilterra e questo ovviamente mi fa molto piacere. Dopo essersi separata dal marito si trasferì a Firenze e qui incontrò e sposò mio nonno, uno scultore che fra l’altro ha inventato la Biennale di Venezia. Lui si era invaghito del primo fascismo, quello di Marinetti – il “nuovo socialismo”, come lo definiva Benito Mussolini all’inizio – e per questo entrò in conflitto con il figlio, cioè mio padre, che allora era uno studente di Antropologia ed era profondamente infastidito dal razzismo del movimento fascista. Nonno pensava che fosse un particolare che con il tempo si sarebbe smussato, non gli dava molta importanza, invece mio padre Fosco era come se avesse intuito l’orrore che stava per arrivare. Un giorno mio nonno portò a mio padre una tessera del Fascio, spiegandogli: “Senza questa non puoi lavorare”, e posandogliela in mano come fosse una necessità a cui adeguarsi senza tante storie. Mio padre, che aveva un carattere, diciamo “deciso”, strappò la tessera in mille pezzi e glieli buttò in faccia. Fu una rottura terribile, per trent’anni non si sono più parlati. E per di più in seguito a questo litigio mio padre se n’è andato di casa, nonostante fosse un ventenne che non guadagnava niente: per qualche tempo fu costretto a vivere di patate perché non poteva permettersi altro. Poi qualche anno dopo ha avuto la fortuna di vincere una borsa di studio internazionale per studiare da vicino una popolazione del nord del Giappone che si chiamava Ainu, un popolo di cacciatori di orsi, e allora con molto coraggio – che probabilmente gli veniva da sua madre – ha preso la giovanissima moglie e la figlia appena nata (che ero io) ed è partito per il Giappone».
In Giappone avete avuto la terribile esperienza del campo di concentramento, cosa ricorda di quegli anni?
«Vivevamo a Hokkaido, tra la neve. Eravamo molto integrati nella società locale: vestivamo alla giapponese, mangiavamo alla giapponese, io da piccolina parlavo perfettamente il dialetto di Kyoto. Nel 1943 purtroppo è cambiato tutto, perché l’impero nipponico ha firmato un patto di alleanza con Hitler e Mussolini e quindi è stato chiesto a tutti gli italiani che vivevano in Giappone di firmare un’adesione formale alla Repubblica di Salò. Mio padre e mia madre hanno deciso di non aderire, nonostante molti altri connazionali avessero firmato, considerando quell’atto come una formalità. Loro invece, con l’idealismo dei giovani che credono nelle loro idee, hanno detto no, decidendo di rischiare la rappresaglia che sarebbe arrivata per questa scelta. È stato per la nostra famiglia un momento decisivo, perché ci hanno preso, caricato su un camion e portato in un campo di concentramento non lontano da Hiroshima. Siamo rimasti là due anni: non c’era lo sterminio come nei lager nazisti, ma la vita era molto molto dura per la fame, il freddo e i parassiti. Ogni giorno le guardie ci contavano e ci dicevano che appena ottenuta la vittoria ci avrebbero tagliato la gola: immaginate una bambina della mia età quale terrore poteva provare, mi ricordo che ogni sera con sollievo pensavo “Siamo ancora vivi”, pensa questa infanzia come ha influenzato la mia vita. Mio padre diceva sempre ai guardiani del campo: “Ma le bambine” – perché nel frattempo erano nate le mie due sorelle, io avevo sette anni, un’altra quattro e la più piccola due – “non sono prigioniere politiche, non potete trattarle così!”, però i giapponesi rispondevano che noi eravamo traditori e i traditori non hanno diritti. Allora mio padre, scavando nelle sue conoscenze antropologiche, ha tentato una mossa disperata: sapeva che esisteva una tradizione samurai definita “yubikiri” per cui se un uomo si taglia un dito e lo tira addosso al nemico gli crea un’obbligazione e gli impedisce di considerarlo un vile. Coraggiosamente mio padre Fosco ha preso un’accetta, si è tagliato un dito e lo ha gettato addosso alla guardia che ci sorvegliava. Lì per lì ha ottenuto solo calci, pugni, urla, però poi incredibilmente – l’Antropologia qualche volta serve, dunque! – i giapponesi hanno smesso di darci dei vigliacchi e insultarci e ci hanno regalato una piccola capra che faceva del latte: e quel latte ci ha salvato la vita. Dopo le bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima alla radio l’imperatore giapponese dichiarò la resa (e non era mai successo né che l’imperatore, considerato un essere divino, parlasse alla radio né che il Giappone si arrendesse) in contrasto con i suoi generali che volevano combattere fino alle estreme conseguenze, al sacrificio. Senonché parlava un giapponese antico, che nessuno capiva, e mio padre – che lo aveva studiato all’università – faceva da traduttore alle guardie dubbiose. Poi per fortuna siamo potuti rientrare in Italia, però non avevamo niente, dovevamo ricominciare tutto da capo: mio padre si mise a fare il fotografo. Rimase comunque legato al Giappone, ci andava spesso e anni dopo ha sposato in seconde nozze una giapponese. Il campo di concentramento ha ovviamente rappresentato per me un’esperienza terribile, che mi porto addosso come una ferita non ancora sanata. Infatti non sono mai riuscita a scrivere un libro sugli anni nel campo di concentramento: ne ho parlato qui e là, ma un libro intero non sono ancora riuscita a scriverlo, è un ricordo che smuove troppo dolore. Però ho promesso a me stessa che prima di morire lo scriverò, e lo farò».
Da ragazza ha frequentato molti dei grandi della letteratura del 900, quale incontro ricorda con più emozione?
«Ricordo ancora la trepidazione con cui sono andata in casa Montale. Mi ero preparata un mucchio di domande sul suo lavoro, sulla sua poesia, ma poi quando mi sono trovata davanti a lui non sono quasi riuscita a spiccicare parola. Con molta titubanza e una voce di formica gli ho chiesto qualcosa sulla sua famiglia. Mi sembrava una zona più sicura, meno scivolosa per me: come potevo parlare di letteratura senza mostrarmi presuntuosa o sciocca? Montale non fu affatto gentile. Cominciò con un tono risentito e scorbutico, ma poi, man mano che parlava dell’infanzia la sua voce è diventata più mossa, più partecipe e questo mi ha dato coraggio. L’intervista piacque, cosi com’era, secondo me sbilenca e monca, ma scorrevole e sincera».