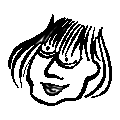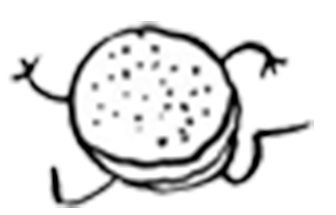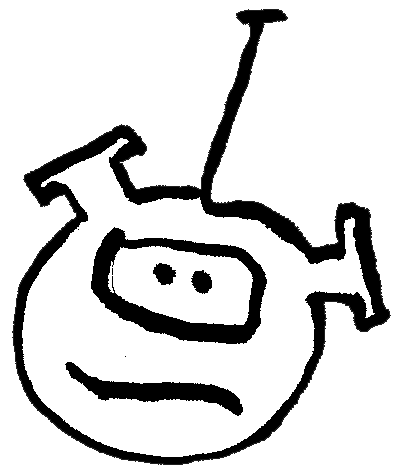I “bottoni” di Ravenna

Vero “viaggiatore” e non semplice “turista” – secondo la nota distinzione di Paul Bowles1 – a velocità “ruskiniana”, sulla sua «vetturetta di cilindrata minima»,2 il signor Dido, alias Alberto Savinio, alias Andrea De Chirico, incontra Ravenna. Come John Ruskin, infatti, che voleva abolire i treni per le carrozze a cavalli e i piedi, il signor Dido non ha fretta. Vede gli altri automobilisti che lo superano a tutta velocità, guardandolo come un povero «vecchietto», e pensa che «corrono velocemente alla morte». Di più: «sono già morti», e invece «guardano lui […] come un morto».
Il signor Dido «ama più il presente che il passato». Ci tornerà utile, più avanti, parlando del «molle» Onorio. Il signor Dido non ha itinerari da rispettare, non ha con sé il “Baedeker”, guida indispensabile per ogni accorto “turista” e quando vede «un cartello con su scritto: Ravenna», si dispone senza tema all’incontro con l’incognita città e dice alla signora Dido «Fermiamoci a Ravenna». Anche se lo dice «senza calore». Premonizione?
Venendo dalla strada che collega Rimini a Ferrara, allora Romea, il signor Dido entra in città percorrendo il borgo Garibaldi e passa sotto la porta Garibaldi, già Pamphilia e ancor prima Gregoriana, oggi porta Nuova. Immediatamente Ravenna gli fa «uno strano effetto»: «Tutte le città – pensa il signor Dido –, anche le più pudiche, hanno un punto, mercato o rione popolare, in cui i visceri della città vengono fuori». Ravenna è un’eccezione, la eccezione: «Ravenna è abbottonata fino al pomo d’adamo nel suo abito di pietra». Il …“ventre” di Ravenna è ben nascosto, non solo agli occhi di un viaggiatore. Anche molti che ci vivono non l’hanno ancora scoperto.
Verso mezzogiorno al signor Dido viene fame. E se c’è una cosa che a Ravenna tutti i viaggiatori hanno sempre trovato, è un buon ristorante.
Anastagi, chi erano costoro? Il signor Dido e la toponomastica

Il signor Dido, entrato da porta Garibaldi, percorre – non era ancor vietato al traffico – l’allora corso Garibaldi (oggi via di Roma) – a quel tempo l’eroe dei due mondi era ancora qualcuno – sezionando da parte a parte la città, «senza avvedersene»: tanto Ravenna può essere attraversata senza lasciar trapelare nulla di sé.
Giunge così all’angolo di una via il cui nome lo porta lontano con la catena delle assonanze: via Anastagi.3 Oggi – «La forme d’une ville change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel», ci ammonisce Baudelaire4 – la via è divenuta un parcheggio («Prima era un tango, adesso è un parcheggio»,5 afferma sconsolato Pepe Carvalho, per un analogo abbattimento, in nome del “progresso”, di uno storico edificio del ballo a Buenos Aires), dopo la distruzione del quartiere di San Vittore, per metà operato dai bombardamenti alleati, per metà dalla speculazione edilizia. Un incontro con un nome che piace al signor Dido. La potente famiglia degli Anastagi, signori feudali, è ricordata da Guido del Duca, assieme ai Traversari, nei versi 107-108 del canto XIV del Purgatorio. Apparsa sulla scena nel XII secolo, è già «diretata» – «spenta»,6 come traduce Corrado Ricci –, al tempo di Dante.
Al signor Dido il nome Anastagi fa subito venire in mente Nastasio degli Onesti della novella ottava della quinta giornata del Decameron, con la «tragica cavalcata attraverso la pineta di Chiassi, davanti ai giovani e alle giovani raccolti in un desinare».
Casi del destino: Nastagio/Anastasi ama, non corrisposto, «una figliuola di messer Paolo Traversaro».7 Nella pineta di Classe ha luogo l’incontro col suo alter ego, Guido degli Anastagi, specchio perfetto del pericolo cui va incontro ogni mal d’amore.

Cucina multietnica
Il signor Dido è di fronte a via Anastagi e i ricordi si affollano: «Nastagio, ossia Anastagio, ossia Anastasio: il Resurto». Occorre un po’ di pratica di greco, visto che Savinio è nato in quelle terre, precisamente ad Atene, nel 1891. Un nome simbolico, “doppio”, come tutti i veri simboli (sumbállo: «getto insieme» e súmbolon, una tessera di terracotta che si spezzava in due e che si conservava, per denotare un legame o un’alleanza tra due individui o due città) che mettono assieme in concordia discors due cose in apparenza antitetiche: Anastáseos, al tempo stesso, da un lato, l’“elevare”, la “risurrezione” e, dall’altro, la “demolizione”, la “rovina”. «Resurto», dice il signor Dido, da “resurgere”, variante letteraria arcaica di “risorgere”. Che sia un simbolo anche di Ravenna, ex capitale e capitale mancata, sempre in attesa di “resurgere”?
Ma lasciamo l’arida filologia, perché il signor Dido, come detto, ama il presente: «Andare tutti insieme sul fiume del Presente: questa la via per il signor Dido. E quando il fiume del Presente imbocca la galleria chiamata Passato, entrare tutti assieme nella morte: questo è l’amore per il signor Dido».
La fame, si sa, non aspetta l’erudizione: e il signor e la signora Dido entrano in un «ristorante che sopra è albergo». Una guida Touring dell’epoca, forse, ci aiuterebbe a rintracciarlo. Ma che importa! Ciò che conta è la “multietnicità” di Ravenna: «Si misero a un tavolino. Sedevano agli altri tavolini stranieri di varie razze, di vari sessi, di varie età. Tiravano su spaghetti, lasagne, fettuccine: se le introducevano in bocca con diligenza, come se si applicassero per mezzo di quei cibi a imparare l’italiano».
Da sempre il Bel Paese è apprezzato dagli stranieri per i suoi paesaggi, la sua arte e la sua gastronomia, che, come afferma Pepe Carvalho, assieme al «sesso» è la cosa più seria che esista.8
La storia vista dal buco. Un imperatore imbelle e un genio
Una guida poliglotta «in giacca a vento e occhiali neri» richiama all’ordine i turisti in tre lingue: alle tredici e quarantacinque, visita ai monumenti! Come un sol uomo, all’annuncio, il gruppo esce, incolonnato. Il Passato, di colpo, fa la sua irruzione nel Presente del signor Dido: «Ho finito di mangiare: dovrei andare a rievocare sui monumenti la storia di Ravenna». A questo pensiero il signor Dido si sente «infelice»: «Non è che il signor Dido non ami la storia: l’ama ma preferisce guardarla attrverso il buco della serratura». E, attraverso questo buco, il signor Dido guarda la storia di Ravenna: gli appare una sala da pranzo, anche se vecchia di alcuni secoli rispetto a quella in cui sta comodamente seduto; e una scena assai poco solenne si svolge sotto i suoi occhi. Vede Onorio, primo imperatore romano d’Occidente – dopo la divisione in due dell’Impero – e fratello di Galla Placidia. «Molle di carattere», scambia “Roma” con la sua amata omonima gallina e gli viene quasi un colpo quando un nunzio gli porta la notizia che i barbari «hanno preso Roma». «Scemo! […] Me lo potevi dire subito!», è la sollevata risposta di Onorio quando si rende conto dell’abbaglio. La storia “alta” di Ravenna non merita, agli occhi del signor Dido, di essere sbirciata, dunque, che dal «buco della serratura».
Liquidata la Storia, il signor Dido cerca una «camera fresca» per un «magnifico sonno ristoratore». E sogna. Sogna «il suo amico Enrico. E chi altro avrebbe sognato il signor Dido a Ravenna?». Ora sappiamo che da noi non solo è morto un genio, ma ne è anche nato uno: Enrico Galassi.9
L’infanzia di Enrico
Il signor Dido non ci svela il cognome di Enrico. Ci dice soltanto che è nato «un po’ meno di cinquant’anni sono» a Ravenna. Il padre, «restauratore di mosaici», pensa di trasmettere a Enrico, il «più geniale dei suoi tre figli», «i segreti» di un’arte «difficile e paziente». A Enrico il signor Dido dedica buona parte dei ricordi della visita a Ravenna. Ne viene fuori uno spaccato di storia ravennate assai più vivo di tanta un po’ noiosa agiografia nostrana. «Uscivano padre e figlio da Porta Garibaldi che era ancora notte, traversavano il Canale del Molino Lovatelli [oggi non più in uso e “gambizzato” dall’interramento del canale], si mettevano per la campagna diretti a Sant’Apollinare in Classe, ove in quel tempo si stavano eseguendo importanti lavori di restauro.10 A metà strada si fermavano a una bettola. Era uno stanzone enorme e nero, in mezzo al quale ballavano le fiamme di un braciere». Una storia materiale di dignitosa povertà. Piatti “caldi” e “freddi” si alternano: «C’era tra quei clienti mattutini anche l’accalappiacani, tirava fuori dal tascapane un pezzo di carne, lo buttava nella padella; e anche i più ignari di zoologia riconoscevano in quel pezzo di carne un coscio di cane. C’era anche il serparo, ma costui mangiava freddo. Tirava fuori della bisaccia a tracolla una biscia, la stringeva viva e guizzante tra le dita, intingeva la punta nella ciotola del sale posata in mezzo alla tavola, addentava, masticava». Riprova evidente che la cucina non è che la «dissimulazione del cannibalismo».11
Questa è l’unica storia ravennate che il signor Dido dimostri di apprezzare. Quella legata direttamente alle persone, anche alle persone qualunque. Ma Enrico non è affatto una persona qualunque.
Virtus et (S)fortuna
Enrico, come tutti, attraversa l’«infanzia» e l’«adolescenza». Anche se, a differenza dei più, diventa «uno degli adulti più geniali che il signor Dido avesse mai conosciuto». Come ogni genio, opera in campi diversi, contro ogni tranquillizzante orticello: «pittore, architetto, scrittore, ideatore di infiniti progetti».
In qualità di pittore è precocissimo: i suoi primi disegni e tempere risalgono alla fine degli anni Venti. Benché poi esponga, fuori dal piccolo mondo ravennate, a varie quadriennali romane, a Parigi, Stoccolma, Oslo, Londra, in Svizzera e in America, aspetta ancora di essere “rivisitato e rivalutato”.12
Come architetto, nel 1936, progetta proprio la casa di Savinio a Poveromo, vicino a Forte dei Marmi, in Versilia, dove Enrico vive a lungo in compagnia di Lorenzo Viani, Enrico Pea, Moses Levy e Krimer (alias Cristoforo Mercati). Di questa casa, «mègaron straordinario»,13 tuttora esistente, lo stesso Savinio ce n’ha data una descrizione magistrale: «La mia casa Galassi l’ha disegnata a forma del più casalingo degli animali: a chiocciola. Galassi è stato a Ibiza, che è la più piccola delle Baleari. […] A Ibiza le case portano davanti alla fronte un gran muro pieno, che le guarda dai grandi venti del largo. Nella mite foresta del Poveromo i grandi venti del largo non arrivano, ma davanti alla mia casa Galassi ha alzato ugualmente un gran muro pieno e curvato a S, e questo muro, nonché guardarmi dai grandi venti metafisici, segna perentoriamente la lettera iniziale del mio nome».14 Delle tante villeggiature della famiglia Savinio al Poveromo ne rimane testimonianza solo una foto, con Savinio e la moglie affacciati ad una finestra della casa.
Enrico, come spesso accade ai geni, è stato «sempre guardato in cagnesco dalla sorte»: «ora, dopo tanto lavorare, dopo tanto ideare, dopo tanto progettare, è povero, malato. Abita dentro un corridoio, sul tetto di un vecchio e illustre palazzo romano;15 un corridoio che mediante un gioco di coperte tirate da muro a muro egli ha trasformato in un molle labirinto; un molle e ondeggiante labirinto che una bambina traversa e ritrova quale una piccola luce danzante: Donnina,16 la figlia di Enrico; una bambina di cinque anni che se Mozart l’avesse conosciuta, avrebbe scritto apposta per lei un’operina della sua musica più sottile e scintillante».
Enrico Galassi, nato a Ravenna il 14 novembre 1907 e morto a Pisa il I° settembre 1980, forse unico genio assieme al “nostro” Corrado Ricci, di questa terra aspra per i geni (a uno, fra i più grandi, è stata fatale). Del tutto ignoto alla sua città natale.
Dante, scultore di parole
Tra tutti i possibili monumenti di Ravenna, cosa decide di visitare il signor Dido, dopo la prevedibile sollecitazione – «E i monumenti?» – di una pazientissima signora Dido? Naturalmente… la tomba di Dante. Dante è poeta-scultore: «trasforma la parola in forma scolpita». Alcuni modellano «con la mano». Dante «con la lingua e con le labbra». E dalla sua bocca – «per quanto stretta e risucchiata» – esce un «lungo nastro» di «marmo formato». Vero re Mida della poesia, tutto quello che tocca acquista valore: come quando, per non dire il nome del monte (Pisano o di San Giuliano) che divide Lucca da Pisa, impiega un’intera terzina (Inferno, XXXIII, 28-30).
Sovrintendenti catene «sospese a festone» sbarrano la strada alla sua pur quasi pedonale vetturetta e il signor Dido, come tutti i mortali, si reca a piedi in devoto/dovuto pellegrinaggio alla tomba «dell’Altissimo poeta».
Subito un parallelo, senza pudori di falsa modestia, balena nella mentre del signor Dido: Dante, qui, nella zona del Silenzio (ma silenziosa lo era divenuta solo da un paio di decenni, dopo la realizzazione del progetto di sistemazione degli anni Trenta), riesce a «dormire». Non il signor Dido nel suo «pianterreno» di Roma, dove, oltre a dormire, lavora «dodici ore al giorno». Zone di rispetto, infatti, il signor Dido non ne ha e, novello Giovenale (Saturæ, III, vv. 235 sgg.), ripensa ai «veicoli che corrono rombando sotto le […] finestre» e che gli «mandano il cervello per aria».
La retorica, evidentemente, non piace al signor Dido e allora la scritta «Dantis poetae sepulcrum», non può non stimolarlo: «Perché poetae?». «E perché quel latino» per «il più italiano dei poeti»? Chi lo ricorderebbe, oggi, «se avesse scritto soltanto libri in latino»? Quanto «Petrarca come autore dell’Africa».
“Mosaici” e “Musaici”. La fuga del signor Dido
«E i musaici?». Dopo aver visto naufragare l’idea di visitare i monumenti (per il signor Dido, è Dante un monumento in carne, ossa e parola), la signora Dido prova, candidamente, con l’asso nella manica della città. Era tutta intenzione del signor Dido, naturalmente, di visitare i «famosi mosaici», ma «la signora Dido non disse mosaici, disse musaici»: e «certe parole agiscono sul signor Dido come respingenti».
È ormai troppo tardi. Quando la signora Dido esclama (stupita, ma non troppo, abituata com’è alle stravaganze del signor Dido»): «Come non ti piace l’arte musiva?», il signor Dido, infatti, sta già «uscendo dalla città». Non solo: accelera (cosa per lui straordinaria). Quello che sarà il futuro patrimonio mondiale dell’umanità viene clamorosamente dribblato dal signor Dido: le basiliche, il mausoleo di Galla Placidia e, last but not least, il Guidarello – allora ancora alieno da pericolose insinuazioni sulla sua paternità – nonostante «non sia un musaico, ma il pensant maschile della lucchese Ilaria del Carretto». C’est égal, dice la signora Dido, ma non riesce a trattenere una rimostranza garbata che sottolinea, a suo parere, un paradosso bell’e buono: «Venire a Ravenna e non vedere Sant’Apollinaire!». Apollinaire? Un lapsus spiegabilissimo: la signora Dido «ama i poeti francesi di questi ultimi cinquant’anni».
Non è che l’ultimo motto di spirito di Alberto Savinio, alias signor Dido (o viceversa?). Suprema, straordinaria ironia di un grande artista (come il suo grande amico Enrico), nonché acutissimo, impagabile viaggiatore del Novecento appena trascorso. Veni, vidi, vici: Savinio si ferma appena un giorno a Ravenna ma è quanto basta per mettere allo scoperto, con straordinaria leggerezza, le nudità, bizantinamente nascoste, di un’abbottonatissima città.
Non lo ringrazieremo mai abbastanza.