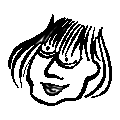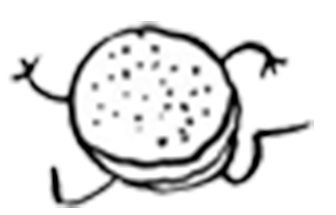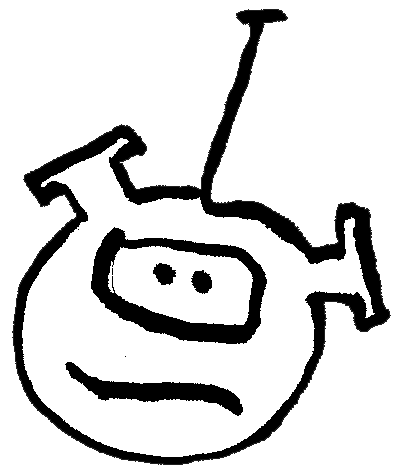La Madonna della Misericordia di Piero della Francesca e la Silvana Cenni di Felice Casorati sono a tutti gli effetti gli estremi significativi della mostra in corso ai Musei di San Domenico di Forlì, dedicata al grande maestro prospettico toscano – se non il monarca, almeno un principe del Quattrocento italiano – e ai suoi influssi sull’arte attraverso i secoli, fino ad arrivare a quella indagine capillare che numerosi artisti italiani dedicarono alla sua opera fra gli anni ’20 e ’30 del ‘900.
La Silvana Cenni di Felice Casorati, una grande tela eseguita nel 1922, chiude praticamente il percorso espositivo rendendo chiaro quanto l’analisi dell’artista piemontese dovesse a Piero: una cromia giocata su poche tonalità controllate e opalescenti, e una geometria spaziale perfetta a cui il cervello si aggrappa come all’ultimo respiro. Poco importa che il punto vita della Cenni sia talmente stretto da pregiudicare la sopravvivenza della donna: quel respiro a cui si alludeva è una funzione metaforica dell’occhio che rimbalza dal semicerchio della scollatura della donna all’ovale della sua blusa bianca, dal rettangolo della finestra che inquadra la figura alle rette perpendicolari del soffitto di legno agli oggetti sparpagliati prospetticamente a terra.
Casorati è forse l’unico che abbia pienamente compreso la potenza del genio di Sansepolcro, le regole del suo lavoro – prospettiva e luce – e i suoi esiti finali. Molti epigoni si sono limitati a riprendere quel sistema geometrico di resa tridimensionale scaturito da un’interpretazione razionale del mondo, altri hanno invece compreso l’analisi di una luce naturale di origine fiamminga che per una strada diversa è in grado di costruire lo spazio. Pochi invece, e fra questi è Casorati, hanno sospinto la rappresentazione in un’atmosfera rarefatta dove al mondo è sottratta ogni possibilità di vita ma a cui è donata in cambio l’eternità. C’è chi ha ricordato in passato come Piero della Francesca può essere venuto in contatto con la filosofia del contemporaneo Nicola Cusano, il che spiegherebbe come la conciliabilità degli opposti – una luce naturalissima e una contraddittoria geometria pervasiva – costituisca l’unica strada possibile per la rappresentazione del divino. Forse questa non è l’ultima meta spirtituale di Casorati, ma la sua pittura raggiunge un effetto spiazzante, determinato proprio dalla coesistenza armoniosa di queste contraddizioni.
L’esito è altissimo e, mi dispiace, non accessibile a tutti: la seconda parte della mostra si sviluppa quindi per mostrare i riecheggiamenti – veri o presunti – di Piero della Francesca in numerosi artisti italiani, puntando decisamente ad alcuni veristi e al gruppo dei Macchiaioli, poi alla generazione di artisti attiva fra gli anni ’20 e ’30.
Per quanto riguarda i primi – fra cui ricordiamo presenti alcuni dipinti di Silvestro Lega, Odoardo Borrani e Telemaco Signorini – direi che la tesi di un richiamo a Piero non è del tutto convincente: la luce naturale è il punto di partenza dell’estetica del gruppo ma nel senso di un’aderenza profonda alla verità della visione. Nulla di più lontano da Piero della Francesca, che – come si diceva – non mostra nessun interesse verso il contingente, ad eccezione del fattore luce come elemento antitetico. Forse vi si avvicinano maggiormente le ambientazioni pacate e silenziose di Lega, ma la sua lucida descrizione della realtà assomiglia più alla sospensione di un attimo che ad un un’uscita dal mondo.
In mostra, a piano terra, si dimostra come l’artista toscano fosse stato completamente dimenticato dopo la grande stagione del Rinascimento maturo e come questo paradossale oblio venga interrotto da alcuni artisti e intellettuali stranieri nel corso dell’Ottocento. Sono quindi gli affreschi di Piero ad Arezzo a convergere gli interessi di un artista tedesco come Johann Anton Ramboux, vicino al gruppo dei Nazareni nella prima metà del XIX secolo, o quelli del francese Charles Loyeux, che li copia a grandezza naturale verso la fine dell’Ottocento. Occorre invece aspettare il circolo londinese di Bloomsbury – nelle figure di Roger Fry e Duncan Grant – e le illuminazioni di un lituano naturalizzato statunitense, ma profondamente italiano per cultura e biografia, come Bernard Berenson, per restituire agli studi la vera dimensione della grandezza di Piero della Francesca.
L’approdo di questa riscoperta in Italia all’inizio del ‘900 incrocia l’attento sguardo di Roberto Longhi e da qui in poi il definitivo recupero è cosa nota. Longhi è figura centrale della cultura italiana del Novecento e nessuno poteva o può non tenere in conto il suo giudizio: l’ambiente artistico italiano postavanguardista lega la scoperta del toscano alle necessità di un linguaggio monumentale dalle radici “italianissime”, come voleva la cultura fascista.
La purezza di Piero e la tecnica dell’affresco incontrano i favori di un’estetica che doveva spiegare la grandezza del genio nazionale, illustrandola su grandi pareti con soggetti adeguati e dettati dal potere. Difficile vedere affinità con Piero se non tangenziali nelle opere di Ferruccio Ferrazzi e Pino Casarini o negli esponenti del gruppo “Novecento”: si tratta di citazioni letterali o riprese di aure sospese, di geometrie precise e luci fredde che si limitano a esplorare un insieme di regole visive.
A parte la pittura di Casorati che vive delle stesse contraddizioni volute da Piero, si avvicina più alla pittura del maestro toscano chi – fra i pittori – meglio lo tradisce. È il caso di Antonio Donghi – di cui sono in mostra tre dipinti eccezionali – che dimentica la luce pierfrancescana sostituendola con un’altra innaturale, ottenendo comunque lo stesso l’immagine di un mondo slittante fra reale ed eternità; è ancora il caso del Temporale (1933) di Capogrossi, che rinuncia alla definizione pittorica e alla luce naturale, ma restituisce un’immagine sospesa, ambigua, in cui la geometria sembra costituire la possibile via di fuga dal mondo. Il rimando all’esperienza di Morandi – anch’egli in mostra con alcune tele di proprietà di Roberto Longhi – è quasi scontato. Ma per tutti questi grandissimi autori – Donghi, Capogrossi, Morandi, Guidi, Funi – e per la loro produzione degli anni Trenta, occorre ricordare che ben oltre a Piero c’erano state le esperienze (indimenticabili anche per i ciechi, sordi e muti) delle Avanguardie e, soprattutto, della Metafisica e del Surrealismo. De Chirico è in mostra a Ferrara, ma è più vicino in linea di spirito a molti di questi dipinti di quanto lo siano in linea d’aria quelli di Piero.
Rimane il fatto che a Forlì è possibile vedere opere antiche e moderne – spesso in relazione diretta, se pure ricca di fraintendimenti, con alcune opere di Piero – prestate eccezionalmente da collezionisti privati e musei europei e d’oltre Oceano. Interessanti sono ad esempio alcuni piccoli esemplari di Seurat – un altro “traditore” che ha compreso la fuga verso l’eterno del maestro di San Sepolcro – e due grandi dipinti di Puvis de Chavannes – Le ballon e Le pigeon (1870, 1871) – che respirano la stessa sospensione del tempo, l’inattualità del gesto e del corpo, trasformandosi in un puro esercizio di intelletto così gradevole rispetto a tante sciatterie del Simbolismo.
E per chi non fosse interessato alla linea critica che esplora i conti fra i dare e gli avere tra le opere di Piero della Francesca in mostra – poche ma eccezionali, come la Sant’Apollonia della National Gallery di Washington DC o la Madonna con Bambino di Newark – e gli artisti delle generazioni successive fra Otto e Novecento, rimane più di un motivo per andare a vedere questa mostra: incentrata non solo sulla figura del grande artista toscano, le sale dispongono una serie di opere di artisti precedenti e contempoeanei – Domenico Veneziano, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Beato Angelico – e altri che a lui sono direttamente debitori fra Romagna, Marche, Emilia, Roma e Venezia, come il Palmezzano, Cristoforo da Lendinara, Francesco del Cossa, Ercole de’ Roberti, Bartolomeo della Gatta o Antoniazzo Romano. Se alcune di queste opere sono state mal scelte – non tanto per gli influssi, indiscutibili, ma perché talvolta restaurate da manine che andrebbero mozzate prima dei danni – è pur vero che ci sono capolavori a breve distanza che da soli valgono un giro ai Musei di San Domenico. Uno fra tanti, Giovanni Bellini con le due Pietà prestate da Rimini e dai musei Vaticani, che pur partendo dalle stesse domande di Piero della Francesca sulla consistenza naturale della luce esemplificano una ricerca dall’esito contrapposto: l’umano – troppo umano – ricordava e ancora riporta dolorosamente al tempo che scorre.