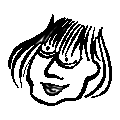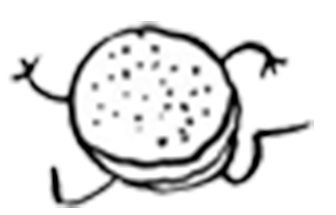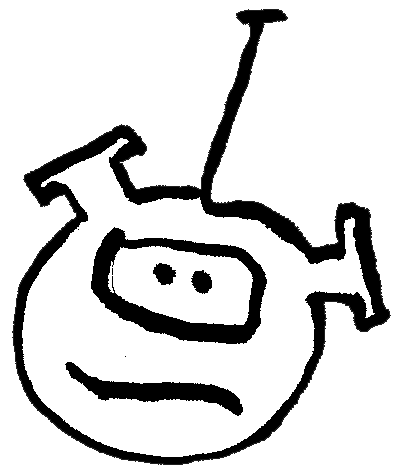Sulle prime potrebbe venire in mente l’incipit dell’Enrico V: «Sopperite alle nostre deficienze | con le risorse della vostra mente: | moltiplicate per mille ogni uomo, | e con l’aiuto della fantasia | createvi un poderoso esercito».
Sulle prime potrebbe venire in mente l’incipit dell’Enrico V: «Sopperite alle nostre deficienze | con le risorse della vostra mente: | moltiplicate per mille ogni uomo, | e con l’aiuto della fantasia | createvi un poderoso esercito».
Un inno alla fantasia, scritto da Shakespeare per fare di necessità virtù. Le risorse del Globe e della compagnia del Bardo non permettevano certo la rappresentazione di una battaglia campale: gli spettatori, within this wooden O, avrebbero dovuto immaginarsi da soli i cavalli, i rumori, gli odori, le moltitudini sui campi di battaglia, e riempire il palcoscenico dei loro fantasmi.
Così, se è permessa una piccola digressione, qualcosa di simile avviene anche per l’ultima produzione della compagnia bolognese Kepler-452, F. Perdere le cose. Nicola Borghesi e Paola Aiello contano sulla fantasia della platea per ricreare sulla scena una presenza – quella del protagonista della loro storia – negata per ragioni legal-burocratiche. F., un vagabondo mezzo matto, non può concretamente varcare il confine del teatro (ecco un altro confine a cui non avevamo ancora pensato, in questi tempi di deleteria riscoperta dei confini): saranno gli spettatori ad interpretarlo, a riempire di senso un’assenza scenica, in questo spettacolo complesso e maturo.
Ma torniamo alla produzione dell’Accademia degli Artefatti, I, Banquo. Anche in questo caso il richiamo all’immaginazione è un leitmotiv che tornerà per tutta la durata dello spettacolo. Ma il testo di Tim Crouch, scritto all’inizio del Duemila, non lo fa per faute de mieux: il richiamo all’immaginazione non è un succedaneo, ma un elemento costitutivo del testo.
L’immaginazione a cui è ossessivamente sollecitato il pubblico diventa una modalità della riflessione meta-teatrale, una riscoperta del gioco profondo del teatro e, al limite, una messa in discussione ironica delle sue regole. Enrico Campanati – abilissimo nel mantenere attento il pubblico e nell’interazione con lo spettatore – entra in scena in smoking bianco, bevendo una birra: è palese a tutti che non è Banquo, il celeberrimo personaggio del Macbeth. È Campanati, period.
Ma immaginiamo che lo sia. Immaginiamo che sia davvero l’amico fidato di Macbeth, una delle numerose pedine cadute sotto i suoi colpi per arrivare al trono che fu di Duncan. Immaginiamo che sia davvero il capostipite della progenie che, nel futuro, indosserà la corona del trono di Scozia. Immaginiamo che sia lui quel fantasma che comparirà durante la famosa scena del banchetto, spaventando a morte Macbeth e suscitando lo sdegno della snaturata Lady.
È innescato così il meccanismo ironico di questo spettacolo, nel quale tutti (attori e pubblico) sono perfettamente coscienti del gioco delle parti, tutti interrompono la sospensione della credulità, tutti sanno qual è il trucco; eppure tutti si prestano volentieri al gioco, e incitati da Campanati-Banquo (bianco e insanguinato, come bianco e insanguinato è il suo fantasma nel Macbeth) assumono le identità degli altri personaggi del dramma.
Durante la rappresentazione della sua morte, ridiamo perché l’attore è indeciso su come posizionarsi sul palco per essere visto meglio; ridiamo per le allusioni ironiche sull’inettitudine di suo figlio Fléance (il totem barbuto Matteo Selis); ridiamo per l’esagerazione comica del sangue in scena, antifrasi evidente: l’unico elemento realistico presente in scena è anche quello meno necessario – nonché efficace parodia del celebre monologo di Lady Macbeth («All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand (…) What’s done cannot be undone»).
Non ho potuto fare a meno di pensare, durante questo delizioso momento splatter, all’uso simile che è stato fatto dell’elemento corporeo dai Monty Python, in The Meaning of Life (chi l’ha visto ricorderà la scena della donazione coatta degli organi); così come c’è qualcosa di montypythoniano anche nella scelta dei costumi e della scenografia, molto eighties, che sa di prima serata televisiva thatcheriana.
Ma l’intuizione del regista Fabrizio Arcuri nel proporre questo testo di Crouch è stata quella di intercettare il suo senso profondo, e di non fermarsi all’esercizio meta-teatrale, di non paludare nell’ironia. Perché il teatro è un gioco, sì, ma come tutti i giochi è serissimo. Succede così che, dietro alle risate, un pensiero cominci a prendere forma, alla fine dello spettacolo. Succede che venga svelato, attraverso un gioco intellettuale, il vero senso di quell’“io”, presente fin nel titolo dello spettacolo e che, notare bene, è un io sempre presente in ogni nostra rappresentazione pubblica. Quell’io è un prodotto dell’immaginazione collettiva.
Quell’io pubblico, quella proiezione della persona parallela e potenziale per ognuno di noi, non ha un’identità già stabilita, ma è il risultato di uno sguardo collettivo, il prodotto – non siamo lontani dallo strutturalismo – di mille altri sguardi e mille interpretazioni. La miracolosa fragilità della finzione teatrale, appesa alla volubile immaginazione del pubblico, è specchio della finzione che informa le nostre vite.
I, Banquo
di Tim Crouch
traduzione Pieraldo Girotto
regìa Fabrizio Arcuri
in scena Enrico Campanati e Matteo Selis
produzione Fondazione Luzzati, Teatro della Tosse
Visto al teatro Rasi il 9 marzo 2019