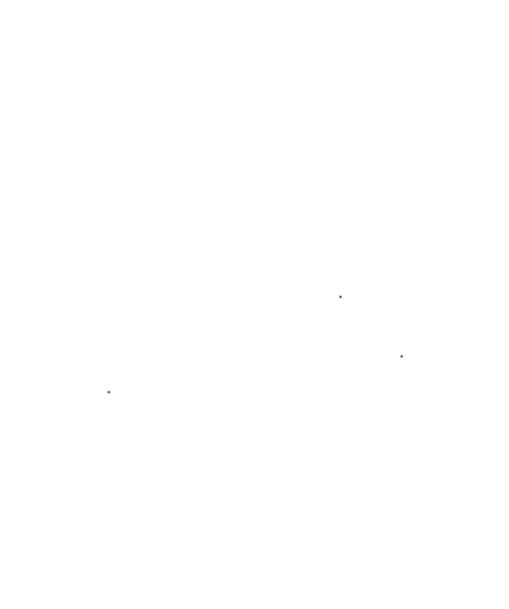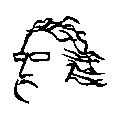Le perturbanti e spaesate creazioni iperrealiste di Feuerman, De Andrea, Sijan, Hanson, Mueck
Capri, agosto 2017: non è più l’isola degli anni ruggenti di Sofia Loren, Clark Gable, Aristotele Onassis, Rita Hayworth e Jacqueline Kennedy ma ormai quella di calciatori e veline. A tirar su il livello del jet set locale contribuiscono fortunatamente la cantante statunitense Katy Perry e Tiffany Trump con Marla Maples, figlia e moglie del presidente americano. Ad accogliere i “vip” prezzi stellari, masse di turisti in torpedone e in vari angoli della cittadina di Capri un allestimento di alcune sculture monumentali della statunitense Carole Feuerman (1945). Giunta al successo già in età matura agli inizi del nuovo millennio grazie ad una serie di mostre negli Stati Uniti e alle Biennali di Venezia del 2007 e del 2013, oggi non si contano più le presentazioni del suo lavoro in tutto il mondo. A testimoniare la visibilità delle sculture di Feuerman – eseguite in resina, marmo o bronzo, in scala monumentale, naturale o ridimensionata, a figura intera o parziale – è la loro presenza in collezioni di prestigio come quelle dell’imperatore del Giappone, di Henry Kissinger, Bill e Hillary Clinton. La serie che ha contribuito alla fama di Feuerman rappresenta nuotatrici e bagnanti, raffigurate ad occhi chiusi mentre emergono dall’acqua o riposano su elementi galleggianti, tutte sorridenti e dall’aspetto sereno, il volto racchiuso in sé in uno stato quasi nirvanico. Non ci sono tracce di sforzo o di pensieri disturbanti nei loro visi dall’ovale perfetto, i capelli raccolti in cuffie da bagno. Niente stona: non il realismo convincente dei pori o delle leggerissime imperfezioni della pelle o delle gocce di acqua che sembrano scorrere su visi e spalle.
Carole Feuerman
La formula ha contribuito alla devozione del grande pubblico attratto da questo iperrealismo per nulla disturbante. In tutti i lavori regna una perfezione ideale dettata dalle pose, dalla bellezza delle protagoniste – prese da modelle reali – dalla muscolatura atletica delle rare figure maschili, create sulla base di fotomodelli. La bellezza di un mondo senza sforzo o pensiero non si appesantisce neanche per la scelta dei materiali: quando la scultrice non usa la resina colorata a totale imitazione della realtà ma il bronzo o il marmo, comunque lo scopo raggiunto è di una perfezione studiata al millesimo. Anche le opere fotografiche tratte dalle sculture possiedono l’identico glamour, ottenuto grazie a vernici luccicanti o patinate.
In una intervista Feuerman ha spiegato il nodo della sua ossessione per le bagnanti – di cui sottolinea il profondo sentimento interiore – nata all’origine della sua carriera su una spiaggia, alla vista di una donna bella, potente, forte, che esce dall’acqua: è il momento in cui la scultrice si chiede che fare della propria vita, decidendo in quel momento per la strada dell’arte. La serie delle bagnanti iniziata ancora negli anni ‘80 – a cui hanno fatto seguito le serie delle figure femminili che fanno esercizi ginnici e quella dei tuffatori – possiedono un fascino indubitabile determinato dalla verosimiglianza e forte idealizzazione delle figure, un processo già impiegato nella storia dell’arte ad esempio da Degas e Renoir. La risultante è un’arte piacevole, tecnicamente affascinante, ma volutamente lontana, anzi lontanissima dal tempo che le ha viste nascere.
Non molto distante da questa visione estetizzante è il lavoro di John De Andrea (1941) uno scultore statunitense che fin dagli anni ‘70 si specializza nella realizzazione di figure ad altezza naturale in bronzo policromo, polivinile o fibra di vetro, con capelli naturali ad imitazione perfetta della realtà. Raggiunta la fama già negli anni ‘70 – in tempi in cui la critica e il mercato incoraggiano maggiormente la creatività maschile – le sue figure femminili, in particolare i nudi, si allineano alla bellezza idealizzata delle opere della Feuerman.
John De Andrea: Joan, 1990/ Nude with a Black Drape, 2014
La differenza più sensibile sta nello sguardo: a differenza dalla collega statunitense, le donne di De Andrea sono fortemente oggettivizzate, non sono protagoniste dei loro atti o pose ma semplicemente si sottopongono alla visione attiva dello spettatore. La sensibilità è in questo caso tutta maschile ed è difficile intravedere in queste belle figure quella “fragilità” umana che qualche critico ha voluto leggervi. Pur con questa sensibile differenza, come nel caso della Feuerman anche le sculture di De Andrea appartengono ad un tempo separato dalla vita che scorre e dai suoi innumerevoli incidenti che la compongono.
Per capire questo distacco basta confrontare questo tipo di lavori con quelli di Duane Hanson (1925-1996) padre statunitense dell’Iperrealismo assieme a George Segal.
Duane Hanson
Le sue sculture realizzate in poliestere, fibra di vetro e bronzo, sono reali non solo nei particolari ma anche nelle pose talmente simili alla realtà da poter ingannare la percezione, non fosse per la strana immobilità che le caratterizza. Vicini alla corrente della Pop Art, gli uomini e le donne scolpiti da Hanson e immortalati nelle improbabili mise della gente comune negli States raccontano degli atti banali della vita quotidiana, del lavoro o dei gesti consumistici che vengono reiterati quotidianamente. A sorprendere non è solo la perfezione tecnica dei dettagli ma la naturalezza delle persone, appannate solo da una solitudine e povertà interiori che carica il lavoro di una critica sociale palpabile. Anche nel caso delle opere più datate, in cui gli abiti anacronistici segnano la distanza di tempo, le sculture raccontano di uno stato permanente dell’umanità occidentale di cui tutti sono portatori virali e inconsapevoli.
Su questa stessa onda di pensiero si incanala l’opera di Marc Sijan (1946), un altro artista statunitense di origine serba, che solo negli ultimi anni è apparso sulla scena internazionale dopo un lungo curriculum espositivo negli Usa.
Marc Sijan
Come nelle opere di Hanson di cui è stato allievo, gli attori principali sono persone comuni raffigurate in pose quotidiane o intime, talvolta anticonvenzionali, ma sempre in modo da ostentare il corpo, il processo di invecchiamento e la sua fragilità. Sijan – che dichiara di voler “raggelare le emozioni piuttosto che suggerire la vita” – spesso riesce in questo intento e, nei casi in cui volutamente fallisce, torna ad illustrare un’umanità solitaria, leggermente squallida, in cui nessuno vorrebbe identificarsi.
Erede di questa tradizione tradizionalmente statunitense è Ron Mueck (1958), australiano trasferito a Londra da dove ha cominciato a farsi conoscere a livello internazionale fin dalla metà degli anni ‘90. Le sue figure – sottodimensionate o al contrario monumentali – vengono realizzate attraverso un lungo e minuzioso lavoro che spesso impegna l’artista un intero anno per l’esecuzione di ogni singola opera. Ciò che è veramente potente di questi lavori e che marcano la loro personalità è la forte concentrazione sulle emozioni, sia delle figure che degli spettatori. Talvolta è il forte sovradimensionamento dell’opera – come nel caso del viso furente di un uomo, del corpo di un bambino appena nato, di un adolescente seduto in posizione di difesa, di un viso di donna preoccupata che esce dal lenzuolo o di un pollo appeso come in macelleria – a inibire, a far scattare emozioni della memoria più lontana, a suscitare una repulsione amplificata. Nel caso delle figure più piccole della scala reale, l’artista crea equivoci mediante il posizionamento del lavoro, come nel caso dell’uomo steso su un materissino posto a parete, paradossalmente simile ad un Cristo in croce; in altri casi, Mueck indirizza l’attenzione su emozioni sottili, quasi minimali, esaltate grazie ad un’esplorazione per forza ravvicinata. A questa stretta distanza è possibile condividere l’impaccio che passa fra due adolescenti abbracciati, la preoccupazione che esprime il viso tirato di una madre col figlio al collo e due borse di plastica nelle mani. Non c’è critica o descrizione sociale nei lavori di Mueck quanto indagine emozionale di ciò che in un punto della nostra vita siamo stati, di ciò che in un momento possibile o futuro potremmo essere o saremo.
Ron Mueck