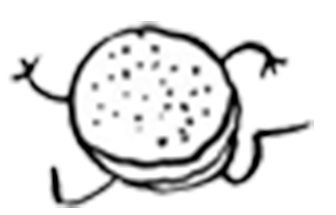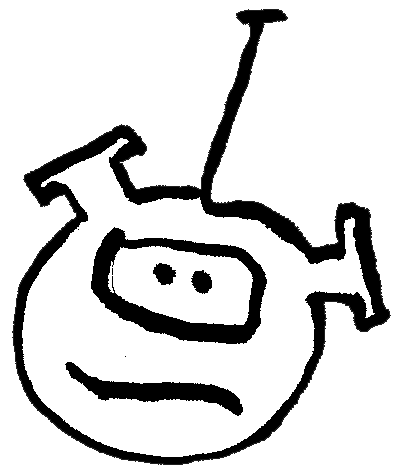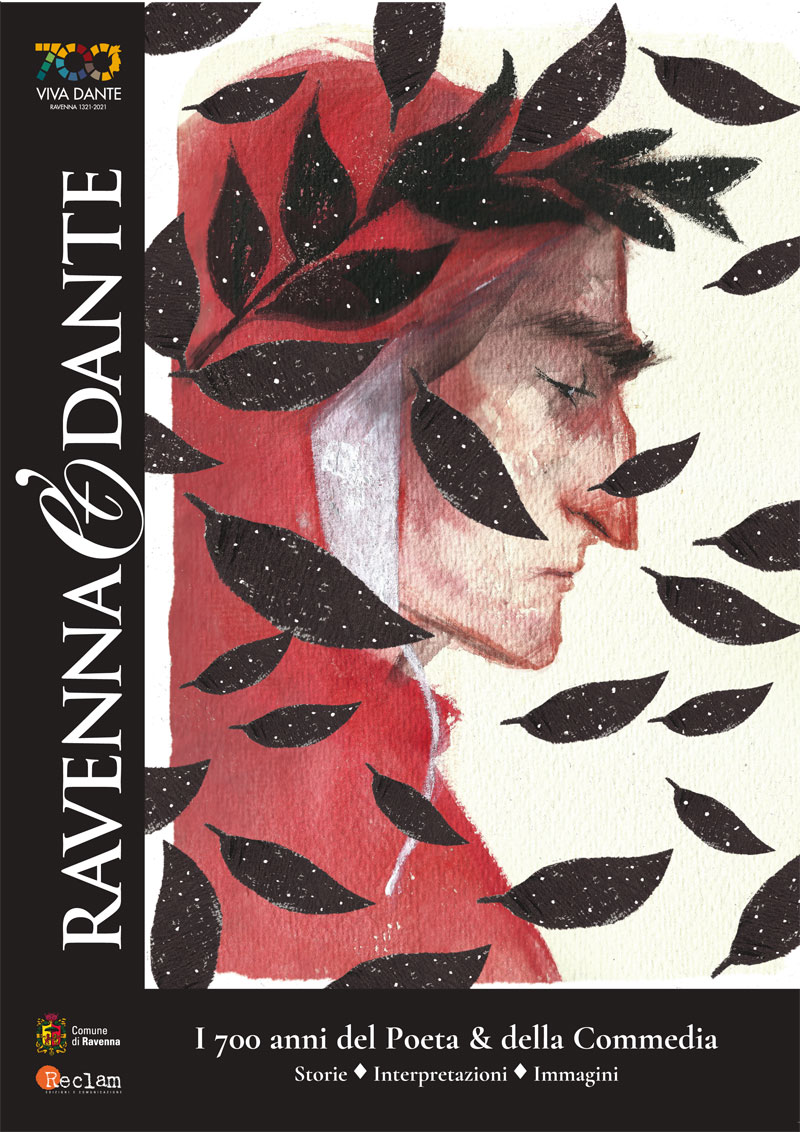Se vi piace leggere articoli e libri che parlano in qualche misura di “cultura pop” vi sarà capitato diverse volte, nell’ultimo lustro, di imbattervi nell’espressione . Come può intuirsi è un’espressione che viene dal mondo anglosassone, come del resto quasi tutta la “cultura pop”; se ne parla quando ci si accorge che una cultura dominante e oppressiva si è appropriata di elementi e simbologie che appartengono a culture minoritarie e oppresse.
A grandissime linee è quello che succede quando un trentacinquenne europeo di buona famiglia si presenta al bar in canottiera con il corpo imbrattato di disegni tradizionali di qualche tribù aborigena: la nostra cultura ha deciso che quei disegni sono fighi e se li tatua addosso senza pensare troppo a quale sia il significato originale di quei segni. Ovviamente ci sono tanti altri motivi, alcuni perfino sensati, per cui le persone si fanno tatuaggi tribali pur non appartenendo ad alcuna tribù; ma è un fatto che le condizioni di partenza di quella simbologia, quelle per cui si è sviluppata e ha assunto un senso, in questo contesto non possono esistere. Altrettanto ovviamente, l’assenza di queste condizioni non costituisce un problema per i 35enni europei. Loro sono semplicemente andati da un tatuatore e hanno contrattato un tatuaggio, attenendosi a delle prassi di ordine commerciale, umano ed etico che si sono sviluppate lungo decenni di studio ossessivo, duro mestiere, lotte sociali e shottini di vodka. In giro ci sono tatuatori molto rigorosi e via di questo passo. Ma rimane il punto alla base: quei simboli avevano un significato che è stato spazzato via dal fatto che, semplicemente, a un certo punto siamo andati lì e ce li siamo presi, e questo è il processo di appropriazione culturale, appunto.
Se ne parlò con una certa insistenza nel 2013 per via di un’esibizione di Miley Cyrus ai VMA. Ai tempi ci fu una discussione molto lunga e accurata, per quanto non troppo interessante: perché proprio Miley Cyrus, una popstar che fino all’anno precedente era stata l’incarnazione dei valori dell’America bianca e cattolica, dovrebbe arrogarsi il compito di “sdoganare” il twerking di fronte al pubblico di Mtv?
Il discorso sull’appropriazione culturale ha almeno un lato interessante: la negazione. Tutti sanno che avviene e nessuno osa difenderla per quello che è, ma di fronte ai casi specifici si tende a dare addosso alle minoranze e chieder loro di non rompere il cazzo. Negli anni ’80 le cose erano diverse, c’era ancora una certa arroganza trumpiana che ti portava a dire fanculo le minoranze, io mi son fatto un teepee in salotto coi foulard di Moschino. Oggi il processo di vessazione delle minoranze segue delle dinamiche più sottili, la cui premessa di solito è che come ti permetti? nessuno qui sta vessando nessuno.
È una sorta di fascismo sorridente e ben vestito di un livello più intellettuale, quello che ad esempio ci porta a dire che non ce l’abbiamo con tutti i rumeni ma solo con quelli che violano la legge, e per sicurezza dovremmo censire i rumeni sul territorio italiano. Ma qui il protofascismo è intuibile; quando si discute il twerking di Miley o i tatuaggi tribali, invece, non ci si chiede quasi mai se l’appropriazione culturale di queste due cose sia giusta o sbagliata. Ci si chiede, piuttosto, se i tatuaggi e Miley possano essere davvero considerati casi di appropriazione culturale. Spesso, tra l’altro, la qualità delle performance influisce: perché un buon tatuaggio tribale fatto da un tedesco dovrebbe avere meno senso di un brutto tatuaggio tribale fatto da un maori? Il sottotesto inconscio è tremendo, e quindi fascinoso: se l’appropriazione culturale è ben fatta, non è più appropriazione culturale.
Io purtroppo non mi posso lamentare di questa cosa, perché sono parte della cultura dominante. È frustrante. Ho cercato per tutta la vita di essere parte di una minoranza, e non ce l’ho mai fatta. Comprendo da carnivoro le ragioni del movimento vegan, sono un maschio etero a favore dei diritti delle donne e degli omosessuali, inorridisco di fronte al trattamento dei migranti pur non avendo mai abitato fuori dalla Romagna. Per un certo periodo amavo considerarmi un outcast per via dei miei consumi culturali: libri sconci, fumetti underground, dischi punk e film d’autore. Ho passato quasi tutta l’adolescenza (l’età che va dai 14 ai 37 anni, ricordiamolo) a indossare le insegne del mio non-allineamento e a pensare che questo mi abbia chiuso un sacco di porte; all’atto pratico, però, l’unico posto dove non mi facevano entrare erano certe discoteche per tamarri che negli anni ’90 si erano fissate di rimbalzare quelli con le scarpe da tennis ai piedi; in tutti gli altri posti mi hanno accolto a braccia aperte e hanno accettato i miei soldi senza problemi. Ma in qualche modo per me la parola punk ha avuto per lungo tempo una valenza sacrale, senza pari: fino a pochissimo tempo fa, quando qualcuno definiva “punk” una cosa qualsiasi, ero in qualche modo interessato ad ascoltare le sue argomentazioni. È un atteggiamento infantile, ovviamente, per diversi motivi.
Il primo è che non c’è una definizione soddisfacente di “punk” a cui ci si possa rifare per decidere se una certa cosa è punk o no.
Il secondo è che una buona metà delle cose che la gente definisce o definiva “punk” mi ha sempre fatto schifo, a partire da molti gruppi storici.
Il terzo è che sperimento ogni giorno sulla mia pelle il modo in cui l’aggettivo “punk” viene usato senza problemi per definire non solo musicisti di dubbio talento ma anche e soprattutto capitalisti rampanti, stilisti di alta moda e inqualificabili commentatori televisivi.
Il quarto è il più importante: se un 30/35enne borghese e liberale può pensare di usare la parola “punk” con cognizione di causa, è ragionevole concludere che la parola “punk” non abbia più alcun significato. Eppure, in quanto appartenente autocertificato della comunità “punk” (che poi non frequento ma vabbè), ho passato tanto tempo ad infuriarmi di fronte a un uso improprio della parola PUNK.
Perché? Credo che fosse il bisogno di sentirmi parte di un gruppo di reietti.

Poi fortunatamente ho smesso. Tanto per dire: quando è uscito PUNK, il nuovo disco di Gazzelle, l’ho perfino ascoltato a cuor leggero. Gazzelle è un cantautore legato a quell’epica/estetica/etica itpop democristiana da sei-sei e mezzo, che a tanta gente piace un casino e a tanta altra sta sui coglioni a pelle; la canzone che dà il titolo al disco parla di farsi una storia con una ragazza alternativa, tutto come al solito insomma.
Ho assistito a una sorta di mobilitazione da parte di miei coetanei per una sorta di moratoria dell’utilizzo della parola “punk” nell’itpop, con commenti che si orientavano su “è ora di smettere di sopportare tutto questo schifo, prendere i fucili e scendere in piazza”. Guardi a queste cose scritte da quarantenni con una comprensione spensierata tipica di quelli che alle ultime politiche avrebbero potuto votare la lista Bonino; voglio dire, non è poetico che la cosiddetta nostalgia del futuro si applichi anche al no future?